
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 40, Aprile 2006 |
Sommario |
|
|
Vino Biologico |
|
Anche questo mese attingiamo l'argomento dell'editoriale dalla nostra rubrica dei sondaggi che - nonostante sia stata inserita solo da qualche mese - sta riscuotendo molto successo. Come dicevamo il mese scorso, l'opinione dei lettori ci dà l'opportunità di riflettere sui gusti e tendenze degli enoappassionati. Ci ha molto colpito come stanno votando i lettori di DiWineTaste a proposito di quanto, nella scelta di un vino, sia importante che sia “biologico”. La maggior parte dei votanti ha dichiarato di essere “indifferenti” e “poco” interessati al “vino biologico”. Ci chiediamo, comunque, quanto la comunicazione fatta su questo tipo di prodotto sia responsabile di questo risultato, innanzitutto in generale e poi in relazione alla categoria vino. La comunicazione sul vino biologico è stata svolta in modo poco efficace e raramente si è cercato di spiegare con chiarezza cosa fosse un alimento biologico. E ciò vale ancora di più in relazione al mondo del vino. Gli scandali alimentari, quali ad esempio “mucca pazza”, hanno favorito l'attenzione da parte del consumatore verso i prodotti “biologici”. Se in alto alla classifica della tipologia di prodotto più acquistata si colloca la categoria dei “freschi”, come ad esempio ortofrutta e latticini, il vino si trova agli ultimi posti. Ma innanzitutto, cos'è un prodotto da agricoltura biologica? Il metodo di produzione biologico è rispettoso dell'ambiente ed esclude l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (fitofarmaci e concimi chimici). Tutte le fasi produttive sono controllate e certificate da appositi organismi accreditati a livello europeo. Nel caso del vino, la dicitura corretta è “vino da agricoltura biologica”. In Italia, la viticoltura biologica è praticata su circa 50 mila ettari e costituisce poco più del 5% della viticoltura convenzionale. Un vino “biologico” si differenzia da uno convenzionale per diversi elementi: la forma di anidride solforosa ammessa (ad esempio solforosa gassosa in soluzione liquida o sali di metabisolfito) e la quantità totale - tra 10 e 25 ppm per l'anidride solforosa libera - acidi ammessi (ad esempio citrico, tartarico e ascorbico). I livelli di solforosa ammessi in un vino “biologico” variano a seconda dell'ente, scelto dal produttore, il quale controlla che tutti i parametri previsti nel disciplinare siano rispettati. Oltre al fattore comunicazione che il vino “biologico” sconta, occorre considerare l'attuale idea che i consumatori hanno del vino “biologico”. Purtroppo, tanti anni fa, la qualità della maggioranza dei vini “biologici” in commercio non era elevata e la nostra sensazione è quella che il vino prodotto secondo questi criteri non si sia ancora scrollato di dosso la reputazione di vino di “pessima qualità”. Oggi non è più così, almeno nella maggioranza dei casi. Si trovano in commercio ottimi vini biologici, dal punto di vista qualitativo e organolettico. Molti ritengono che i produttori di questa tipologia di vini non seguano i principi del metodo dell'agricoltura biologica. Per contro, molti produttori di vini biologici, nel commercializzare i loro prodotti, mettono in secondo piano il fatto che derivino da agricoltura biologica, proprio come se fosse un elemento che possa scoraggiare il responsabile acquisti della grande distribuzione, l'enotecario o lo stesso consumatore ad acquistare quel prodotto. I canali commerciali utilizzati dalle aziende vitivinicole biologiche italiane, sono prevalentemente rivolti all'esportazione, dove viene venduto il 65% della produzione, il restante viene distribuito in Italia tramite la ristorazione. L'esportazione riguarda prevalentemente i Paesi appartenenti all'Unione Europea (la Germania in modo particolare, dove vivono molti consumatori di biologico), la Svizzera e di recente è iniziata la scalata al mercato Nord americano. Se il problema della comunicazione poco efficace sui prodotti biologici - vino incluso - tiene lontani i consumatori da questi ultimi, altro elemento da considerare è il prezzo. In genere, i prodotti biologici si trovano sul mercato a un prezzo superiore del 20-30% rispetto a quello dei prodotti convenzionali. E nel momento economico-finanziario che stiamo attraversando, anche la spesa per l'acquisto del vino è stata ridimensionata. Purtroppo l'incidenza maggiore dei costi di produzione di chi produce biologico si ripercuote sul consumatore finale. Spesso, comunque, molti vini biologici costano meno rispetto a tanti vini convenzionali. Il vino biologico rimane, comunque, allo stato attuale, un prodotto di super-nicchia. I consumatori di questo tipo di vini sono in genere coloro che si recano a fare la spesa in catene specializzate nel biologico e che in genere acquistano prodotti alimentari che rispettano questi principi o derivanti da agricoltura biodinamica. Quest'ultima non è la stessa cosa del biologico. L'agricoltura biodinamica si ispira alle teorie dello studioso austriaco Rudolf Steiner, che teorizzò sulla coltivazione della terra, rispettando i ritmi e i cicli della natura. Anche in questo caso esistono enti certificatori del “biodinamico”, diversi da chi certifica il “biologico”. Esistono anche vini biodinamici, cioè realizzati con uve coltivate secondo i principi della biodinamica, che si rifanno ai principi di Steiner. Osservando più dettagliatamente cosa sia avvenuto nel comparto dei vini biologici va constatato che, tranne alcuni significativi esempi di nascita di strutture commerciali parallele (soprattutto in Germania e Svizzera), che si sono occupate in maniera esclusiva di promuovere e vendere vini biologici, oggi il vino biologico di qualità si inserisce sempre più facilmente nel mercato tradizionale, ottenendo successi significativi. La produzione di uve con il metodo dell'agricoltura biologica si sta sviluppando rapidamente anche nei nuovi paesi emergenti (Europa orientale, Australia, Nuova Zelanda, Cile e Argentina). Sul mercato italiano e nel resto del mondo sono già approdati i vini di questi paesi, anche quelli biologici, a prezzi sempre più competitivi. Nello scenario economico-finanziario mondiale attuale, le aziende che hanno scelto la produzione “biologica” incontrano notevoli difficoltà nella vendita dei loro vini. In Europa, la stessa Germania - che costituiva per certi versi lo sbocco di mercato naturale per i vini biologici - grazie alla diffusa cultura per questo tipo di prodotti e del biodinamico, ha notevolmente diminuito le importazioni di vino biologico dall'Italia. Così, molte aziende italiane di vino biologico si sono trovate in serie difficoltà, perché non avevano fatto i conti con la crisi economica che la Germania sta attraversando. Ci auguriamo che questi produttori, dopo tanti sforzi, non mollino e continuino a lavorare sulla qualità, sulla comunicazione relativa al prodotto e che non riconvertano i vigneti alla viticoltura convenzionale. Se la viticoltura biologica è ancora un settore in espansione o stia segnando il passo, è attualmente argomento di frequente quanto sterile discussione. Quello che si può affermare è che sono uscite dal sistema di controllo quelle aziende che avevano puntato più sul contributo che sulla messa a punto di sistemi aziendali che portassero a prodotti per il mercato del biologico. In quasi tutte le regioni, ma soprattutto in quelle a minore vocazione vitivinicola, diverse aziende prive di cantina, che conferivano uve a cantine sociali o le vendevano in modo autonomo, negli ultimi otto anni, entrarono nel sistema di controllo grazie ai contributi del Regolamento CE 2078 prima e del piano di sviluppo rurale poi, senza però valorizzare le proprie produzioni che continuavano a essere vinificate assieme a quelle convenzionali. La fine del regime di aiuti ha quindi indotto queste aziende a recedere dall'impegno, visto che non comportava più alcun beneficio. Quello che è accaduto nel mondo del vino biologico dovrebbe essere d'insegnamento a molti, nella speranza che serva di lezione a tutti, sia ai produttori, sia ai consumatori.
|
||||
La Posta dei Lettori |
|
In questa rubrica vengono pubblicate le lettere dei lettori. Se avete commenti
o domande da fare, esprimere le vostre opinioni, inviate le vostre lettere
alla redazione oppure
utilizzare l'apposito modulo disponibile nel
nostro sito.
|
| Sempre più spesso sento parlare degli effetti negativi dell'anidride solforosa sull'organismo. Se è vero che è nociva, perché si usa nella produzione di vino? |
| Giorgio Lanari -- Spilamberto, Modena (Italia) |
| L'uso dell'anidride solforosa in enologia - un gas non infiammabile solubile in acqua - è dovuto alle sue proprietà stabilizzanti e conservanti. Ricordando che la tolleranza agli effetti dell'anidride solforosa varia a secondo dei soggetti, il suo uso è tuttavia regolato da apposite leggi che ne stabiliscono le quantità massime consentite. L'uso di anidride solforosa in enologia e nella viticoltura prende il nome di solfitazione. L'anidride solforosa può essere impiegata in molte fasi della produzione di vino. Prima della vendemmia, si può provvedere alla solfitazione delle viti con lo scopo di prevenire lo sviluppo di muffe e batteri. L'anidride solforosa si aggiunge anche al mosto con lo scopo di stabilizzarlo e si aggiunge al vino con lo scopo di prevenire ossidazioni e altre alterazioni chimiche. |
| Perché la fillossera distrugge le viti europee mentre le specie americane sono immuni a questo parassita? |
| Jacques Barthel -- Mérignac, Bordeaux (Francia) |
| La fillossera è un parassita che attacca le radici della vite, succhiando i nutrienti e provocando un progressivo indebolimento della pianta con conseguente riduzione dei frutti. Gli effetti della fillossera non alterano il gusto del vino, tuttavia con il tempo è necessario provvedere all'impianto di nuove viti. L'origine della fillossera è la zona orientale degli Stati Uniti d'America, dove crescono varietà di viti resistenti a questo parassita. Si ritiene che, nel corso del tempo, queste viti abbiano sviluppato un apparato radicale più spesso e forte tale da rendere vani gli attacchi della fillossera. L'apparato radicale più sottile della Vitis Vinifera - la specie europea - consente invece alla fillossera di aggredire la pianta privandola delle preziose sostanze nutrienti. Per questo motivo le giovani pianticelle di Vitis Vinifera - dette barbatelle - sono innestate su radici di specie americane resistenti alla fillossera, evitando così i suoi devastanti effetti. |
Napa ValleyNon solo la più celebre area vitivinicola della California, ma anche degli Stati Uniti d'America, la Napa Valley è celebre per i suoi vini da uve internazionali e dal locale Zinfandel |
|
La Napa Valley è la zona vitivinicola della California più famosa e certamente anche di tutti gli Stati Uniti d'America. La fama di quest'area è tale che spesso la Napa Valley è considerata come sinonimo di vino Americano, tanto da mettere in ombra anche altre interessanti aree, non solo quelle della California. Fortemente basata sulla produzione vinicola dei più celebri vitigni “internazionali”, la Napa Valley è apprezzata nel mondo per lo stile altrettanto “internazionale” dei suoi vini, dai bianchi ai rossi, e perfino a vini spumanti prodotti con il sistema del metodo classico. Forse è proprio la mancanza di tradizioni antiche - esattamente come in altre zone vinicole di storia recente - che consente alla Napa Valley di adottare le più avanzate tecnologie e metodi di produzione, in questo supportata anche dal sistema di qualità americano - l'AVA (American Viticultural Area) - che lascia più spazio all'intraprendenza delle cantine piuttosto che a principi tradizionali. Tuttavia, in questo scenario “internazionale” e moderno, trova spazio anche un'uva antica e che oramai è considerata come autoctona degli Stati Uniti d'America: lo Zinfandel. Nonostante non sia ancora molto chiaro come e quando lo Zinfandel sia arrivato negli Stati Uniti d'America, si sono comunque formulate diverse supposizioni, fino anche a ritenere che esistano dei legami varietali con le uve Primitivo - tipica della Puglia - e il Plavac Mali, tipica della Dalmazia. Due uve analoghe le cui origini si fanno risalire allo Zagarese, un uva dei Balcani. Quello che è possibile stabilire con certezza è che lo Zinfandel è stato comunque introdotto dall'Europa e che era già nota negli Stati Uniti d'America già a partire dal diciannovesimo secolo e con la quale, già a quei tempi, si produceva vino. Qualunque siano l'origine e le cause che hanno portato quest'uva dall'altra parte dell'oceano Atlantico, oggi lo Zinfandel è considerato un'uva autoctona degli Stati Uniti d'America.
La storia della California - dal punto di vista vitivinicolo - inizia molto prima del diciannovesimo secolo. Furono alcuni missionari francescani a introdurre - dopo la metà del 1700 - l'uva nelle terre della California. Dapprima fu introdotta l'uva mission, seguita da altre varietà di specie europee che, all'insaputa dei viticoltori della costa orientale, riuscì per la prima volta in terra d'America a produrre frutti e quindi vino. La storia della viticoltura e dell'enologia nella zona della Napa Valley, iniziò più tardi, esattamente nel 1838, quando George C. Yount piantò il suo primo vigneto con l'uva Mission. I primi risultati si concretizzarono nel 1840, quando dalle uve prodotte in questi vigneti si produssero i primi vini. La produzione di George C. Yount era destinata per uso personale e dovranno passare poco più di venti anni per vedere la nascita delle prime cantine commerciali. Nel 1861 fu infatti fondata la prima cantina commerciale della Napa Valley per opera di Charles Krug, seguita nel 1862 da Schramsberg, nel 1876 Beringer, Inglenook nel 1879 e Beaulieu Vineyards nel 1900. Lo sviluppo dell'enologia nella Napa Valley fu - a quei tempi - piuttosto rapido e concreto: nel corso di appena venti anni, si potevano contare in quest'area più di 160 aziende dedite alla coltivazione della vite e alla produzione del vino. La qualità dei vini dell'epoca non era certamente comparabile con quelli che si producono oggi nella Napa Valley, tuttavia la produzione vinicola cominciava ad assumere dimensioni importanti. La forte espansione fu bloccata negli anni 1880 - esattamente come in Europa - con l'arrivo della fillossera, che iniziò a devastare i vigneti della Napa Valley. Fu così annullato il paziente lavoro di selezione operato dai viticoltori della Napa Valley svolto sulle potenzialità delle varietà europee nelle diverse aree. La fillossera non fu comunque l'unico fattore che segnò un brusco arresto della viticoltura e della produzione vinicola nella Napa Valley. Quando si notarono i primi segni di ripresa, un altro determinante evento stava per condizionare lo sviluppo dell'enologia, non solo della Napa Valley, ma di tutti gli Stati Uniti d'America. Questa volta la responsabilità non fu di eventi naturali, ma per intervento dell'uomo e delle sue leggi. Dal 1920 e fino al 1933, la viticoltura e la produzione di vino, così come di qualunque altra bevanda alcolica, fu severamente limitata e ridotta dall'istituzione del proibizionismo, che vietava la produzione, il trasporto e la vendita di qualunque bevanda alcolica. Durante questo periodo, fu ammessa unicamente la produzione di vini sacramentali o comunque vini ai quali erano riconosciute proprietà terapeutiche. Il proibizionismo, che segnò la fine di centinaia di cantine, non segnò comunque il declino dei consumi - che di fatto in quel periodo aumentarono - lasciando campo libero alla produzione casalinga e clandestina. Non furono molte le cantine che sopravvissero alla fillossera prima e al proibizionismo dopo. Le poche che ci riuscirono, erano dedite alla produzione di vini sacramentali e alla vendita di uve a coloro che decidevano di produrre il vino in casa. Gli effetti di questi due eventi si faranno sentire per tutta la metà degli anni 1950, quando si contavano poco più di una dozzina di cantine in attività. Segni tangibili di ripresa si registrarono negli anni 1960, quando Joe Heitz fondò - nel 1961 - la “Heitz Wine Cellars”, nel 1966 la famiglia Davies riprese l'attività della Schramsberg, e nello stesso anno Robert Mondavi lasciò l'azienda di famiglia, la Charles Krug Winery, fondando la propria cantina. Negli anni successivi furono fondate molte cantine in tutta la Napa Valley, fino ad arrivare ai giorni nostri a circa 200 aziende che producono vino dalle uve provenienti dai vigneti coltivati in una superficie di oltre 13.700 ettari. Oggi la Napa Valley è considerata fra le aree vinicole più importanti del mondo, sia per qualità, sia per il suo modello enologico fortemente basato su criteri moderni e avanzati, in perfetto stile “internazionale”.
|
||||||||||||
|
La Napa Valley si trova in California, a nord-est di San Francisco, e la sua area di produzione vinicola è riconosciuta dal sistema di qualità Americano come Napa Valley AVA (American Viticultural Area, Areea Viticolturale Americana). Il sistema di qualità AVA è stato introdotto nel 1983 con lo scopo di identificare i vini americani, seguendo i modelli utilizzati in Europa, come per esempio il sistema francese della AOC (Appellation d'Origine Contrôlée, Appellazione d'origine controllata). A differenza della maggioranza dei sistemi di qualità in vigore nei paesi europei, i criteri che regolano il sistema AVA sono piuttosto permissivi. Mentre nei sistemi di qualità europei, come per esempio in quello francese, sono definiti criteri e parametri più rigorosi e precisi, come per esempio le varietà di uve ammesse in una determinata zona, la produzione massima per ettaro e il volume alcolico minimo dei vini, il sistema AVA si basa essenzialmente sulla definizione geografica delle aree viticolturali. In accordo al sistema di qualità americano, l'unico requisito per un vino che riporta nell'etichetta la menzione di una specifica AVA, è che almeno l'85% dell'uva provenga dall'area viticolturale riconosciuta. Il riconoscimento di una nuova area è determinato dalla proposta dei viticoltori. La decisione viene presa in accordo all'esistenza di specifiche caratteristiche dell'area, condizioni topografiche, tipo del suolo e - in certi casi - precedenti storici. In molti casi è previsto che all'interno di un'AVA siano definite altre aree viticolturali, come nel caso della Napa Valley. La stessa Napa Valley è riconosciuta come AVA, e al suo interno sono definite le seguenti aree viticolturali: Atlas Peak, Oak Knoll District of Napa Valley, Oakville, Rutherford, Chiles Valley, Spring Mountain District, Diamond Mountain District, St. Helena, Howell Mountain, Stag's Leap District, Mount Veeder, Wild Horse Valley e Yountville.
|
|
L'area viticolturale della Napa Valley coincide praticamente con il territorio della contea di Napa, l'unica parte esclusa dall'AVA è una piccola parte di territorio che si trova nella parte nord-est del lago Berryessa. La Napa Valley si trova a nord-est della città di San Francisco, a partire dalla punta meridionale della baia di San Paolo, che confina appunto con la baia di San Francisco. L'area meridionale della Napa Valley - in accordo alle regioni climatiche della California - appartiene alla regione I, più fresca, mentre la parte settentrionale appartiene alla regione III, più calda. Nella Napa Valley è inoltre definito parte del territorio dell'AVA Carneros - con la restante parte nell'area di Sonoma - i quali vini non riportano in etichetta la menzione Napa Valley AVA, contrariamente a tutte le altre sotto zone AVA definite nella contea che invece hanno l'obbligo di menzione. Con l'eccezione dello Zinfandel, la viticoltura della Napa Valley è interamente basata sulle varietà internazionali di origine francese. Fra le uve a bacca bianca, circa il 65% dei vigneti piantati nella zona sono coltivati con Chardonnay. Fra le altre uve bianche, si coltivano inoltre Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Riesling, Sémillon e Gewürztraminer. Il Cabernet Sauvignon è l'uva a bacca rossa più coltivata nella Napa Valley, per una quota che supera il 50%. Le altre uve a bacca rossa tipica della Napa Valley includono Pinot Nero, Merlot, Zinfandel, Cabernet Franc e Petite Sirah, un'uva che non ha legami con la più celebre Syrah tipica della Valle del Rodano in Francia. Si ritiene - anche se si nutrono dubbi su questa teoria - che il Petite Sirah sia in realtà l'uva Durif, un incrocio fra le uve Peloursin e Syrah, prodotto in Francia negli anni 1880 dal dottor Durif, oramai pressoché scomparsa dai vigneti francesi. Nonostante la Napa Valley sia l'area viticolturale più celebre della California, qui si produce solamente il 4% del vino di tutto lo stato. L'area è infatti piuttosto ridotta e copre - da nord a sud - una distanza di circa 50 chilometri, e un'ampiezza variabile fra 1,5 e 8 chilometri. Le eruzioni vulcaniche che si verificarono in tempi remoti, hanno lasciato alla Napa Valley una diversità di suoli, appartenenti a otto delle dodici classificazioni geologiche conosciute. Una diversità geologica come questa consente di ottenere vini totalmente diversi anche a distanza di pochi chilometri, anche a causa della notevole differenza climatica della valle, più fresca a sud, nei pressi della baia di San Paolo, e più calda a nord. Nonostante la ricchezza geologica e la diversità climatica possano fare credere che nella Napa Valley si ottengono ottimi risultati con qualunque uva, in realtà i migliori vini sono indubbiamente quelli prodotti con Cabernet Sauvignon, tipici per la loro potente struttura e complessità, anche se in molti casi, si aggiungono Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec. Fra le più importanti sotto zone AVA definite all'interno della Napa Valley si ricordano Atlas Peak, Stag's Leap District, Spring Mountain District, Mount Veeder, Howell Mountain, Rutherford e Oakville. L'area di Stag's Leap District - situata nella parte meridionale della Napa Valley - è caratterizzata dai suoi vigneti posti ai piedi delle colline rocciose e dai quali si producono i suoi famosi Cabernet Sauvignon. Altre aree celebri per i loro Cabernet Sauvignon sono Rutherford e Oakville. Fra i vini bianchi, lo Chardonnay è certamente la varietà più utilizzata e le migliori zone sono Mount Veeder, Spring Mountain e St. Helena. Altri vini interessanti sono prodotti con le uve Pinot Nero - in particolare nella zona meridionale, più fresca - e con lo Zinfandel, soprattutto nella aree più calde del nord. Definire uno stile della Napa Valley è piuttosto difficile poiché le diversità geologiche della zona e le differenze climatiche rappresentano fattori piuttosto variabili e con i quali ogni zona si differenzia, anche notevolmente, da tutte le altre.
|
Pinot Nero a ConfrontoLa grande uva rossa della Borgogna, capace di produrre vini di rara eleganza e classe, è la protagonista della degustazione comparativa di questo mese |
|
Signore e signori, benvenuti nel mondo dell'eleganza e della raffinatezza. Anche se questa presentazione potrebbe non essere condivisa da molti, è comunque certo che il Pinot Nero è un'uva capace di produrre vini che sanno fare parlare di sé, nel bene e nel male. Il Pinot Nero - la celebre uva rossa originaria della Borgogna, in Francia - ha il difetto di non essere capace di stare “nel mezzo” delle scelte dei consumatori: o si adora, oppure si rimane pressoché indifferenti. Eppure quest'uva, nelle sue migliori rappresentazioni, è capace di produrre vini di grande eleganza, classe e raffinatezza, forse come pochissime altre uve al mondo. Uva estremamente versatile e, soprattutto, difficile da coltivare, il Pinot Nero consente anche la creazione di interessanti vini bianchi - facendo attenzione a separare le bucce subito dopo la pigiatura - ed è presente nella quasi totalità degli spumanti metodo classico, a partire dal celebre Champagne. Le origini del Pinot Nero sono molto antiche - si ritiene che sia presente in Borgogna da oltre 2.000 anni - ed è il protagonista dei vini rossi della Côte d'Or, in particolare di quelli della Côte de Nuits. Uva difficile da coltivare e da vinificare, il Pinot Nero - nei migliori casi - riesce tuttavia a produrre vini eccezionali. Se è vero che i vini giovani prodotti con quest'uva tendono ad avere aromi “semplici” di frutti a bacca rossa - ciliegia, lampone, fragola e prugna su tutti - con il tempo acquisiscono qualità organolettiche molto complesse e piacevoli di cioccolato, selvaggina, prugna secca, tartufo e, talvolta, anche note di affumicato. Tuttavia, il Pinot Nero è un'uva che non concede molto quando è coltivata in aree con clima poco adatto o con criteri qualitativi discutibili. Questo è il fattore primario che lascia perplessi gli appassionati di vino e coloro che non amano quest'uva. La differenza fra i grandi Pinot Nero e quelli mediocri è infatti notevole e l'assaggio di un Pinot Nero di bassa qualità non è certo esaltante, anche per il fatto che i tipici trucchi di cantina utilizzati per rendere un vino migliore di quello che è, non aiutano molto.
|
|
Lo scopo della nostra degustazione comparativa è quello di comprendere le qualità organolettiche principali del Pinot Nero in funzione alle pratiche enologiche impiegate nella produzione dei tre vini. Il Pinot Nero è un'uva che predilige le aree a clima fresco e si adatta piuttosto male in quelle calde. Nonostante la patria del Pinot Nero sia la Borgogna, in particolare la Côte d'Or, quest'uva è coltivata anche in altre zone del mondo e - in condizioni climatiche opportune - riesce a dare buoni esempi di vini anche al di fuori dei confini della Francia. A causa delle sue particolari qualità organolettiche, la vinificazione del Pinot Nero difficilmente ricorre all'uso invasivo di barrique o di altri contenitori in legno. Nonostante la barrique e la botte siano spesso utilizzate nella vinificazione del Pinot Nero, la scelta più tipica, e più appropriata, è rappresentata dall'uso di legno non eccessivamente tostato, proprio con lo scopo di conservare l'identità e l'integrità delle sue qualità organolettiche.
I vini selezionati per la degustazione comparativa di questo mese provengono da tre diverse zone dell'Italia, tre buoni rappresentanti di Pinot Nero italiani. Il primo vino selezionato è l'Alto Adige Pinot Nero Schiesstandhof dei Produttori Termeno. Questo vino è prodotto con Pinot Nero in purezza e maturato per 9 mesi in barrique, seguito da un ulteriore maturazione in botte. Il secondo vino è il Pinèro di Ca' del Bosco, nota cantina per la produzione di ottimi Franciacorta. Pinèro matura per 13 mesi in barrique. Il terzo e ultimo vino della nostra degustazione comparativa è il Nero al Tondo di Ruffino, un ottimo vino prodotto in Toscana e maturato in barrique per 12 mesi. Poiché i tre vini sono generalmente posti in commercio dopo alcuni anni dalla loro produzione, sarà opportuno utilizzare una temperatura di servizio di 18 gradi in tutti e tre i casi. Nonostante il Pinot Nero produca vini con apprezzabile freschezza, la maturazione, in questo caso, conferisce una piacevole morbidezza che sarà giustamente valorizzata dalla temperatura. La nostra degustazione si svolgerà utilizzando tre calici ISO.
|
||||||||
|
Il Pinot Nero è un uva rossa non molto ricca di sostanze coloranti, pertanto è piuttosto improbabile trovare vini prodotti con quest'uva con colori intensi e profondi - come nel caso del Cabernet Sauvignon - e all'aspetto mostrano sempre una discreta trasparenza. A causa di una “cultura” discutibile, tale da fare ritenere che un vino rosso, per essere buono e di qualità, deve sempre mostrare colori intensi, profondi e trasparenze impenetrabili, spesso il Pinot Nero è discriminato proprio per il fatto di non confermare, nella maggioranza dei casi, questo criterio. Dopo tutto, se il vino fosse solamente quello che si vede, basterebbe veramente poco per fare un grande vino. Tuttavia, i vini prodotti con Pinot Nero mostrano trasparenze piuttosto variabili, talvolta anche ridotte, una condizione che - come sempre - è determinata dalla qualità dell'uva, dall'area di produzione e dalle tecniche impiegate per la vinificazione. Il primo vino che prenderemo in esame è l'Alto Adige Pinot Nero Schiesstandhof dei Produttori Termeno. Mantenendo il calice inclinato sopra una superficie bianca, si osserverà l'intensità del colore alla base del calice. Si noterà un colore rosso rubino brillante e, nel bordo della massa liquida, verso l'apertura del calice, si osserveranno sfumature rosso granato. Il secondo vino del quale valuteremo l'aspetto è il Nero al Tondo di Ruffino. La tonalità del colore di questo vino è rosso rubino intenso e - come nel vino precedente - con sfumature rosso granato. Si passerà ora alla valutazione dell'ultimo vino, il Pinèro di Ca' del Bosco. Esattamente come i vini precedenti, la tonalità del colore di Pinèro è rosso rubino brillante e, rispetto agli altri vini, la sfumatura tende più al rosso rubino piuttosto che al rosso granato. Si noti come in tutti e tre i vini la trasparenza sia moderata, a conferma del non elevato contenuto di sostanze coloranti del Pinot Nero.
|
|
Una delle qualità che affascina gli appassionati del Pinot Nero è rappresentata dai suoi aromi. Freschi e fruttati, ma anche complessi e ricchi, i vini prodotti con Pinot Nero esprimono un'eleganza e una raffinatezza di aromi tali da renderlo unico. Ovviamente queste sono qualità che è possibile trovare in tutti i vini buoni, però nel Pinot Nero assumono una pulizia e un'eleganza tutta particolare. Anche l'uso equilibrato di barrique e botti contribuiscono alla migliore espressione delle qualità aromatiche dei vini rossi da Pinot Nero. Nonostante sia innegabile che l'uso di contenitori in legno per la maturazione dei vini svolga un ruolo importante, un uso corretto e non invasivo rappresenta nel Pinot Nero la scelta migliore. Un uso forte della barrique nei vini prodotti con quest'uva tenderebbe a esaltare le marcate qualità legnose, coprendo completamente la delicatezza e la freschezza dei suoi aromi. Anche per questo motivo, il Pinot Nero è spesso vinificato utilizzando contenitori inerti, come l'acciaio o il cemento. Il primo vino del quale valuteremo gli aromi è l'Alto Adige Pinot Nero Schiesstandhof dei Produttori Termeno. Mantenendo il calice fermo e in posizione verticale, si inizierà la valutazione degli aromi di apertura. La prima olfazione consentirà di percepire aromi di ciliegia e lampone, due aromi che sono tipicamente presenti nei vini da Pinot Nero, in modo particolare la ciliegia. Dopo avere roteato il calice, in modo da favorire un'opportuna ossigenazione del vino, si procederà con una seconda olfazione. Sarà possibile percepire dal calice aromi di fragole, prugna, rosa appassita e geranio oltre ad aromi terziari conferiti dalla maturazione in legno, in particolare vaniglia, liquirizia e cacao. Si noti come l'aroma di vaniglia - tipica nei vini maturati in botte - sia piuttosto contenuta ed equilibrata, lasciando il giusto spazio alla natura fruttata del vino, molto piacevole. Il secondo vino che analizzeremo è il Nero al Tondo di Ruffino. Mantenendo il calice fermo e in posizione verticale, si procederà con la valutazione degli aromi di apertura. Esattamente come per il vino precedente, anche nel Nero al Tondo si percepiranno aromi di ciliegia e lampone, ai quali si affiancherà anche l'aroma di prugna. La seconda olfazione - eseguita dopo avere roteato il calice - farà emergere aromi di fragola, mirtillo e rosa oltre a una serie aromatica terziaria, più complessa rispetto al vino precedente, di liquirizia, vaniglia, tabacco, cioccolato, cuoio, pepe rosa e macis. Si passerà ora alla valutazione del Pinèro di Ca' del Bosco, nel quale sarà possibile percepire aromi di apertura di ciliegia, lampone, prugna e mirtillo. Dopo avere roteato il calice, la sequenza aromatica sarà completata da aromi di rosa e un accenno di ribes, seguite da cioccolato, caffè, eucalipto, vaniglia, affumicato e un accenno di pepe nero.
|
||||
|
L'eleganza del Pinot Nero continua a esprimersi anche nel suo gusto. Esattamente come per gli aromi, i sapori del Pinot Nero sono caratterizzati da qualità eleganti e raffinate, ben supportate dalla sua tipica freschezza. Una delle caratteristiche principali del Pinot Nero è infatti la sua acidità che - unita al suo basso contenuto di tannini - rende il profilo organolettico di questi vini piuttosto speciale. Tuttavia questa acidità ha i suoi aspetti negativi, poiché quando è esaltata eccessivamente, questo rende il vino poco equilibrato. Anche il basso contenuto di tannini del Pinot Nero può essere opportunamente equilibrato grazie alla maturazione intelligente del vino in botte o in barrique, facendo attenzione a non esagerare poiché questo tenderebbe a coprire troppo la natura del Pinot Nero. I vini Pinot Nero di qualità richiedono pratica e competenza in ogni fase della produzione, dalla coltivazione dell'uva fino all'imbottigliamento. La fama di essere un'uva difficile è certamente vera, tuttavia questa “bizzarra” uva rossa è capace di offrire vini straordinari anche nel gusto. Il primo vino che analizzeremo è l'Alto Adige Pinot Nero Schiesstandhof dei Produttori Termeno. Si noti come la freschezza nell'attacco di questo vino sia piuttosto percettibile, tuttavia ben equilibrata, qualcosa che si differenzia dal modello tipico di vino rosso, come per esempio nei vini prodotti con Merlot. Si noti anche l'apprezzabile astringenza, conferita anche dalla maturazione in botte - certamente non aggressiva e forte, come per esempio nel caso del Cabernet Sauvignon - tuttavia in logico equilibrio con le altre qualità organolettiche. Passiamo ora alla valutazione del Nero al Tondo di Ruffino. Anche in questo caso nell'attacco si percepisce una discreta freschezza e, rispetto al vino precedente, una maggiore astringenza, anche in questo caso, accentuata dalla maturazione in barrique. L'ultimo vino che valuteremo è il Pinèro di Ca' del Bosco. Anche in questo caso la freschezza è piuttosto evidente, ben equilibrata dall'alcol, come nei vini precedenti, e anche l'astringenza provocata dai tannini e ben percettibile. Si noti, in tutti e tre i vini, come l'uso della botte sia piuttosto equilibrato tale da consentire l'apprezzamento delle qualità fruttate e fresche del Pinot Nero.
|
|
I tre Pinot Nero della nostra degustazione comparativa fanno ben comprendere le qualità organolettiche di quest'uva, così come l'influsso della botte e del suo uso. Il finale dell'Alto Adige Pinot Nero Schiesstandhof dei Produttori Termeno è persistente, lasciando in bocca piacevoli ricordi di ciliegia, lampone e fragola, tre qualità aromatiche tipiche del Pinot Nero. Anche il finale del Nero al Tondo di Ruffino sarà persistente e caratterizzato da ricordi di ciliegia, lampone e fragola, esattamente come il vino precedente. Il finale dell'ultimo vino, il Pinèro di Ca' del Bosco, sarà persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e prugna. Si noti come l'aroma e il sapore di ciliegia, unitamente a lampone e fragola, siano qualità ricorrenti nel Pinot Nero - come nel caso dei nostri tre vini - e che le qualità floreali ricordano spesso la rosa e il ciclamino. Il segreto per fare un buon Pinot Nero, come nel caso dei nostri tre vini, è l'utilizzo di uve di qualità - un fattore certamente determinante per qualunque vino - e che nel Pinot Nero rappresenta una difficoltà ulteriore. Si noti infine che, nonostante sia importante nell'equilibrio e nella struttura del vino, nel Pinot Nero l'uso di botti e barrique non dovrà mai essere eccessivo, in modo da concedere all'uva di esprimere la sua eleganza.
|
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |
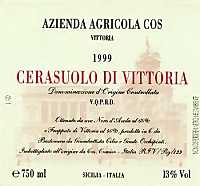
|
|
Cerasuolo di Vittoria 2003 |
|
| COS (Sicilia, Italia) | |
| Uvaggio: Nero d'Avola (60%), Frappato (40%) | |
| Prezzo: € 11,50 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di lampone, mirtillo, carruba, violetta, tabacco e vaniglia. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco leggermente tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. L'uva Nero d'Avola utilizzata per la produzione di questo Cerasuolo di Vittoria matura in botte, mente il Frappato matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Stufati e brasati di carne con funghi, Carne arrosto, Carne alla griglia | |

|
|
Contrada Labirinto 2001 |
|
| COS (Sicilia, Italia) | |
| Uvaggio: Nero d'Avola | |
| Prezzo: € 35,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di mirtillo, tostato, liquirizia, tabacco, vaniglia, carruba e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. Contrada Labirinto matura per 24 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio seguiti da 12 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |
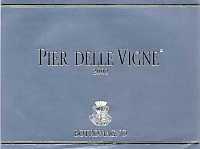
|
|
Pier delle Vigne 2000 |
|
| Botromagno (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Aglianico (60%), Montepulciano (40%) | |
| Prezzo: € 10,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di confettura di prugne e confettura di more seguite da aromi di confettura di lamponi, mirtillo, carruba, tabacco, vaniglia, ciclamino, liquirizia e pepe nero. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di confettura di prugne e confettura di more. Pier delle Vigne matura per almeno 18 mesi in barrique a cui seguono almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Gravisano 2001 |
|
| Botromagno (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Malvasia Bianca | |
| Prezzo: € 14,00 - 375ml | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di fico secco, miele e uva passa seguite da aromi di albicocca secca, confettura di mele cotogne, confettura di pesche, dattero, mandorla, nespola, miele, vaniglia e smalto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco dolce e piacevole morbidezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di fico secco, miele, nespola e uva passa. Gravisano fermenta in barrique. | |
| Abbinamento: Formaggi stagionati, Crostate di mandorle e frutta secca, Pasticceria secca | |
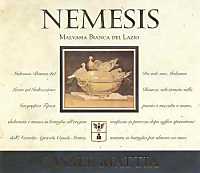
|
|
Nemesis 2004 |
|
| Casale Mattia (Lazio, Italia) | |
| Uvaggio: Malvasia Bianca | |
| Prezzo: € 5,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di biancospino e mela seguite da aromi di ginestra, mandorla, pera e susina. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di mela e susina. Nemesis matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce e verdure | |

|
|
Frascati Superiore Linea Storica 2004 |
|
| Casale Mattia (Lazio, Italia) | |
| Uvaggio: Malvasia di Candia, Malvasia Bianca, Trebbiano Giallo, Bombino, Bellone | |
| Prezzo: € 10,50 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, pera e gelsomino seguite da aromi di ananas, biancospino, ginestra, mandorla e susina. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di pera, mela e ananas. Questo Frascati matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Pesce fritto, Pasta con pesce, Pesce arrosto | |
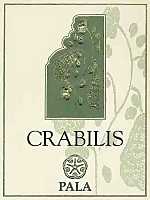
|
|
Vermentino di Sardegna Crabilis 2005 |
|
| Pala (Sardegna, Italia) | |
| Uvaggio: Vermentino | |
| Prezzo: € 6,00 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di pesca, pera e ananas seguite da aromi di agrumi, litchi, ginestra, acacia e mela. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di pesca, ananas e pera. Questo Vermentino di Sardegna matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Pesce fritto, Risotto con crostacei e pesce, Pesce saltato | |
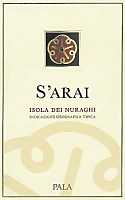
|
|
S'Arai 2002 |
|
| Pala (Sardegna, Italia) | |
| Uvaggio: Cannonau, Carignano, Barbera, Bovale | |
| Prezzo: € 18,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di prugna e amarena seguite da aromi di mirtillo, mora, violetta, vaniglia, tabacco, liquirizia e carruba. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di prugna e amarena. S'Arai matura per 8-10 mesi in barrique a cui seguono 3-4 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |
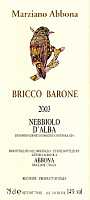
|
|
Nebbiolo d'Alba Bricco Barone 2003 |
|
| Abbona Marziano (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Nebbiolo | |
| Prezzo: € 9,00 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, fragola e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, rosa, vaniglia, liquirizia, cannella e rosmarino. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, fragola e prugna. Questo Nebbiolo matura per 12 mesi in barrique a cui seguono 6 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Barolo Pressenda 2001 |
|
| Abbona Marziano (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Nebbiolo | |
| Prezzo: € 26,00 | Punteggio: |
| Questo Barolo si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso arancio, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di ciliegia, violetta e lampone seguite da aromi di prugna, rosa, ciclamino, vaniglia, tabacco, liquirizia, confettura di fragole, cannella, cacao, scatola di sigari, macis e mentolo. In bocca ha ottima corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, lampone e prugna. Un vino ben fatto. Questo Barolo matura per 12 mesi in barrique a cui seguono 18 mesi di maturazione in botte. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |
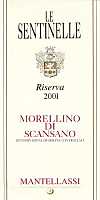
|
|
Morellino di Scansano Riserva Le Sentinelle 2001 |
|
| Fattoria Mantellassi (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese (85%), Alicante (15%) | |
| Prezzo: € 14,00 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di mirtillo, violetta, vaniglia, tabacco, liquirizia, cioccolato e un accenno di mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena e prugna. Questo Morellino di Scansano matura per 20 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Querciolaia 2002 |
|
| Fattoria Mantellassi (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Alicante | |
| Prezzo: € 16,00 | Punteggio: |
| Querciolaia si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena e prugna seguite da aromi di mirtillo, mora, burro d'arachidi, carruba, tabacco, vaniglia e pepe rosa. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Questo vino matura per 13-16 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Primitivo 2003 |
|
| Conti Zecca (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Primitivo (85%) | |
| Prezzo: € 9,15 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di mirtillo, vaniglia, tabacco, liquirizia, caffè, carruba e anice. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco leggermente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. Questo vino matura per 12 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne | |
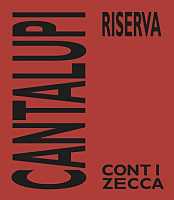
|
|
Salice Salentino Rosso Riserva Cantalupi 2002 |
|
| Conti Zecca (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Negroamaro (80%), Malvasia Nera (20%) | |
| Prezzo: € 8,75 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di prugna e mora seguite da aromi di amarena, lampone, violetta, vaniglia, tabacco, liquirizia e carruba. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco leggermente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena e mora. Salice Salentino Cantalupi matura per almeno 12 mesi in botte. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Formaggi stagionati | |
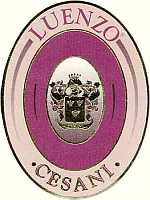
|
|
Luenzo 2002 |
|
| Cesani (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese (90%), Colorino (10%) | |
| Prezzo: € 20,00 | Punteggio: |
| Luenzo si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, vaniglia, lampone, carruba, tabacco e cardamomo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Questo vino matura per 16 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Vernaccia di San Gimignano Sanice 2003 |
|
| Cesani (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Vernaccia di San Gimignano | |
| Prezzo: € 15,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di pesca, susina e mela seguite da aromi di ananas, nocciola, vaniglia, pralina, confettura di pesche e burro d'arachidi. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, piacevole morbidezza, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di mela, ananas e susina. Parte di questo vino matura per 6 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi | |

|
|
Brunello di Montalcino Riserva 1998 |
|
| Mastrojanni (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese Grosso | |
| Prezzo: $55,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso arancio, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di prugna secca, amarena e confettura di mirtilli seguite da aromi di confettura di more, viola appassita, vaniglia, rosa appassita, tabacco, liquirizia, cioccolato, cannella, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di prugna secca, amarena e confettura di mirtilli. Un vino ben fatto. Questo Brunello di Montalcino Riserva matura per 42 mesi in botte a cui seguono circa 12 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Brunello di Montalcino Vigna Schiena d'Asino 1999 |
|
| Mastrojanni (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese Grosso | |
| Prezzo: $75,00 | Punteggio: |
| Questo Brunello di Montalcino si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di violetta, mirtillo, rosa, vaniglia, tabacco, liquirizia, cacao, cannella, pepe rosa e mentolo. In bocca ha ottima corrispondenza con il naso, un attacco tannico e piacevole freschezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mora. Un vino ben fatto. Questo Brunello di Montalcino matura per circa 42 mesi in botte a cui seguono circa 8-9 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati | |
Leone de CastrisTra le cantine più storiche d'Italia, con 80 anni di attività, e tra le più note della Puglia, porta nel mondo i vini tipici di Salice Salentino, puntando soprattutto sui vitigni autoctoni e sperimentando quelli alloctoni |
|
La storia del vino pugliese e quella dell'azienda vinicola Leone de Castris viaggiano parallele. L'azienda ha origine nel 1925, dal matrimonio tra Piero Francesco Leone (1904-1993) e Anna Luisa Filippa de Castris (1901-1950), che unì le due più importanti famiglie di Salice Salentino, provincia di Lecce. Piero Francesco Leone, secondo di cinque figli, alla morte del padre, si dedicò all'amministrazione delle proprietà, costituite da fabbricati e terreni sui quali avviò un processo di trasformazione colturale, impiantando vigneti su terre prima coltivate a grano, e conducendoli parte in economia e parte attraverso un esercito di coloni del luogo. Piero, si trovò così a soli 20 anni ad amministrare un patrimonio terriero di oltre 2.000 ettari tra Salice, Guagnano, Campi, San Pancrazio e Sandonaci. Oltre a essere agricoltore divenne anche viticoltore, mostrando di possedere le qualità di agronomo, enologo ed esperto imprenditore. Nel corso degli anni venti, egli sviluppò la produzione di vino e nel 1925 effettuò in Puglia il primo imbottigliamento, che a poco a poco perfezionò negli anni seguenti, dopo aver acquisito tutti i sistemi più aggiornati, avendo constatato direttamente l'applicazione dei nuovi processi tecnologici attraverso viaggi e contatti con le più rinomate case vinicole italiane (toscane e piemontesi) e francesi.
Piero rinnovò i vigneti, impiantò uno stabilimento moderno, attrezzato con torchi elettrici, che sostituirono quelli di legno e a vite; fece costruire lungo il perimetro delle cantine vasche e fermentini in cemento armato, adottò tecnologie avanzate in cantina e ammodernò la struttura gestionale dell'azienda; servendosi, inoltre, della collaborazione di esperti enologi. Fu così che nel 1943 nacque il celebre vino rosato Five Roses, il Salice Salentino nel 1954 e successivamente una vasta gamma di vini pregiati. Alla fine degli anni sessanta, la direzione generale venne assunta da Salvatore Leone de Castris, figlio di Piero e Lisetta, che contribuì fortemente a un'ulteriore espansione anche nei principali mercati internazionali. Negli ottanta entra in azienda il figlio Piernicola Leone de Castris che si occupa del settore commerciale e poi, della direzione generale dalla fine degli anni novanta. Piernicola, che da oltre un decennio dirige l'azienda con grande competenza imprenditoriale, rappresenta la terza generazione, dopo il nonno Piero e il padre Salvatore, di una casa vitivinicola rinomata fin dal secondo dopoguerra, anche se le origini dell'azienda agraria affondano le radici nel lontano XVII secolo. La capacità dell'azienda vinicola Leone de Castris di coniugare imprenditorialità e qualità del prodotto, un rapporto inscindibile, nel corso degli anni è stata alla base, prima della sperimentazione dell'imbottigliamento del vino rosato e poi degli altri. L'azienda produce vini di pregio DOC (Denominazione di Origine Controllata) e IGT (Indicazione Geografica Tipica), spumanti, un'acquavite d'uva e un olio extra-vergine d'oliva. La “mission” dell'azienda recita così: «Desideriamo valorizzare i vini del Salento nel mondo». I vigneti di Leone de Castris si trovano su terre di antica e provata tradizione vitivinicola: le terre del Salento. Ventilati e in pieno sole, i vigneti di vecchia e media età, sono concimati sempre con sostanze organiche tradizionali e curati da mani esperte, per una produzione mai eccessiva e altamente selezionata. La trasformazione delle uve prodotte su questi terreni e da questi vigneti, vendemmiate al giusto punto di maturazione, in nobili vini di qualità superiore, costituisce un irrinunciabile impegno che si perfeziona attraverso il continuo aggiornamento delle tecniche di vinificazione: sempre al passo con i tempi per soddisfare le attese dei più esigenti consumatori. L'azienda Leone de Castris è stata, infatti, la prima in Italia ad aver imbottigliato e fatto conoscere il vino rosato. Accanto ai vitigni tradizionali (Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Verdeca, Aleatico e Moscato), si affiancano alcuni vitigni di nuova introduzione (Montepulciano, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Sauvignon Blanc), ma la scelta strategica principale è la valorizzazione dei vitigni autoctoni. Le cantine dell'azienda si estendono su una vasta area. Dispongono, poi, di alcune linee d'imbottigliamento a ciclo completo, d'impianti di sterilizzazione e refrigerazione; di depositi, freschi e asciutti, per l'invecchiamento in bottiglia di alcuni vini e di reparti per l'imballaggio e l'immagazzinamento automatico delle bottiglie vuoti. Da sottolineare, infine, la grande sala di degustazione, quella per i ricevimenti e tutte le infrastrutture che rendono queste cantine perfettamente efficienti e autonome sotto tutti gli aspetti. L'impegno nell'ammodernamento degli impianti, nella cura e la selezione delle uve, nella produzione di vini che valorizzano il territorio, hanno fatto della Leone de Castris una certezza in un settore altamente competitivo e un punto di riferimento per la produzione pugliese.
L'apprezzamento ottenuto dai vini Leone de Castris, da parte degli intenditori, è il risultato ultimo di una serie di favorevoli circostanze naturali, accompagnate da esperienza a da costante impegno. Terreni particolarmente adatti alla coltivazione dei vigneti, uve perfettamente maturate, vinificazione e invecchiamento appropriati: questi i segreti del successo che da tanti anni fanno preferire i vini Leone de Castris. Tra i vini prodotti dall'azienda si evidenziano diversi tipi di linee: “La grande tradizione”, “I vini di pregio”, “I barricati”, “La nuova generazione” e “gli spumanti”. Della linea “La grande tradizione” fanno parte il Salice Salentino Riserva DOC, il ben noto Five Roses da uve Negroamaro e Malvasia Nera, infine Negrino Salice Salentino DOC, un vino dolce da uve Aleatico. La linea “I vini di pregio” è costituita da Pierale, vino dolce da uve moscato e dedicato all'ultima generazione della famiglia de Castris; Villa Santera, un Primitivo di Manduria DOC; La Rena (Salento Primitivo IGT); Vigne Case Alte Sauvignon, bianco IGT; Messapia (Salento bianco IGT); Imago, Salento Chardonnay IGT; Negroamaro Elo Veni, Salento rosso IGT; Truppere, Salento Primitivo IGT, sulla cui etichetta si fa riferimento al vitigno Zinfandel. La linea dei vini barricati è poi formata da quattro prodotti: Illemos, Salento rosso IGT, prodotto dal 1997; Donna Lisa, Salice Salentino bianco DOC; Donna Lisa, Salice Salentino Rosso Riserva DOC; Messere Andrea, Salice Salentino rosso DOC. Ecco i prodotti della linea “La nuova generazione”: Maiana, Salice Salentino rosso DOC; Maiana Rosè DOC; Maiana Bianco DOC; Locorotondo DOC; Ursi, bianco frizzante a fermentazione naturale da uve Verdeca e Chardonnay; il Medaglione Salento rosso IGT; Medaglione rosato Salento IGT; Medaglione bianco Salento IGT. Due gli spumanti brut prodotti da Leone de Castris: Donna Lisetta, da uve Pinot Nero con lavorazione in bianco, e Don Piero, da uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, prodotti entrambi dedicati agli antenati. Infine, l'azienda pugliese produce anche un vino Novello, il Salentinello, ottenuto dalla macerazione carbonica di uve Negroamaro, Malvasia Nera e Montepulciano.
|
||||||||||||||||||||
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |
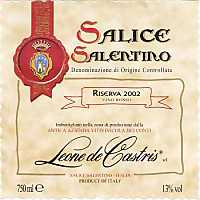
|
|
Salento Salentino Rosso Riserva 2002 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Negroamaro (90%), Malvasia Nera (10%) | |
| Prezzo: € 8,20 | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena e mora seguite da aromi di mirtillo, prugna, violetta, vaniglia e un accenno di caucciù. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco leggermente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena e mora. Questo Salice Salentino Riserva matura per 12 mesi in botte. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Salento Salentino Bianco Donna Lisa 2004 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Chardonnay | |
| Prezzo: € 14,00 | Punteggio: |
| Donna Lisa Bianco si presenta con un colore giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, susina e pera seguite da aromi di agrumi, biancospino, ginestra, ananas, pesca, vaniglia e pompelmo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e piacevole morbidezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di mela, susina e pera. Questo vino matura per circa 9 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Zuppe di funghi, Pesce alla griglia, Carne bianca arrosto | |
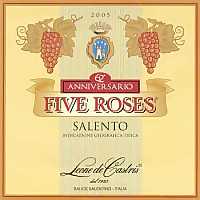
|
|
Salento Five Roses Anniversario 2005 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Negroamaro (80%), Malvasia Nera (20%) | |
| Prezzo: € 8,40 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosa salmone brillante e sfumature rosa tenue, trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, lampone e pesca seguite da aromi di fragola, mirtillo, melograno, susina, ciclamino e biancospino. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e piacevole morbidezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di lampone, ciliegia e susina. Five Roses Anniversario matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Pasta con carne e pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi | |
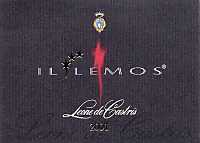
|
|
Salento Il Lemos 2001 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Primitivo (50%), Neogroamaro (10%), Montepulciano (20%), Merlot (20%) | |
| Prezzo: € 19,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di lampone, mirtillo, violetta, vaniglia, pepe rosa e carruba. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Il Lemos matura per circa 14 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati di carne, Formaggi stagionati | |
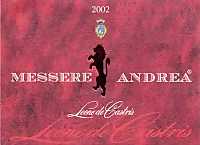
|
|
Salento Messere Andrea 2002 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Negroamaro (85%), Cabernet Sauvignon (15%) | |
| Prezzo: € 15,00 | Punteggio: |
| Il vino si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di prugna, mora e amarena seguite da aromi di mirtillo, violetta, vaniglia, ciclamino, liquirizia e carruba. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di prugna e amarena. Messere Andrea matura per circa 12 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi stagionati | |
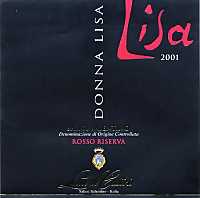
|
|
Salento Salentino Rosso Riserva Donna Lisa 2001 |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| Uvaggio: Negroamaro (90%), Malvasia Nera (10%) | |
| Prezzo: € 24,00 | Punteggio: |
| Questo vino si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di mirtillo, violetta, lampone, vaniglia, liquirizia, cacao e macis. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Il finale è persistente con ricordi di prugna e amarena. Donna Lisa Rosso Riserva matura per circa 18 mesi in barrique. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |
| Leone De Castris - Via Senatore de Castris, 26 - 73015, Salice Salentino (Lecce) - Tel. 0832 731112 Fax. 0832 731114 - Enologo: Giovanni Dimastrogiovanni - Anno fondazione: 1925 - Produzione: 2.500.000 bottiglie - E-Mail: info@leonedecastris.com - WEB: www.leonedecastris.com |
Giornale di Cantina |
|
Questa rubrica è riservata ai produttori di vino che intendono rendere note particolari attività produttive, annunciare nuovi prodotti o semplicemente comunicare alla clientela informazioni e promozioni sulla propria attività e i propri prodotti. Inviare le notizie da pubblicare al nostro indirizzo e-mail.
|
Joint Venture fra Cantina di Soave e Cantina Ermes |
||||
Entusiasta del progetto si dice anche Paolo De Maria, direttore di questa azienda con un volume di 400 mila quintali d'uva lavorata all'anno: «Siamo felicissimi, e oltremodo fiduciosi circa il futuro di questa joint venture. Cantina di Soave è un partner con cui ci troviamo benissimo e che sta investendo molto in questo progetto. È la dimostrazione che ci crede fortemente, come ci crediamo noi». Primo frutto dell'accordo è stata la creazione di due distinte linee di vini, rigorosamente da vitigni autoctoni: Qibli, destinata al canale Ho.Re.Ca, comprende un Nero d'Avola e un Grillo (vinificati in purezza), mentre Kjos porterà le stesse tipologie nel canale moderno. Entrambe verranno distribuite in Italia e nei quaranta paesi esteri in cui sono presenti i vini veronesi della Cantina di Soave. |
||||
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
Le Colline di Romagna e Vino: Concorso di Fotografia Digitale |
||||
| Il Progetto comunitario Wineplan, per valorizzare il territorio vitivinicolo,
ha stimolato l'organizzazione di un concorso fotografico digitale rivolto a
tutti i fotografi dilettanti e professionisti. Su queste linee l'Associazione
“Strada del Sangiovese” ha indetto il primo concorso fotografico digitale a
premi. Una sfida a suon di scatti incentrata sul tema “Le colline di Romagna,
il paesaggio, la vite, il vino, gli uomini”. Sono previste cinque categorie:
Natura, Paesaggio, La vite e il vino, I volti, Antichi mestieri e tradizioni. |
||||
Il Vino Nobile di Montepulciano a Bologna |
| Si è conclusa con un grande afflusso di operatori, enoappassionati e
giornalisti, la giornata promozionale del Vino Nobile di Montepulciano a
Bologna. Organizzata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con il
supporto della segreteria operativa di Bologna della rivista “Capita al Vino”
e in collaborazione con Caraiba Spiegelau, la giornata si è svolta nelle sale
del centralissimo Hotel Royal Carlton. L'evento ha consentito ai produttori
dello storico vino toscano di invitare e incontrare gli operatori commerciali,
la stampa specializzata e tutti i cultori del buon bere della città di Bologna,
facendo loro degustare in anteprima le nuove annate in commercio della DOCG Vino
Nobile di Montepulciano, accompagnate da prodotti tipici del territorio come
salumi e formaggi. I produttori sono rimasti a disposizione del pubblico per
l'intera durata della manifestazione. Venti sono state le aziende vinicole intervenute all'evento con i loro prodotti: Bindella, Boscarelli, Casa Vinicola Carpineto, Casa Vinicola Triacca, Contucci, Dei, Fattoria del Cerro, Fattoria di Palazzo Vecchio, Gracciano Svetoni, La Braccesca Antinori, La Ciarliana, Le Bèrne, Le Casalte, Nottola, Poggio alla Sala, Romeo, Tenuta di Gracciano Della Seta, Tenuta Sant'Agnese, Tenuta Valdipiatta, Villa Sant'Anna. |
Terza Edizione del Bea |
| Una formula nuova, più ricca e, quest'anno, anche generosa per la terza
edizione del Bea, Banco dell'Enogastronomia e dell'Artigianato. Tra le varie
novità che caratterizzeranno la manifestazione si inserisce infatti anche
l'impegno sociale: l'intero incasso dell'iniziativa sarà devoluto alla Croce
Rossa Italiana. La rassegna fieristica delle tipicità enogastronomiche e
artigianali si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2006 nella Palazzina
Azzurra di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e in una tensostruttura
appositamente allestita su viale Buozzi. La Palazzina, oltre ad essere dotata
di corner espositivi ed informativi delle varie associazioni aderenti alla
manifestazione, sarà la sede istituzionale della rassegna, dove verranno
organizzati convegni, conferenze e tavole rotonde a tema. Nel contempo, la
tensostruttura, sarà suddivisa in due aree distinte e contigue, caratterizzate
rispettivamente da una zona mercato e da una zona degustazione. Al suo interno,
infatti, sarà possibile sia la vendita dei prodotti al dettaglio per il
pubblico, sia la degustazione delle tipicità in appositi angoli allestiti dalle
singole associazioni che offriranno agli ospiti le proprie eccellenze. L'area dedicata agli assaggi delle tipicità sarà inoltre caratterizzata da degustazioni guidate e da laboratori del gusto curate dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier, Slow Food, Cia, Assindustria, Cna, Coldiretti e I.P.S.S.A.R. Importante sarà il contributo che verrà fornito dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, da sempre attenta alla tutela delle tipicità enogastronomiche ed artigianali. «La distinzione delle due aree - spiega Marco Calvaresi, Presidente del Consorzio Turistico Riviera delle Palme - ha il duplice obiettivo di favorire il rapporto immediato del consumatore con il prodotto attraverso la vendita diretta e di valorizzare la qualità delle eccellenze del nostro territorio attraverso le degustazioni guidate e gli incontri tematici». Ulteriore novità dell'iniziativa sarà la premiazione del miglior prodotto della rassegna attraverso i giudizi espressi dai visitatori su un apposito questionario che verrà consegnato nel corso della manifestazione e attraverso il quale sarà stabilito l?indice di gradimento. La volontà di garantire un'adeguata “vetrina” alle peculiarità che caratterizzano l'offerta turistica di San Benedetto del Tronto e del suo hinterland sarà inoltre soddisfatta da una serie di tour nelle varie località del Piceno, dedicata a giornalisti di settore e corrispondenti italiani di testate straniere. |
La Cucina Indiana e il VinoLa cucina di un paese ricco di fascino e di piatti deliziosi, non solo a base di riso e curry, nel quale ogni regione ha la sua gastronomia e il suo pane tipico. Una cucina che può essere abbinata al vino |
|
L'India viene considerata da molti il paese delle cento nazioni, dei cento dialetti, delle mille religioni e dei duemila dei. Ma è anche un paese con una gastronomia molto varia, diversa da regione a regione e da famiglia a famiglia, considerata come arte e ricca di riti sociali e religiosi. È il paese delle spezie e del curry. Se si pensa che la cucina indiana sia solo riso, curry e chutney, si rimane piacevolmente sorpresi. Non esiste uno stile culinario ben preciso, né un piatto nazionale, ma un'incredibile varietà di ingredienti e preparazioni. La cucina indiana è semplice, equilibrata, basata su ricette e principi millenari. L'Ayurvedica, ad esempio, trascende in ogni composizione. Così un piatto un po' pesante sarà sempre attenuato da una base acida e digestiva, ad esempio pomodori, aceto o limone. I miscugli di spezie ricoprono un ruolo fondamentale.
|
Facendo un confronto fra la cucina del nord e del sud, si noterà una presenza maggiore di pane, carne grigliata, una minore presenza di salse, un maggiore consumo di yogurt, oltre alla caratteristica cottura con il ghee, una sorta di burro chiarificato. Nella cucina del nord si ritrovano anche gli influssi di altre tradizioni gastronomiche orientali, come nei biryani (piatti unici a base di riso ripieni di spezie, carne, verdure e a volte pesce) e gli spiedini. Nel Rajastan - al confine con il Pakistan - è tipico l'allevamento di pecore. Il celebre tandoori - famosissimo anche nei paesi occidentali - è tipico del Punjab, e soprattutto a Delhi, dove ha avuto la sua origine. La cottura della carne nella cucina del nord prevede una marinatura, per poi essere grigliata nel tandoor - una specie di forno - solitamente accompagnata da salse allo yogurt. Il Kashmir, nell'estremo nord dell'India, è celebre per le ricette a base di carne, ceci e le preparazioni piuttosto speziate. Qui si registra la maggiore produzione di peperoncino del paese, il cui uso - in accordo alla tradizione indiana - consente di riscaldarsi “dall'interno”, provvedendo, se necessario, a mitigare l'effetto con un po' di yogurt. La cultura gastronomica dell'India del sud è prevalentemente orientata ai prodotti della terra, pertanto vegetariana, con un consumo prevalente di legumi e cereali. In questa zona la cottura è essenzialmente fatta con olio, i piatti sono generalmente accompagnati da riso nel quale si aggiungono salse. La preferenza al consumo di alimenti di origine vegetale è inoltre favorita dalla ricca presenza di alberi da frutto, in particolare anacardi, banani - nelle varietà rosse, di grandi e piccole dimensioni, molto dolci dette banane burro - limone, guaiava, pianta del pane, manghi, papaia e tamarindi. Nella parte meridionale, nella costa tropicale a partire da Goa, si registra inoltre un consumo di pesce, crostacei e molluschi, generalmente cotti nell'olio e speziati con curry. La parte occidentale del sud dell'India - nello stato di Kerala - è celebre per le noci di cocco, ananas e banane rosse, oltre per la produzione di semi di cardamomo, una delle spezie più utilizzate in India. Il Tamil Nadu, nella parte orientale, è noto per i suoi dal - nome con il quale in India si identificano circa 60 varietà di legumi, come lenticchie, ceci, soia, piselli e fagioli - a base di tamarindo. Probabilmente la cucina più ricercata dell'India è quella dello stato di Maharashtra, la cui capitale è Bombay, che prevede l'uso di innumerevoli ingredienti. Sono famosi gli achar o pickles (sottaceti piccanti) e i chutneys, le famose salse di accompagnamento per ogni tipo di cibo, dal riso al pane e alla carne, con lo scopo di creare una contrapposizione di gusti piuttosto particolare. Esistono diversi tipi di chutney: alcuni sono freschi, acidi e profumati alla menta o al coriandolo, altri sono vere e proprie conserve agrodolci e piccanti. Frutta e verdura sono generalmente speziate, cotte con aceto e zucchero, lasciate maturare per alcuni giorni in modo da accentuarne l'aroma. Celebri anche i kachumbars, insalate preparate con non più di due o tre tipi di verdure, nelle quali si trova quasi sempre cipolla cruda, condite molto semplicemente, profumate con coriandolo o menta tritati. La cucina dell'India occidentale è dolce, con un uso moderato di spezie e curcuma. Nella parte orientale - dove si trovano gli stati Bihar, Bengala Occidentale e Orissa - la cucina è caratterizzata da pesce e dolci. Tipico è l'uso del midollo di banano servito come verdura.
|
||||||||||||
|
Il tandoor è il tipico forno della cucina indiana, costruito in terracotta, la cui origine è probabilmente l'Asia Centrale. Il tandoor ha una forma di grande giara, un collo ristretto ed è interrato nel suolo. Per poterlo usare, si sistemano pezzi di legna sul fondo e quindi si accende il fuoco. Quando le pareti diventano incandescenti e le fiamme si sono spente, si possono inserire gli alimenti da cuocere. I bordi di pani e focacce sono fatti aderire nella parete calda, sotto il collo, in modo che restino sospese sopra la fonte di calore. In questo modo il pane si gonfia, prevalentemente sul bordo, divenendo leggero e assumendo un colore dorato. La cottura delle carni e del pesce si effettua solitamente utilizzando lunghissimi spiedini, nei quali si infila la carne da cuocere, lasciandola nella parte alta, e si appoggiano sul collo del tandoor facendo attenzione che la carne si trovi a circa 30 centimetri al di sopra della brace. Durante la cottura - che richiede tempi brevi - la carne è irrorata con ghee fuso e con la propria marinatura. Il tipico colore ramato delle preparazioni tandoori è ottenuto dalle spezie. Questa tecnica di cottura - tipica delle zone settentrionali - è spesso definita come dietetica poiché non prevede l'uso di grassi. Il segreto tuttavia consiste nei lunghi tempi di marinatura con yogurt, limone e spezie.
|
|
Il lassi è una delle bevande tipiche dell'India consumate durante i pasti. Si prepara con latte pastorizzato portato a ebollizione, al quale si aggiunge limone e lo si lascia riposare fino al giorno seguente. Si recupera quindi il siero che si è formato e lo si mescola con un po' di dahi - yogurt con un pizzico di sale - foglie di menta o di coriandolo e acqua di rose. Tè e caffè sono sempre presi fuori pasto, al mattino o al pomeriggio, preferibilmente con il latte. Il tè, servito senza latte, è generalmente consumato la sera e ben caldo, in modo da facilitare la digestione, come precisato nei testi sacri. L'indiano consuma grandi quantità di succhi di frutta, acqua di cocco, cioè il liquido contenuto all'interno della noce e da non confondere con il latte di cocco, sciroppi di fiori diluiti, e bevande rinfrescanti - a volte salate e al tempo stesso zuccherate - profumate, aromatizzate al limone o all'acqua di rose.
|
|
In India, il pane è un alimento praticamente insostituibile ed è sempre presente nelle tavole. Anticamente il pane indiano era piatto, senza lievito, conosciuto con il nome di roti. La successiva influenza musulmana ha introdotto una varietà di pani lievitati, fra questi il più celebre è il naan. Esistono inoltre roti lievitati, come quelli del Kashmir e di Bombay. Fra i tipi di pane più diffusi si ricordano:
|
|
Nonostante gli indiani siano soliti abbinare alla loro cucina succhi di frutta o acqua, non è comunque escluso l'abbinamento con il vino. Come sempre, è opportuno comprendere le basi di un piatto in modo da formulare il giusto abbinamento enogastronomico. La cucina indiana è ricca di spezie - ingredienti che aumenteranno l'aromaticità del piatto ma anche il gusto tendenzialmente amaro - pertanto sarà opportuno scegliere vini secchi profumati e prodotti con uve aromatiche, come Gewürztraminer e Moscato Bianco, e caratterizzati da una buona morbidezza. Altri vini che generalmente si abbinano felicemente con la cucina indiana sono i rosati, freschi e profumati. I vini rosati hanno inoltre il vantaggio di possedere una maggiore struttura rispetto ai bianchi e che sarà utile nell'abbinamento con le preparazioni più robuste e con la ricca scelta di piatti a base di legumi, cereali e farinacei. Per quanto concerne la cottura della carne tandoori, si potranno abbinare vini rossi, anche di buona struttura e con buona morbidezza - e in accordo al tipo di carne - tuttavia risultano interessanti anche gli abbinamenti con vini Sangiovese o Pinot Nero.
|
Il BasilicoPianta erbacea, originaria dell'India e dell'Indonesia, dal caratteristico odore, si usa come per condimento ai cibi, nella medicina Ayurvedica, in erboristeria e in cosmesi |
|
Il basilico (Ocimum Basilicum), appartiene alla famiglia delle Lamiacee (labiate), le foglie presentano un colore verde intenso sulla parte superiore e verde grigio in quella inferiore. Il termine “basilico” deriva dal greco Basilikos che significa “erba degna di re”. Coltivato in tutte le parti del globo, ricco di olii volatili che variano in composizione all'interno della stessa specie e in relazione alle condizioni di crescita. Le foglie più profumate, dolci e fragranti, sono quelle che si raccolgono poco prima della fioritura, poiché contengono una maggior quantità di sostanze oleose che ne determinano l'aroma, mentre le foglie più vecchie tendono ad avere un sapore più piccante.
|
|
Il Basilico era già noto al tempo degli egizi, che lo impiegavano, con altre essenze, durante le cerimonie religiose. Sembra che fosse usato anche come ingrediente nella fabbricazione del balsamo per la mummificazione. Nel Medio Evo, gli si attribuivano poteri magici, era utilizzato come difesa contro il “basilisco”, creatura mostruosa dalle sembianze di serpente velenoso. Il Basilico - o Bassilico - trova le sue origini nelle lontane India e Indonesia. Probabilmente, fu introdotto in Europa prima dai greci e successivamente dai romani, tramite le rotte commerciali che attraversavano il Medio Oriente. Presso i romani era considerato il simbolo degli innamorati, ma veniva usato anche come erba aromatica in cucina. Apicio lo nomina in una ricetta con i piselli. In Inghilterra lo incontriamo intorno al XVI secolo, mentre in America si dovrà attendere il XVII secolo prima di potere fare la sua comparsa.
Nel suo paese d'origine - l'India - l'impiego del basilico in cucina è piuttosto ridotto. Un tipo di basilico, l'Ocimum Sanctum - il famoso “Tulsi” - è considerata una pianta sacra dedicata a Vishn e Krishna, e i suoi semi sono utilizzati per la fabbricazione dei mala, sono consumati dalle persone che praticano una dieta vegetariana o aspirano a uno stile di vita più puro. Nell'ayurveda, la medicina tradizionale indiana, il basilico è utilizzato per la cura di molti disturbi. In India si usa piantare il basilico per vedere se verificare la salubrità di un terreno: la buona crescita della pianta battezza un luogo o un terreno come decisamente salubre. Si ritiene, inoltre, che la presenza del basilico, o meglio del Tulsi, può scacciare gli spiriti maligni e attirare le benedizioni divine. Le foglie vengono utilizzate durante le cerimonie religiose in favore di Vishnu, specialmente quelle in favore del benessere della famiglia. In India una pianta di basilico coltivata davanti casa, tiene lontano gli insetti pericolosi, ma un profondo conoscitore delle tradizioni indiane vi dirà che è sintomo della cultura e delle inclinazioni religiose della famiglia. Il terreno circostante la pianta, viene concimato solo con sterco di vacca, animale considerato sacro in India. Nelle case più ricche vengono coltivate diverse piante di tulsi, in modo da formare un piccolo boschetto sacro denominato tulsi-van o vrindavan. Le sacre scritture indù invitano a guardare il tulsi non come semplice pianta, ma come una rappresentazione naturale del dio Vishnu o Krishna. Chiunque abbia avuto occasione di fare un viaggio in India avrà certamente notato che moti fedeli utilizzano una serie di sferette di legno legate insieme da una funicella (Mala), e che ricordano i rosari cattolici: le palline sono fatte con i semi di una pianta sacra, il basilico indiano, i mala di tulsi. Per comprendere il rispetto che gli indù hanno per questa pianta, vale la pena spendere qualche parola, per ricordare che gli inglesi, quando volevano obbligare un indiano a giurare - e non avendo un equivalente alla Bibbia - lo facevano giurare sul tulsi. In Occidente il basilico è simbolo di fertilità. Boccaccio narra la storia di Lisabetta che, dopo aver nascosto la testa del suo innamorato dentro il terriccio di un vaso di basilico, lo innaffiava con le proprie lacrime. Di tutt'altro avviso è Van Helmont (1577-1644), dottore fiammingo, il quale sosteneva che il basilico lasciato tra due mattoni si trasformava in uno scorpione. Uso del Basilico Il basilico è una pianta annuale adatta a climi temperati e non sopporta il gelo. Può raggiungere un'altezza di 30-40 centimetri. Una caratteristica interessante e curiosa, è che il basilico, se coltivato in un ambiente avverso, tende a perdere le sue caratteristiche principali, diventa grasso e duro, perde il suo caratteristico profumo dolce e delicato per assumere toni forti e duri. A Genova - dove il basilico viene coltivato su vasta scala, in serre con temperature ed umidità tropicali - la raccolta viene fatta quando la pianta raggiunge un'altezza massima di dodici centimetri, in modo da ottenere il meglio delle caratteristiche organolettiche. I genovesi sono molto esigenti in fatto di basilico. In Liguria è tradizione coltivare il basilico in vasi di terracotta posti nei balconi delle case. Riassumendo: il basilico migliore è quello coltivato in condizioni di agio e consumato giovane. Non si possono fare paragoni tra l'aroma del basilico fresco e quello secco. Il basilico fresco può essere conservato per un breve periodo in frigorifero, ma il modo migliore per conservarlo è senz'altro a bagno nell'olio. Secondo la tradizione italiana, si prendono le foglioline di basilico lavate e asciugate, si sistemano su un vaso ricoperte da un pizzico di sale, quindi si procede, allo stesso modo, con uno strato successivo di basilico, una spolverata di sale, un altro strato di basilico e così via fino a riempire il vaso. Quando il vaso è pieno, lo si riempie con olio d'oliva fino a coprire il tutto, si chiude bene e si conserva in un luogo fresco o in frigo al riparo dalla luce diretta. Con questo sistema si può conservare il basilico per un tempo molto lungo senza perdere le sue qualità organolettiche, anche se con il passare del tempo le foglie tenderanno a diventare nere. Inoltre, il basilico conservato secondo questo sistema è ideale per preparare il pesto alla genovese. Il basilico non è certamente un ingrediente caratteristico della cucina nord europea. Per trovarlo bisogna andare verso sud, in Italia, in Grecia e nei paesi del Mediterraneo. L'impiego più affascinante del basilico in cucina, forse si trova nella preparazione del pesto genovese, che in varie espressioni, è tipico di tutta la riviera da Genova fin oltre confine, in Provenza, dove prende il nome di pistou. La ricetta del pesto prevede l'utilizzo di basilico, aglio, sale, olio d'oliva, pecorino sardo e/o parmigiano, pinoli o noci sbucciate, il tutto pestato in un mortaio fino a ottenere una salsa densa. Da notare che alcune varianti del pesto non prevedono l'uso dell'aglio. In Italia - dove ormai è conosciuto in tutte le regioni - viene utilizzato per condire la pasta, in particolare le “trenette”, ma anche sul riso e sui crostini. La diffusione su larga scala ha portato l'industria a offrire confezioni di pesto già pronto, naturalmente non comparabile al pesto fresco, ma forse è meglio accontentarsi piuttosto che rinunciarvi. Un prodotto tipico della Puglia è l'olio di basilico. L'olio viene aromatizzato in maniera naturale: in fase di spremitura, fatta rigorosamente con mezzi meccanici, insieme alle olive sono spremute anche delle foglie di basilico, donando all'olio un aroma fresco e intenso. L'olio al basilico viene utilizzato per condire piatti di pasta, pesce e insalate. Nella Francia meridionale il pistou viene usato nelle minestre. Sulla riviera italiana, si usava fare uno spuntino con un panino riempito con pomodoro, sale, olio d'oliva e qualche foglia di basilico: una preparazione certamente gustosa, ormai sostituita da sandwich, panini e tramezzini. Un panino con pomodoro, olio e basilico, è arricchito dai sapori e dai profumi degli ingredienti, sono diversi, sono essenze della terra, ogni stagione diversi e in ogni regione diversi. L'aroma del basilico si sposa bene con il pomodoro, e con qualunque piatto a base di pomodoro, con piatti a base di uova, come le frittate o le uova strapazzate, con le melanzane, il pesce - in particolare triglie e aragoste - e tante altre preparazioni. La fantasia e il gusto rappresentano, come sempre, il limite. In commercio si trovano anche foglie di basilico essiccate utilizzate nella preparazione di sughi, stufati e minestre. È buona abitudine aggiungere il basilico alle pietanze all'ultimo momento, poiché tende a perdere il suo caratteristico sapore. Alcuni cuochi evitano di sminuzzare le foglie con il coltello, preferendo di romprerle con le mani in modo da permettere agli olii essenziali di liberarsi più facilmente e sprigionare tutti i loro aromi. Oltre i confini dell'Europa, il basilico è utilizzato in Malesia (selaseh) e in India (babuitulsi). Esiste anche l'aceto di basilico, preparato lasciando macerare delle foglie di basilico in aceto di vino. L'utilizzo del basilico non si limita al campo culinario e religioso, ma anche in cosmesi, in erboristeria e in aromaterapia. In erboristeria viene usato come rimedio contro l'alito cattivo, la cattiva digestione, la tosse, il meteorismo, la cefalea nervosa e la cefalea da cattiva digestione. L'infuso delle foglie essiccate viene utilizzato negli stati febbrili, nella nausea e nei crampi addominali. L'olio di basilico è sconsigliato in caso di gravidanza, ai bambini sotto i sei anni, sulla cute particolarmente sensibile. Assunta a dosi elevate, per via interna, l'essenza di basilico può provocare effetti narcotici, per via esterna può avere un effetto irritante per le mucose. La pianta contiene un olio essenziale ricco di estragolo ed eugenolo, oltre che linalolo e terpeni. In cosmesi si usa come tonificante e deodorante: è sufficiente mettere 15 foglie di basilico in un sacchetto di cotone e aggiungerlo all'acqua del bagno. Come tonico per la pelle, alcune foglie di basilico e salvia macerate nell'alcol, successivamente diluito con acqua. Per i capelli, un infuso a base di basilico usato come lozione dopo lo shampoo. In aromaterapia è utilizzato come stimolante.
|
||||||||||||
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
| I punteggi delle acqueviti sono espressi secondo il metodo di valutazione di DiWineTaste. Fare riferimento alla legenda dei punteggi nella rubrica "I Vini del Mese" |
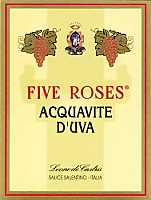
|
|
Acquavite d'Uva Five Roses |
|
| Leone de Castris (Puglia, Italia) | |
| (Distillatore: Bonollo) | |
| Materia prima: Negroamaro e Malvasia Nera | |
| Prezzo: € 24,00 - 50cl | Punteggio: |
| Quest'acquavite si presenta incolore, limpida e cristallina. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli di lampone, ciclamino, ciliegia e fragola con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca è intensa con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, nota dolce bilanciata. Il finale è persistente con ricordi di lampone, fragola e ciliegia. Questa acquavite è distillata in alambicchi a caldaiette di vapore. Alcol 40°. | |
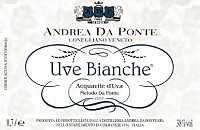
|
|
Uve Bianche |
|
| Andrea Da Ponte (Veneto, Italia) | |
| Materia prima: Malvasia Bianca e Chardonnay | |
| Prezzo: € 18,50 - 70cl | Punteggio: |
| Quest'acquavite si presenta incolore, limpida e cristallina. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati di uva, pera, mela, banana, ginestra e nocciola con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca è intensa con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, nora dolce bilanciata. Il finale è persistente con ricordi di uva e pera. Questa acquavite è distillata con alambicco discontinuo a bagnomaria. Alcol 38°. | |

|
|
Grappa di Nebbiolo di Carema |
|
| Revel Chion (Piemonte, Italia) | |
| Materia prima: Vinaccia di Nebbiolo | |
| Prezzo: € 13,40 - 50cl | Punteggio: |
| Alla vista è incolore, limpida e cristallina. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati di ciliegia, prugna, violetta, rosa, liquirizia, lampone e nocciola con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca è intensa con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, nota dolce bilanciata, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, lampone e prugna. Questa grappa è distillata con alambicco a caldaiette di vapore. Alcol 45°. | |

|
|
Liquore di Mirto |
|
| Lucrezio R (Sardegna, Italia) | |
| Materia prima: Bacche di Mirto | |
| Prezzo: € 10,00 - 70cl | Punteggio: |
| Alla vista si presenta con un colore rosso arancio intenso, limpido e cristallino. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli di mirto con pungenza dell'alcol impercettibile. In bocca è intenso con pungenza dell'alcol abbastanza percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, dolce, piacevole morbidezza con intenso sapore di mirto. Il finale è persistente con ricordi di mirto e accenni di dolcezza. Alcol 30°. | |
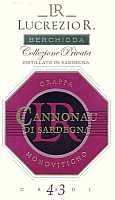
|
|
Grappa Cannonau di Sardegna Collezione Privata |
|
| Lucrezio R (Sardegna, Italia) | |
| Materia prima: Vinaccia di Cannonau | |
| Prezzo: € 20,00 - 50cl | Punteggio: |
| Questa grappa si presenta incolore, limpida e cristallina. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati di prugna, amarena, violetta, nocciola, liquirizia e lampone con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca è intensa con pungenza dell'alcol percettibile che tende a dissolvere rapidamente, piacevole morbidezza, nota dolce bilanciata. Il finale è persistente con ricordi di prugna, amarena e liquirizia. Questa grappa è distillata con alambicco discontinuo a bagnomaria. Alcol 43°. | |

|
|
Acquavite di Miele di Corbezzolo Selezione Speciale |
|
| Lucrezio R (Sardegna, Italia) | |
| Materia prima: Miele di Corbezzolo | |
| Prezzo: € 35,00 - 50cl | Punteggio: |
| Questo distillato di presenta incolore, limpido e cristallino. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti di miele di corbezzolo e cera d'api con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca è intenso con pungenza dell'alcol equilibrata e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, nota dolce bilanciata, molto piacevole. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di miele di corbezzolo. Prodotto dalla distillazione di miele di corbezzolo fermentato. Alcol 38°. | |
Wine Parade |
|
|
| I 15 migliori vini secondo i lettori di DiWineTaste. Per esprimere le vostre preferenze comunicate i vostri tre migliori vini al nostro indirizzo di posta elettronica oppure compilare il modulo disponibile nel nostro sito. |
| Posizione | Vino, Produttore | |
|---|---|---|
| 1 |
| Trento Talento Brut Riserva Methius 1998, Dorigati (Italia) |
| 2 |
| Colli Orientali del Friuli Rosazzo Bianco Terre Alte 2002, Livio Felluga (Italia) |
| 3 |
| Amarone della Valpolicella Classico 1998, Santa Sofia (Italia) |
| 4 |
| Riesling Central Otago 2004, Felton Road (Nuova Zelanda) |
| 5 |
| Aglianico del Vulture La Firma 2002, Cantine del Notaio (Italia) |
| 6 |
| Brunello di Montalcino 1999, Castello Banfi (Italia) |
| 7 |
| Palazzo della Torre 2000, Allegrini (Italia) |
| 8 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2000, Zenato (Italia) |
| 9 |
| Wine Obsession 2001, Vignamaggio (Italia) |
| 10 |
| Montepulciano d'Abruzzo Riparosso 2001, Illuminati (Italia) |
| 11 |
| Notarpanaro 1999, Taurino (Italia) |
| 12 |
| Chianti Classico Riserva Novecento 2000, Dievole (Italia) |
| 13 |
| Chablis Grand Cru Les Clos 2002, Domaine Billaud-Simon (Francia) |
| 14 |
| Rêve 2001, Velenosi Ercole (Italia) |
| 15 |
| Nero al Tondo 2001, Ruffino (Italia) |
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |