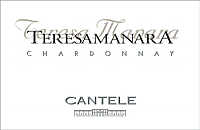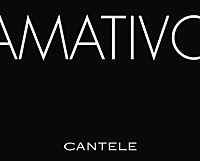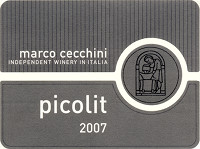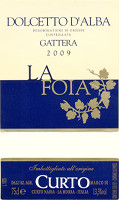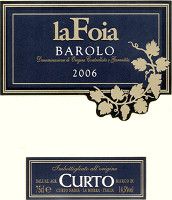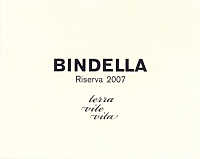|
La scena è consueta: si versa un vino nel calice e inizia un processo analitico
che, seppure con finalità diverse, ha comunque lo scopo di definire se quel vino
ci piace oppure no, se incontra il nostro gusto, le nostre aspettative, il
nostro consenso. Già detto altre volte, la degustazione sensoriale di un vino -
e di qualunque bevanda o cibo - ha diverse finalità, dal semplice piacere
personale alla valutazione critico-analitica per stabilire la corrispondenza a
un modello qualitativo o tipico. In ogni caso, indipendentemente dalle sue
finalità, la pratica della degustazione necessita della disponibilità di
strumenti idonei - o ritenuti tali a seconda del degustatore o della circostanza
- così da assicurare il conseguimento dell'obiettivo prefisso. Gli strumenti
della degustazione sono generalmente rappresentati da oggetti tangibili e
fisici. In realtà, questa attività richiede anche l'impiego di altri
“strumenti” che non hanno nulla in comune con il mondo fisico.
Degustare un vino - e lo stesso vale per ogni alimento o bevanda - non significa
versarlo semplicemente in un calice, quindi osservare, annusare, assaggiare.
Questi gesti, certamente fondamentali, costituiscono solamente una piccola parte
del processo che porta alla valutazione sensoriale del vino. Il risultato della
degustazione sensoriale è infatti determinato da una serie di fattori ed
elementi, ognuno indispensabile e determinante allo stesso modo. Il calice
sembra essere lo strumento principale con il quale si esegue la degustazione,
certamente il più importante fra gli strumenti tangibili. La forma del
calice è fondamentale per la corretta e opportuna valutazione delle qualità
organolettiche di un vino, non solo la forma, ma anche il materiale con il quale
è costruito. Privo di decorazioni, il calice deve essere trasparente e incolore
così da non alterare l'aspetto del vino, permettendo la sua corretta
osservazione, dalla limpidezza al colore e le sue sfumature.
La forma del calice, poi, determina in modo fondamentale la percezione degli
aromi del vino - risultato di precisi rapporti geometrici fra volume e
superficie di contatto - oltre a condizionare l'impatto iniziale del gusto e il
suo sviluppo. Non ci soffermeremo sulle qualità fisiche e meccaniche di un
calice, poiché in passato questo argomento è stato più volte trattato nelle
nostre pagine. Lo scopo di questo articolo è quello di considerare gli altri
aspetti che condizionano la degustazione sensoriale, in particolare quelli che
non hanno nessun legame con il “mondo fisico”, che riguardano l'atteggiamento
interiore e le qualità specifiche del degustatore. Se il calice è importante per
il corretto apprezzamento di un vino, allo stesso modo lo è l'umore del
degustatore, la sua esperienza, la concentrazione e la cultura, il modo di porsi
di fronte a un calice di vino.
Fra i fattori che attengono alla fisica della degustazione, si deve comunque
ricordare il fondamentale ruolo della temperatura alla quale il vino è
degustato. Questo fattore - com'è noto - ha la capacità di alterare la
percezione sensoriale di una bevanda o alimento, accentuando o attenuando sia i
profumi sia i sapori. A titolo di esempio, è sufficiente ricordare che
temperature troppo basse attenuano lo sviluppo - e quindi la percezione - degli
aromi, e quindi anche la percezione di aromi negativi e difetti, mentre le alte
temperature tendono a sviluppare in modo eccessivo la volatilità dell'alcol e,
nel complesso, a rendere il profilo aromatico del vino meno elegante. La
temperatura altera fortemente anche la percezione dei sapori. Sempre a titolo di
esempio, le alte temperature rendono i tannini meno astringenti, mentre quelle
basse tendono a esaltarne l'aggressività e la durezza. Il ruolo della
temperatura nella degustazione sensoriale, esattamente come i calici, è stato
già trattato in passato nelle pagine del nostro mensile.
|
 | |
| Calice, penna e taccuino: strumenti
utili al lavoro del degustatore | |
|
La degustazione sensoriale non si esprime solamente per l'accuratezza e la
precisione degli strumenti tangibili e fisici. L'esercizio della degustazione
sensoriale, che si basa prevalentemente dall'ascolto degli stimoli provocati da
fenomeni chimici, fisiologici e - non da ultimo - emotivi, necessita di una
serie di strumenti e condizioni che attengono prevalentemente
all'espressione interiore del degustatore. Condizioni e predisposizioni del
tutto intime - e che nessun strumento fisico può esprimere - ma che
rappresentano un valore aggiunto, probabilmente quello con il valore più alto.
Fra i principali elementi che appartengono a questa categoria troviamo
certamente il rispetto. Rispetto per il vino, la sua storia, la sua terra, le
sue uve, la sua personalità e - non meno importante - rispetto per chi quel vino
lo ha prodotto, frutto di una passione, di un'interpretazione e di un lavoro
svolto con dedizione. Troppo semplice giudicare con la pretesa di emettere
sentenze definitive e indiscutibili senza prima avere capito o compreso. Troppo
semplice, oltre che inutile.
La mancanza di rispetto, e il mondo della critica enologica è pieno di questi
casi, porta spesso a esprimere pareri del tutto presuntuosi, sentendosi in
diritto di potere demolire o esaltare il lavoro altrui semplicemente esprimendo
la propria opinione. Questo significa non rispettare gli altri e soprattutto,
credersi nella stupida posizione di chi si sente superiore agli altri - e
nessuno lo è - convinto che il proprio pensiero sia assoluto e inopinabile.
L'opinione di chi degusta e critica un vino non è certamente assoluta,
certamente frutto di una competenza professionale, ma di certo non esprime
l'opinione di tutti. Se un vino non è piaciuto, non significa che non è buono,
significa che non è piaciuto a chi lo ha degustato. E questo è molto diverso dal
denigrare il lavoro e la passione degli altri solo perché non incontra il nostro
pensiero o la nostra comprensione. Esiste certamente il diritto di esprimere il
proprio gradimento verso un vino, ma non si può pretendere che questo sia
condiviso, o condivisibile, da tutti, visto come una sentenza indiscutibile e
inappellabile.
Altro fattore fondamentale è il tempo. Non si può pretendere di giudicare in
modo attendibile un vino in pochi secondi o in pochi minuti. Ci sono degustatori
che affermano di valutare anche oltre cento vini al giorno, altri che vanno ben
oltre questa cifra. Confidando che questi degustatori facciano anche altro nel
corso della propria giornata - come tutti noi, del resto - e supponendo che il
tempo dedicato alla degustazione sia, mediamente, dieci ore al giorno, significa
degustare dieci vini all'ora, uno ogni sei minuti, senza pause. Si può
pretendere di esprimere un giudizio attendibile in soli sei minuti? Qualora
fosse possibile, c'è inoltre da considerare il notevole influsso dell'effetto
alone e della naturale stanchezza fisiologica dei sensi quando sollecitati per
lungo tempo senza opportune pause. Ci sono vini che si concedono immediatamente
- a volte riservano anche buone sorprese quando si ha la pazienza di farli
parlare a lungo - e altri più riservati e timidi, che chiedono più tempo per
raccontare la loro storia. Con il vino non è mai saggio avere fretta.
Con il vino si deve avere la predisposizione all'ascolto, quella sana curiosità
di conoscere chi si ha davanti, con i suoi pregi e i suoi difetti. In un calice
di vino non troveremo mai solamente un liquido variamente colorato, risultato
della fermentazione del succo d'uva. Quando si stappa una bottiglia e si versa
il contenuto nel calice, non si versa solamente del vino, si versa una storia,
il racconto di un'intera stagione, di sole e di pioggia, di fatiche e di
speranze, il rinnovato rapporto fra uomo e terra, fra uomo e vite. «Il
vino è il canto della terra verso il cielo» diceva Luigi Veronelli. In queste
parole si concentra tutta la forza del vino, una bevanda dal forte significato
per la storia dell'uomo e del suo rapporto con la terra, la sua terra. Anche per
questo motivo, l'assaggio di un vino non può risolversi in pochi minuti, proprio
perché nel vino - quello che avete nel vostro calice - c'è molto più di una
bevanda frutto della fermentazione del succo d'uva.
La degustazione sensoriale è una pratica che richiede inoltre dedizione e
concentrazione, condizioni che si possono ricondurre - in un certo senso - al
rispetto che di deve al vino, alla sua terra e a chi l'ha prodotto. Se si
assaggia un vino in modo disattento non si può certo pretendere di potere
conoscere quel vino - o, peggio, esprimere un parere - in modo attendibile e
concreto. Sarebbe come affermare di conoscere bene una persona dopo averci
parlato o essere stati in sua compagnia per pochi minuti, magari guardando
altrove o parlando al telefono. La degustazione è un esercizio totale che
coinvolge completamente il degustatore, non ammette disattenzioni, non ammette
atteggiamenti superficiali o, peggio, supponenti. Si deve avere sempre un
atteggiamento di sana curiosità, con la volontà di conoscere qualcosa di nuovo,
senza pregiudizi, consentendo al vino di raccontare la sua storia fino in fondo.
A questo proposito, va detto che ci sono vini - esattamente come le persone -
che sfoggiano grandi doti e qualità, che sanno ben ammaliare chi li ascolta, che
sanno usare le parole giuste sin dall'inizio del dialogo, così da impressionare
positivamente chi li sta ascoltando. Questo, in realtà, è un ulteriore motivo
per dedicare tempo all'assaggio del vino, così da “costringerlo” a parlare a
lungo, per poi scoprire se quello che dice è vero oppure si tratta di deludente
finzione. E lo stesso vale per i vini che si mostrano “timidi”, quelli che non
si concedono subito e che hanno appunto bisogno di tempo per “aprirsi” e
prendere confidenza con chi ha deciso di ascoltare la loro storia. Inoltre, il
nostro umore influisce notevolmente con la volontà e con la predisposizione
all'ascolto. Questo vale con le persone e allo stesso modo con il vino. Quando
siamo di cattivo umore, la nostra predisposizione all'ascolto costruttivo è
decisamente alterata e pertanto sarebbe bene evitare l'assaggio del vino con
finalità critiche o per motivi di studio.
Per diventare dei bravi degustatori si deve degustare continuamente, si deve
praticare molto, con dedizione, passione e concentrazione. Non c'è altra strada.
E più si degusta e più si affinano quelle indispensabili qualità che alla fine
rappresentano un'enorme differenza: memoria ed esperienza. Queste due qualità
sono indispensabili alla comprensione di un vino, permettono di discernere e
comprendere la qualità vera da quella che non è, o - al limite - che appare
tale. Un vino buono si riconosce come tale proprio per il fatto di avere
assaggiato vini buoni; pertanto è molto utile assaggiare anche vini cattivi.
Certo, esiste anche il gusto personale, ma la qualità oggettiva la si può
valutare solo se si hanno parametri di confronto, basati sulle esperienze
passate. La memoria, altro fattore fondamentale, consente di confrontare vini
appartenenti allo stesso territorio o tipologia così da stabilirne una
corrispondenza alla tipicità. Un profumo o un sapore hanno il potere di
richiamare alla mente situazioni, momenti ed esperienze. Nel caso del vino,
questo richiama alla mente altri vini assaggiati in precedenza, attivando
l'utile esercizio della comparazione e dell'apprendimento.
Come già detto, degustare un vino non significa solamente versarlo nel calice e
analizzarlo attraverso i propri sensi. Dietro ogni vino c'è la storia di un
territorio, di una cultura, dell'espressione della vite in un determinato luogo.
Questi fattori sono imprescindibili dal vino. Se si vuole veramente comprendere
un vino, è fondamentale conoscere il territorio dal quale nasce, proprio perché
ogni territorio è un mondo a sé al quale si aggiunge il fattore parimenti
importante dall'opera dell'uomo e del suo modo di interpretare quel territorio e
le sue uve. Per questo motivo non esistono due vini veramente uguali, nonostante
ne esistano tanti simili, non per colpa del territorio ma delle mode che si
seguono per motivi di mercato. Si dovrebbe più spesso ricordare che quando si ha
davanti un calice, non si degusta solamente il vino, ma soprattutto il
territorio e l'espressione di un determinato momento e stagione che, come tale,
è irripetibile e unico. Proprio perché ogni vino è unico e irripetibile, si
dovrebbe fare di questo concetto uno dei principali strumenti del degustatore.
Se si vuole davvero capire. E per capire serve innanzitutto il rispetto.
|