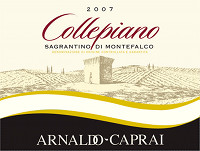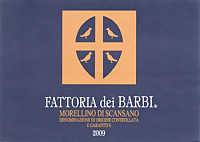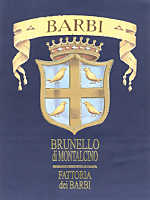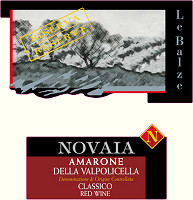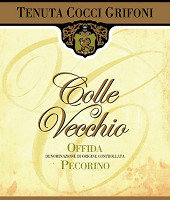|
I vini fortificati, conosciuti anche come vini liquorosi, hanno scritto pagine
memorabili della storia, non solo di quella enologica. Questi vini hanno infatti
contribuito alla storia e allo sviluppo commerciale del 1800, oltre a legare il
proprio nome a successi militari, vini prediletti per la celebrazione di grandi
momenti della società. Basti pensare, per esempio, alla storia del Marsala - uno
dei più grandi vini d'Italia - vino per il quale nacque un florido commercio,
protagonista di agguerrite competizioni commerciali. Vino di lunghissima e
gloriosa storia, il Marsala era il vino prediletto dell'ammiraglio Orazio
Nelson, che lo definì victory wine - il vino della vittoria - anche in
occasione della celebre battaglia di Trafalgar del 1805, nella quale conseguì il
suo ultimo successo bellico. Destino del tutto analogo fu vissuto anche dagli
altri gloriosi e pregiati vini fortificati, ancora oggi rappresentanti di
straordinaria espressione enologica, come Jerez - noto anche con il nome di
“Sherry” - Porto, Madeira e Malaga.
La predilezione dell'ammiraglio Nelson per il Marsala fu tale che, dopo avere
assaggiato questo vino per la prima volta, ne ordinò ben 500 barili da portare a
bordo. Il successo del Marsala - e degli altri vini fortificati di Spagna e
Portogallo - fu tale che dai porti delle rispettive città di produzione
salpavano continuamente navi cariche di preziosi barili, delle quali la
maggioranza destinate in Inghilterra. Non solo, alcune celebri famiglie di
mercanti inglesi si trasferirono addirittura nei luoghi di produzione avviando
loro stessi cantine per la produzione, come nel caso dei Woodhouse e Ingham a
Marsala, oppure i Dow, Graham e Taylor a Porto. Stessa sorte per il celebre vino
fortificato spagnolo - il Jerez - poiché molte della cantine dedite alla
produzione di questo vino furono fondate da famiglie di mercanti inglesi. Jerez
è il nome con il quale la famosa città Andalusa e il suo vino sono oggi
conosciuti nel mondo, tuttavia nei paesi di lingua inglese, il vino è ancora
noto con lo storico nome “Sherry”, termine che deriva da “Sherish”,
nome con il quale la città si chiamava ai tempi del dominio dei Mori.
I vini fortificati sono caratterizzati da un particolare elemento produttivo,
comune a tutti i vini appartenenti a questa categoria. Si dice
fortificato un vino al quale si aggiunge, in un particolare momento della
produzione, una certa quantità di acquavite di vino con lo scopo di aumentare
la gradazione alcolica. In Italia, questo stile è definito anche con il termine
liquoroso, categoria che non va assolutamente confusa con la definizione
liquoreux dei francesi, termine con il quale in Francia si identificano i
vini dolci e da dessert, come per esempio il Sauternes. In Francia, i vini
fortificati prendono il nome di Vin de Liqueur. L'aggiunta di alcol, in
verità, produce anche altri effetti in accordo alla tradizione produttiva di
ogni singolo vino, non da ultimo, contribuisce efficacemente alla sua
conservazione. Il volume alcolico di questi vini può arrivare al 20%, in
alcuni casi raggiungere perfino il 22%, e, in accordo alle leggi comunitarie,
non può avere un titolo alcolico inferiore al 12%.
Dal punto di vista storico, l'alcol si aggiungeva ai vini per consentire loro di
“sopravvivere” alle fatiche del viaggio in mare, collocati in barili sulle
stive delle navi, così da farli arrivare al porto di destinazione ancora
bevibili e sani. La stiva dei velieri di duecento anni fa non era certamente
l'ambiente più asettico e accogliente che il vino potesse avere, ragione per la
quale - complici anche le condizioni meteorologiche e, in estate, l'alta
temperatura - il vino subiva delle notevoli trasformazioni, tanto da renderlo
non proprio piacevole. La destinazione più frequente del commercio
marittimo dei vini era l'Inghilterra - una consuetudine che già la storia
registra sin dai tempi degli antichi romani - mentre le stive delle navi
venivano caricate a migliaia di chilometri di distanza, prevalentemente nei
paesi del bacino del Mediterraneo. Viaggi dalla durata di settimane, tempo
durante il quale il vino subiva delle sostanziali alterazioni.
|
 | |
| Il colore dei vini fortificati
maturi: a sinistra, il Marsala Vergine, a destra, il Porto | |
|
I mercanti pensarono quindi di aggiungere ai barili acquavite di vino e, grazie
alle capacità antisettiche dell'alcol, riuscivano in questo modo a limitare
fortemente i danni che inevitabilmente erano procurati dal viaggio. Questa
pratica modificava inevitabilmente le qualità organolettiche del vino,
aggiungendo una nuova dimensione che incontrò da subito il favore delle classi
abbienti inglesi. Ma anche il favore di ammiragli e marinai, poiché ci si poteva
concedere una bevanda “corroborante” e inebriante, senza ricorrere all'uso dei
ben più alcolici distillati. L'abitudine di aggiungere l'acquavite a questi vini
divenne così fortemente legata alle loro qualità organolettiche e alla loro
produzione, tanto che ancora oggi sono difficilmente immaginabili senza la
tipica fortificazione. Come nel caso del Marsala, vino dal carattere ossidato e
complesso e che prima della sua scoperta “commerciale” da parte di John
Woodhouse, si produceva con il metodo del perpetuo e non era prevista
nessuna fortificazione.
Pare che per la produzione del vino Porto, nello stile che lo conosciamo oggi,
si sia sempre utilizzata l'acquavite, tecnica probabilmente utilizzata
all'interno di alcuni monasteri. La leggenda narra infatti che due mercanti
inglesi, alla ricerca di nuovi vini portoghesi da spedire nel loro paese,
giunsero in un monastero nei pressi di Lamego, e qui un monaco offrì loro un
vino dolce e fortemente alcolico. Allo stupore dei due commercianti, il monaco
disse loro che quel vino era stato prodotto aggiungendo acquavite al mosto in
fermentazione così da conservare la naturale dolcezza. Era la fine degli anni
1670 e il mondo e l'Inghilterra scoprirono quindi il glorioso vino Porto: non
proprio un vino; piuttosto un mosto fortificato al quale la magia del tempo
conferisce eleganza e qualità assolutamente uniche. Alla produzione dell'altro
grande vino fortificato - il Jerez, o Sherry - si deve l'intuizione del metodo
della Solera y Criaderas, metodo oggi impiegato anche nella produzione di
altri vini e, non da ultimo, di distillati, come lo straordinario brandy di
Jerez.
Anche il vino Madeira, prodotto nelle omonime isole portoghesi dell'oceano
Atlantico, ha una storia particolare da raccontare, una caratteristica che lo
rende assolutamente unico rispetto a tutti gli altri vini fortificati. Ciò che
caratterizza il Madeira è infatti il particolare processo di produzione, o - per
meglio dire - una particolare fase del processo di produzione. Il Madeira è
infatti sottoposto a un processo di “cottura” detto estufagem e che
consiste nel mantenere le botti dove matura il vino a una temperatura che
talvolta raggiunge anche i 55°C. Questo processo cerca di “imitare” quello che
accadeva nelle stive delle navi nei secoli passati, durante il suo trasporto,
quando le botti erano sottoposte al caldo clima tropicale. Si comprese infatti
che la “tortura” tropicale alla quale il Madeira era sottoposto fosse il
principale responsabile della particolare personalità del vino. Poiché il
Madeira non viaggia più nelle stive delle navi - ma ben consapevoli di quanto
quel viaggio fosse utile alle qualità del vino - oggi si cerca di “simulare”
il clima tropicale direttamente in cantina, sottoponendo il vino a una
temperatura e un'umidità quanto più simile a quelle delle stive dei velieri che
lo trasportavano nei porti del mondo.
Una caratteristica comune a molti vini fortificati è l'evidente aroma prodotto
dalla notevole ossidazione subita durante la maturazione. Questa caratteristica
è sempre considerata un difetto grave nella totalità dei vini; per i vini
fortificati diviene invece un pregio. Non è un caso che nei vini da tavola,
quando si percepisce un'evidente ossidazione, si dice che il vino è
maderizzato, proprio perché ricorda il profumo del vino Madeira. Questo
“difetto” è anche definito in Italia come marsalato, proprio perché
ricorda, appunto, il vino Marsala. Questo particolare aroma, che ricorda in
parte quello della nocciola tostata, sia al naso sia in bocca, è definito dai
produttori e dagli estimatori del Jerez con il termine spagnolo rancho.
Va detto che il termine rancho non si riferisce unicamente all'effetto
dell'ossidazione, ma anche - e soprattutto - all'effetto della particolare
tecnica di produzione del Jerez.
Le botti nelle quali questo vino matura sono volutamente lasciate scolme,
procedura che favorisce non solo l'ossidazione ma anche lo sviluppo sulla
superficie del vino di una particolarissima coltura di lieviti che prende il
nome di flor. Lo sviluppo del flor non è comunque caratteristica
esclusiva del vino di Jerez. Questa particolare coltura di lieviti è infatti
fondamentale per la produzione di uno dei grandi vini di Sardegna, la Vernaccia
di Oristano, che - va detto - è un vino bianco che non subisce nessun processo
di fortificazione. Il contenitore usato per la maturazione dei vini fortificati
è, nella totalità dei casi, la botte. I vini fortificati sono lasciati maturare
in legno, non tanto per conferire loro le tipiche qualità organolettiche
associabili a questi contenitori, piuttosto per favorire l'ossidazione, più o
meno forte, qualità assolutamente tipica di questi vini. Va inoltre detto che, a
differenza di quanto accade nella produzione di vini da tavola, per i quali le
botti sono generalmente sostituite ogni tre o quattro anni così da ripristinare
l'influsso organolettico del legno, nei vini fortificati le botti sono raramente
sostituite.
La botte usata rappresenta infatti un alto patrimonio per i vini fortificati,
non solo per il fatto che i pori del legno sono più “aperti” - favorendo
quindi l'ossidazione - ma anche per il fatto che è fortemente impregnata del
vino prodotto in annate precedenti e delle sue qualità organolettiche. Il tipico
carattere conferito dal legno sarà comunque presente anche nei vini fortificati,
tuttavia, a differenza di altri vini, in questo caso all'impatto terziario
costruito dal legno, si unisce l'enorme complessità regalata dal tempo e
dall'ossidazione. Va comunque detto che, proprio per mantenere la loro tipica
personalità, nei vini fortificati il carattere del legno difficilmente svolge la
parte del protagonista. Definire infatti il profilo aromatico dei vini
fortificati è un esercizio estremamente complesso, probabilmente fra i più
impegnativi per i sensi del degustatore. Le loro qualità aromatiche sono infatti
molto distanti da quello che si trova solitamente nei vini da tavola, talvolta
esprimibili con descrittori che, all'apparenza, non hanno nulla in comune con il
vino.
Questa complessità aumenta notevolmente con il tempo, poiché - è bene ricordarlo
- i vini fortificati possono maturare in bottiglia per decine di anni grazie
all'alto volume alcolico, elemento che preserva questi vini dal decadimento e
dalla contaminazione batterica. Parlare di vini fortificati maturi pone di
fronte a un totale cambiamento dei termini di confronto rispetto agli altri
vini. In molti casi, sono i produttori stessi a immettere sul mercato vini
fortificati già maturati in cantina per molti anni, anche oltre 10 anni, un
tempo che spesso rende decrepiti molti vini da tavola. In alcuni casi, il tempo
di maturazione è impossibile da determinare a causa del metodo di produzione,
che può prevedere l'aggiunta di annate molto vecchie, come nel caso del Jerez -
prodotto con il sistema del Solera y Criaderas - e che per questa ragione
non si indica mai il millesimo. Grazie a queste lunghe maturazioni, i vini
fortificati offrono un'estrema complessità già al momento della loro
commercializzazione. Note di frutta tostata e secca, fiori secchi e frutta
candita, sono solamente alcuni degli aromi che troviamo nei vini fortificati. A
questi si uniscono aromi di notevole complessità, dei quali i principali
responsabili sono l'ossigeno e l'ossidazione.
Un vino lungamente maturato, non solo, ma anche ossidato, potrebbe fare pensare
a un profilo gustativo del tutto squilibrato, perfino piatto. In realtà i vini
fortificati, soprattutto quelli secchi, offrono al palato un equilibrio
impeccabile, nel quale la morbidezza e l'alto volume alcolico trovano un
perfetto equilibrio con l'acidità, nel caso dei vini bianchi, e una levigata
astringenza, nel caso dei vini rossi. Il mondo dei vini fortificati è
estremamente vasto, offrendo al degustatore un'ampia varietà di stili:
dall'estremamente secco, come il Jerez Fino o il Marsala Vergine, fino a stili
estremamente dolci, come il Jerez Pedro Ximénez e alcuni stili di Porto. Altra
caratteristica dei vini fortificati è l'apprezzabile persistenza
gusto-olfattiva, generalmente molto buona e lunga, così come l'esplosione di
sapori, sempre di notevole intensità. Con il tempo, e questo significa decine di
anni, i vini fortificati assumono un carattere più “pacato” e “austero”,
lasciando spazio a una maggiore morbidezza, spesso vellutata, senza mai perdere
la loro impeccabile eleganza ed equilibrio.
|