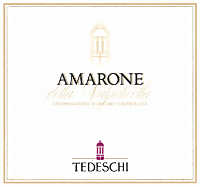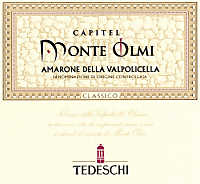|
La degustazione sensoriale è una pratica molto importante per la conoscenza e la
comprensione del vino. Un concetto già espresso più volte in queste pagine,
ribadito anche in questa circostanza. Questo non significa che l'apprezzamento
di un vino si possa compiere unicamente attraverso una rigorosa pratica di
degustazione, poiché l'apprezzamento - nelle sue diverse forme - è soprattutto
una questione puramente soggettiva. Un vino può essere certamente apprezzato
anche in un contesto informale e spensierato, in compagnia di amici apprezzando
anche l'occasione e il momento in sé, sempre ammesso che lo si faccia nella
moderazione e mai nel deprecabile abuso. Quando si affronta la degustazione
sensoriale del vino, in modo analitico e critico, è comunque necessario
abbandonare lo stato emotivo tipico delle situazioni informali e spensierate.
Condizione fondamentale è infatti lo stato di isolamento dai fattori
esterni tali da disturbare la concentrazione e l'attenzione verso il contenuto
del calice.
Lo svolgimento della degustazione sensoriale è, senza ombra di dubbio,
l'attuazione di metodi codificati e tecniche specifiche con lo scopo di valutare
e determinare le caratteristiche e le qualità di un vino. È bene ricordare che
la valutazione sensoriale non è una disciplina che riguarda unicamente il vino,
ma qualunque elemento - quindi non solo cibo e bevande - che hanno la proprietà
di stimolare i sensi, qualunque tipo di senso. L'esercizio della degustazione
sensoriale, benché sia costituita in larga parte da fattori tecnici, non si
realizza unicamente con l'analisi degli elementi interessati alla definizione e
alla costituzione del risultato. La tecnica, qualunque tecnica, necessita di tre
condizioni specifiche affinché questa possa risultare utile e produrre risultati
concreti e tangibili. Innanzitutto, è necessario conoscere la tecnica, i fattori
e le modalità che la costituiscono, pertanto - passo fondamentale - è necessario
comprenderla. La comprensione implica quindi la condizione di possedere
requisiti e competenze tali da consentirne l'apprendimento e la comprensione.
Dopo avere appreso e compreso la tecnica, nella sua forma teorica, è
indispensabile possedere la capacità di rendere il concetto teorico nella sua
forma pratica, cioè la capacità di sapere utilizzare i concetti appresi in
relazione alla circostanza reale di impiego. A titolo di esempio, per quanto
concerne il vino, la tecnica della valutazione gustativa si basa sui medesimi
principi teorici, tuttavia la loro applicazione differisce a seconda dello stile
di vino da esaminare. La valutazione e la determinazione dell'equilibrio di un
vino, per esempio, cambia radicalmente nel caso di un vino bianco o di un vino
rosso. Infine, la capacità di sapere determinare i risultati e, quindi, saperli
interpretare in modo da ottenere informazioni e modelli di riferimento
consistenti e definiti. Questo ultimo aspetto, che di fatto rappresenta lo scopo
primario della tecnica e della sua attuazione, consentirà non solo di definire e
valutare il campione esaminato, ma anche - e soprattutto - poterlo confrontare
con altri campioni così da evidenziare le differenze e le peculiarità di ognuno.
L'apprendimento e la comprensione delle tecniche, come già detto, si realizza
grazie alla preliminare conoscenza degli elementi ai quali la tecnica fa
riferimento. In altre parole, per comprendere l'aritmetica e la matematica, è
indispensabile sapere cosa siano i numeri. Allo stesso modo, per potere
degustare in modo proficuo il vino, è indispensabile sapere cos'è il vino, quali
sono gli elementi e le condizioni che influiscono sulla produzione e, non meno
importante, come questo si produce. Sapere degustare il vino non significa
essere enologo, vitivinicoltore o agronomo, allo stesso modo, essere enologi,
vitivinicoltori o agronomi non significa essere degustatori. È comunque
indispensabile per un enologo conoscere la degustazione sensoriale del vino - il
suo lavoro è, appunto, produrre l'elemento fondamentale oggetto della
degustazione - certamente non è indispensabile per un degustatore essere
enologo. Questi ruoli hanno evidentemente finalità molto diverse, ma è
innegabile che un buon degustatore debba avere una conoscenza, non superficiale,
dell'enologia e della viticoltura.
|
 | |
| Per la degustazione sensoriale del vino,
oltre al calice e alla tecnica, serve anche conoscenza e strategia | |
|
La degustazione sensoriale non è comunque una pratica per la quale
l'improvvisazione, peggio, la superficialità, consentono di ottenere risultati
apprezzabili, ma è comunque innegabile che curiosità, innata predisposizione e
talento, siano elementi di notevole valore. Se è vero che per comprendere e
usare proficuamente le tecniche della degustazione sensoriale sia fondamentale
la conoscenza del vino e della sua produzione, è parimenti importante conoscere
gli strumenti che consentono la sua applicazione, come il calice e gli organi di
senso. Oltre a questi, è fondamentale comprendere il ruolo dei fattori fisici e
ambientali che influiscono fortemente sulla percezione dei singoli stimoli,
come, ad esempio, la temperatura del vino e dell'ambiente. Un vino rosso,
degustato alla temperatura di 10 °C, porterà a un risultato ben diverso dalla
degustazione svolta alla temperatura di 18 °C. Risultato che è ulteriormente
condizionato dalle qualità specifiche del vino, come per esempio, la sua
astringenza, acidità e volume alcolico.
La pratica della degustazione sensoriale coinvolge inevitabilmente altre
discipline e competenze. Non basta conoscere le tecniche che consentono la sua
realizzazione, si deve - fra l'altro - avere cognizione, non certo in modo
superficiale, della fisiologia del gusto e dei sensi, delle caratteristiche
delle uve, del ruolo dell'ambiente e delle condizioni viticolturali, pratiche
viticole ed enologiche e come queste possono influire sulla produzione in
funzione di tutti gli altri elementi. Per esempio, la stessa uva può produrre
risultati estremamente diversi a seconda del luogo e della condizione dove
questa è coltivata, dalle pratiche viticolturali adottate nel corso della
stagione, dalle condizioni meteorologiche e, infine, da come è stata lavorata
durante la produzione. Il Cabernet Sauvignon, uva notoriamente capace di
produrre vini di buona struttura e dal colore intenso e cupo, può anche dare
vini di corpo medio, con un colore scarico e una trasparenza elevata, quando
coltivato in luoghi non adatti e con rese elevate.
Lo studio delle materie ausiliarie relative all'enologia e alla vitivinicoltura
- in ogni caso, da considerarsi fondamentali - sono di estrema importanza per
qualunque degustatore. La comprensione delle qualità e delle caratteristiche di
un territorio e delle sue uve, trova nella pratica della degustazione
sensoriale, il primario strumento di studio. Lo stesso è parimenti vero per
qualunque altra disciplina legata al vino: attraverso la degustazione sensoriale
è possibile verificare e valutare le diverse tecniche colturali ed enologiche,
comprese le condizioni ambientali, ampelografiche e meteorologiche. Questo
ultimo aspetto, trova la massima efficacia soprattutto nella degustazione
comparativa, ponendo a confronto vini prodotti con le stesse uve ma coltivati e
prodotti in territori diversi. Allo stesso modo, è estremamente utile comparare
vini dello stesso produttore appartenenti ad annate diverse, così come un vino
della stessa annata e appartenente allo stesso territorio e stile, ma prodotto
da cantine diverse.
Questi ultimi due esempi, sono rispettivamente definiti degustazione
verticale e degustazione orizzontale. A questo si dovrebbe aggiungere -
per completezza - la cosiddetta degustazione diagonale, che consiste
nella valutazione comparativa di vini appartenenti allo stesso stile e
territorio, ma prodotti in annate diverse e da produttori diversi. La
degustazione diagonale, di fatto, non offre opportunità di studio concrete,
poiché la diversità degli elementi che costituiscono il vino, stile e territorio
a parte, non consentono di definire un modello consistente di studio. Lo
svolgimento e l'utilità delle degustazioni comparative - indipendentemente dal
tipo - trova in ogni caso beneficio e vantaggio dallo studio e dalla conoscenza
preliminare degli elementi caratteristici dei vini da degustare. In altre
parole, se i vini da comparare sono tutti prodotti con uve coltivate in suoli
prevalentemente sabbiosi, il colore che si osserverà nel calice sarà decisamente
più scarico rispetto alle stesse uve coltivate in suoli argillosi.
Il tempo e la pratica offrono al degustatore uno strumento di inestimabile
valore, qualcosa che va ben oltre la comprensione e l'uso delle tecniche. Fra
questi, due fattori in particolare risultano fondamentali per lo svolgimento
proficuo della degustazione: la memoria e l'esperienza. In entrambi i casi, la
loro formazione non è favorita dallo studio, per così dire, puramente teorico
delle materie, ma dalla pratica svolta con dedizione e profitto. Esercitarsi
continuamente nella pratica della degustazione sensoriale è - di fatto -
l'aspetto di maggiore importanza, non solo per mantenere allenati i propri
sensi, ma soprattutto per acquisire nuovi elementi tali da accrescere la propria
esperienza e conoscenza. L'esperienza e la conoscenza sono presupposti che
implicano una buona memoria: esercitarsi senza imparare - quindi ricordare -
cosa si è fatto e cosa di è percepito in un vino, rende vana l'utilità della
degustazione ai fini della propria formazione.
Per questo motivo, validi alleati del degustatore sono la carta e la penna.
Prendere nota di tutte le degustazioni svolte, cosa si è percepito, i commenti e
le impressioni sull'esame sensoriale e come i singoli elementi interagiscono fra
loro, consentirà al degustatore di creare la propria preziosissima memoria
storica. Trascrivere le proprie impressioni e le sensazioni percepite durante la
degustazione, non è comunque l'unico tipo di memoria della quale il degustatore
può trarre vantaggio. Esiste infatti un tipo di memoria che, per sua natura, non
trova piena efficacia nella descrizione e nella trascrizione: la memoria
sensoriale e, in particolare, la memoria olfattiva. Ricordare un profumo, una
sfumatura, ed essere capaci di eseguire una rapida associazione con un vino
specifico, oppure un territorio, uva, pratica enologica o ambiente, rappresenta
uno strumento di enorme valore per ogni degustatore. Questa capacità si ottiene
sia mediante il talento personale, ma anche - e soprattutto - dalla pratica e
dall'allenamento, infine, da un buono stato di concentrazione.
La concentrazione è condizione fondamentale per trarre il massimo vantaggio
dalla degustazione sensoriale, non solo per l'apprendimento delle tecniche e il
miglioramento della conoscenza relativa al vino da esaminare, ma anche, in modo
particolare, per la determinazione di un risultato affidabile e attendibile. Per
questo motivo, la proficua pratica della degustazione sensoriale prevede
l'attuazione di condizioni ambientali tali da favorire la concentrazione senza
interferenze o elementi di disturbo. La concentrazione si ottiene, oltre a
condizioni ambientali favorevoli, dallo stato mentale del degustatore, da uno
stato di rilassamento, cercando di non permettere ai propri pensieri - negativi
o positivi che siano - di interferire con la valutazione e, quindi,
l'affidabilità del lavoro svolto. Parimenti, la presenza di elementi sensoriali
di disturbo, come profumi e odori nell'ambiente di degustazione, fare uso di
profumi e deodoranti, avere consumato cibi e bevande di recente, costituiscono
elementi di disturbo, non solo per la concentrazione ma anche per la percezione
degli stimoli sensoriali.
Ogni degustatore, con la pratica e con il tempo, sviluppa metodi e strategie
personali, tali da rendere il lavoro della degustazione il più proficuo
possibile. Ogni fase della degustazione, oltre all'impiego delle tecniche, si
avvale di un personalissimo metodo di svolgimento, in modo particolare nella
valutazione e nel riconoscimento dei profumi di un vino. In questo senso, la
consapevolezza degli elementi identificati nella fase dell'esame visivo,
consentono al degustatore di attuate metodi e strategie specifiche per ogni
stile di vino. La vista di un vino rosso, per esempio, predispone il degustatore
verso un approccio analitico diverso da quello utilizzato per i vini bianchi o
per i vini spumanti. La fase più complessa della degustazione sensoriale è
certamente quella olfattiva, oltre che essere la più interessante. Avere una
strategia nella ricerca dei profumi - inclusa la memoria - consente di
velocizzare l'intero processo. A titolo di esempio, è molto più proficuo
iniziare con l'identificazione della famiglia di appartenenza dello stimolo
olfattivo - come fiori, frutti, vegetali o terziari - anziché concentrarsi sul
riconoscimento specifico di un profumo. Lo stesso è vero anche per l'analisi
gustativa e per la corrispondenza gusto-olfattiva.
|