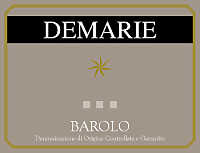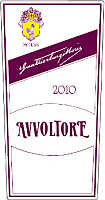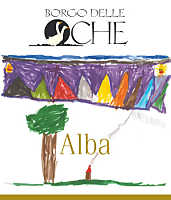|
Le sostanze acide presenti nel vino determinano in modo sostanziale il suo
profilo gustativo. L'acidità è elemento fondamentale a partire dal suo
luogo d'origine - gli acini dell'uva - che fornisce la maggiore quantità
di elementi acidi che saranno poi presenti nel vino. La produzione della
bevanda di Bacco introduce altre sostanze acide al vino, in particolare durante
la fase della fermentazione. La variazione dell'acidità può avvenire anche dopo
il termine della fermentazione, soprattutto nei casi di cattiva conservazione
del vino. Nella giusta quantità, l'acidità rappresenta un elemento fondamentale
e pregevole, non solo per il raggiungimento del giusto equilibrio, ma anche per
contribuire alla complessità del gusto del vino. Stimolo gustativo che si
contrappone agli stimoli gustativi morbidi e rotondi, la mancanza
dell'acidità determina sempre un profilo gustativo piatto e privo di carattere.
L'importanza delle sostanze acide nella produzione di vino inizia dalla vigna.
La quantità di elementi acidi all'interno dell'acino dell'uva contribuisce, per
esempio, a determinare il periodo di vendemmia. Il caso più significativo nel
quale l'acidità è fattore determinante in enologia, è la produzione dei vini
spumanti. In questo caso specifico, il livello di acidità presente nell'uva al
momento della vendemmia è infatti prioritario rispetto allo zucchero, così da
supportare propriamente uno degli aspetti principali di questi vini: la
freschezza. Rispetto ai vini da tavola, nei quali la quantità di zucchero è
utile anche alla produzione di alcol etilico, nel caso specifico della
dolcezza, negli spumanti questa deve essere piuttosto contenuta. Va infatti
ricordato che durante il processo di spumantizzazione - operazione che prevede
una seconda fermentazione del vino - si otterrà un'ulteriore produzione di
alcol etilico.
Prima di comprendere l'influsso dell'acidità nel gusto del vino, è opportuno
ricordare il suo ruolo e la sua natura in ambito enologico. Dal punto di vista
tecnico, la presenza di sostanze acide nel vino si misura in termini di
acidità fissa, acidità volatile e acidità totale,
quest'ultima determinata dalla somma delle prime due. Dal punto di vista
quantitativo, l'acido maggiormente presente nel vino è quello tartarico, detto
anche acido dell'uva, nonostante questo si trovi in molte piante e
frutti, in particolare nel tamarindo. L'acido tartarico, oltre che essere
quello principale del vino, è anche la sostanza responsabile del carattere di
freschezza che si riconosce generalmente al vino. Acido fondamentale e
importante, l'azione del tartarico è completata anche dalla presenza di altri
acidi.
Le sostanze acide presenti nel vino non derivano unicamente dal succo dell'uva,
poiché alcune di queste si formano durante la vinificazione e la maturazione.
Nel vino si trovano diverse sostanze acide e, fra queste, quelle più rilevanti
in termini quantitativi e organolettici sono gli acidi tartarico, malico,
citrico, succinico, lattico e acetico. Va inoltre ricordato che, durante le
operazioni enologiche - e in accordo a quanto stabilito dalla legge - è ammessa
l'aggiunta o la riduzione di alcuni acidi con lo scopo di migliorare la
stabilizzazione, il gusto e la conservazione del vino. Oltre al tartarico, fra
gli acidi correttori aggiunti e permessi dalla legge, ricordiamo l'acido
ascorbico e l'acido sorbico. Di tutti gli acidi presenti nel vino, quello più
temuto è certamente l'acido acetico, la quale presenza può essere
positiva entro un certo limite, superato il quale, da origine a uno sgradevole
e temuto difetto.
|
 | |
| Cristalli di acido tartarico, il
responsabile principale dell'acidità nel vino | |
|
La quantità di questi acidi si modifica nel corso della vita del vino, in
particolare l'acido malico - dal sapore aspro e acerbo - che può essere
facilmente degradato in acido lattico, dal sapore più rotondo. Questo
fenomeno, generalmente detto fermentazione malolattica, si definisce più
correttamente conversione malolattica, poiché, dal punto di vista
chimico, non è prodotta da processi fermentativi per opera di lieviti. La
conversione malolattica è un processo generalmente positivo nella produzione
dei vini rossi, mentre nei vini bianchi si tende a evitare per il suo tipico
risultato di arrotondare il gusto. L'acidità è infatti una delle qualità
tipiche e caratteristiche di un vino bianco, responsabile della sua vivacità e
freschezza, così da consentire un proficuo equilibrio del vino, evitando
un'eccessiva piattezza.
L'acidità fissa è determinata dalla quantità delle sostanze acide presenti in
un vino e che non tendono a volatilizzare, cioè non si disperdono durante la
vita di un vino, restando quindi fisse. L'acidità volatile rappresenta
la frazione di sostanze acide che possono liberarsi dal vino e disperdersi
nell'aria, tutte appartenenti alla cosiddetta serie acetica -
percettibili sia all'olfatto sia al gusto - delle quali, il principale è
l'acido acetico. Dal sapore tipicamente aspro e duro, l'acido acetico è
comunque presente nel vino, tuttavia il suo apporto risulta positivo unicamente
quando è presente in quantità ridotte e inferiore allo 0,7%. Al superamento di
questo limite, il vino si considera affetto dal difetto di spunto o
acescenza, facilmente riconoscibile al naso per l'evidente odore di
aceto. L'eccessiva quantità di questo acido porta infatti alla costituzione
dell'aceto, nel quale l'acido acetico diviene dominante e caratteristico.
Dal punto di vista organolettico, ogni sostanza acida ha un gusto proprio e
caratteristico, pertanto, il sapore dell'acido tartarico è piuttosto diverso da
quello lattico o acetico. Lo stimolo fondamentale acido non è infatti l'unica
qualità organolettica che si può percepire nelle sostanze acide: ogni acido ha,
nel suo complesso, un sapore unico e caratteristico che va oltre il
semplice acido. A tale proposito, è interessante comprendere il sapore
prodotto dalle principali sostanze acide che tipicamente sono presenti nel
vino. Il più importante di tutti è, come già detto, l'acido tartarico - detto
anche acido dell'uva - ed è quello che maggiormente contribuisce al gusto acido
del vino donando la tipica freschezza. L'eccessiva presenza di questo
acido conferisce al vino un carattere piuttosto duro, determinando
inoltre un forte squilibrio e una personalità eccessivamente tagliente
del gusto.
L'acido malico prende questo nome poiché presente nella mela, tuttavia, va
notato, è presente anche in altra frutta. Il suo sapore è decisamente
duro e produce una sensazione tipicamente acerba, una qualità che
è apprezzabile nei vini bianchi, soprattutto giovani, ma poco gradita in quelli
rossi. Per questo motivo, nei vini rossi, è favorita la cosiddetta
fermentazione malolattica che ha lo scopo di convertire l'acido malico
in acido lattico mediante l'opera di batteri lattici. L'acido lattico, a
differenza di quello malico, ha un sapore decisamente più morbido e rotondo,
pur conservando un carattere comunque acido. Questo acido si forma naturalmente
nel latte - da cui il nome - a seguito della sua acidificazione. Nei vini
bianchi si evita generalmente la sua formazione, ottenuta dalla conversione
malolattica, proprio per mantenere una certa freschezza e vivacità del vino.
Presente in quantità decisamente inferiori rispetto al tartarico, nel vino
troviamo anche la presenza dell'acido citrico, capace di donare una gradevole
freschezza e vivacità che ricorda quella degli agrumi. Va notato che l'acido
citrico è facilmente degradabile dai batteri lattici e, pertanto, tende a
scomparire con la maturazione del vino. L'acido citrico è generalmente presente
nei vini bianchi giovani, operando uno stimolo sensoriale sinergico con l'acido
tartarico, aumentando la sensazione di acidità e di freschezza. Un altro acido
che si trova nel vino è quello succinico. Questa sostanza si forma in seguito
alla fermentazione alcolica e, va detto, la sua presenza non contribuisce in
modo significativo al sapore acido del vino. Il ruolo dell'acido succinico
riguarda prevalentemente la sapidità di un vino e può contribuire anche a
rafforzare il carattere vinoso nei vini giovani.
Una considerazione particolare spetta certamente all'acido acetico. Si tratta
di una sostanza che si sviluppa durante la produzione del vino, a partire dalla
fermentazione. Dal sapore aspro e duro, contribuisce alla presenza nel
vino di aromi e gusti che ricordano direttamente l'aceto. Si tratta del
principale acido che costituisce l'acidità volatile e la sua presenza nel vino
è tollerabile quando è inferiore allo 0,7%. Al di sopra di questa soglia, nel
vino si percepiscono evidenti ricordi di aceto, segno inequivocabile
dell'insorgere del difetto di spunto, che diviene acescenza nei casi più gravi.
Quando presente nei limiti tollerabili, l'acido acetico può contribuire alla
freschezza e alla vivacità del vino, in particolare di quelli bianchi, e
contribuisce inoltre allo sviluppo del profilo aromatico. L'effetto sui profumi
del vino è dovuto alla natura volatile dell'acido acetico che, sollevandosi
dalla superficie del vino, trasporta verso l'alto anche gli aromi.
L'impatto dell'acidità nel gusto del vino assume significati diversi in
funzione dello stile, in ogni caso, elemento fondamentale per la determinazione
dell'equilibrio. Dal punto di vista sensoriale, l'acidità si classifica nelle
sostanze cosiddette dure, che si oppongono a quelle morbide e di natura
prevalentemente dolciastra. L'acidità svolge un'azione sinergica con le altre
sensazioni “dure” - astringenza e sapidità - rafforzandone l'effetto
organolettico. Anche l'effervescenza è rafforzata dall'acidità, effetto che si
verifica in modo reciproco. L'acidità si deve considerare come il principale
antagonista sensoriale della dolcezza, trovando in questo stimolo un reciproco
effetto di equilibrio. A tale proposito, si consideri il sapore del succo di
limone che, oltre a essere acido è anche aspro, sensazione che si può
facilmente rendere più tollerabile con la semplice aggiunta di zucchero. In
questo caso specifico, la quantità di sostanze acide non subisce nessuna
alterazione, ma la loro percezione risulta meno aggressiva e perfino piacevole.
La temperatura svolge un ruolo piuttosto neutrale sulla percezione
dell'acidità: lo stimolo gustativo sarà percettibile indifferentemente dalla
temperatura, tuttavia è bene notare che basse temperature rendono l'acidità più
gradevole. Dal punto di vista sensoriale, la presenza e l'intensità di una
sostanza acida produce una risposta fisiologica chiaramente riconoscibile: la
salivazione. L'acidità è considerata come potenziale condizione offensiva della
mucosa della cavità orale, pertanto la naturale risposta fisiologica è
determinata dalla salivazione, che ha lo scopo di diluire le sostanze acide
rendendole meno aggressive. Tanto maggiore la secrezione si saliva, tanto
maggiore l'intensità dell'acidità, ricordando - a tale proposito - l'azione
opposta provocata dall'astringenza nella salivazione. I tannini responsabili
della sensazione di astringenza si legano infatti con le proteine della saliva,
determinandone la precipitazione e la conseguente riduzione della secrezione.
|