
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 151, Maggio 2016 |
Sommario |
|
|
Il Vino dei Giovani |
|
Non parlerò del consumo di vino dei giovani e del loro rapporto con la bevanda di bacco, l'alcol e le implicazioni sociali di questo comportamento, soprattutto quando diviene deplorevole abuso ed eccesso. Parlerò invece di quei giovani che con il vino hanno un rapporto ben diverso, che non si limitano ad apprezzarlo nel calice - con maggiore e più consapevole rispetto - ma che, in particolare, lo accompagnano dalla vigna alla bottiglia. Giovani produttori di vino, insomma. Negli ultimi anni, sempre più giovani si dedicano all'agricoltura, non solo per passione ma anche per necessità. In questi tempi, non proprio floridi anche per quelli che hanno la volontà di fare, i giovani, non trovando possibilità concreta nel mondo del lavoro dell'industria e del terziario, trovano occupazione nell'agricoltura. Piuttosto che lavorare per pochi mesi all'anno - con redditi decisamente ridicoli e insufficienti a garantire anche la più modesta sopravvivenza - i giovani decidono di avviare aziende agricole e, per così dire, tornare alla terra. Sì, d'accordo si tratta di lavoro duro e faticoso, lontano dalle comodità alienanti delle poltrone di uffici, ma con il vantaggio di essere liberi all'aria aperta e trarre soddisfazione dal proprio impegno. Non si tratta, in ogni caso, del lavoro durissimo della campagna conosciuto dai contadini di qualche decina di anni fa: oggi la tecnologia e il progresso, per fortuna, facilitano questo mestiere. I nuovi agricoltori e viticoltori hanno un approccio ben diverso rispetto a un tempo: studiano, si preparano, si dedicano con consapevolezza al loro lavoro, senza dimenticare l'esperienza di chi li ha preceduti. Si guarda alla tradizione ma con la consapevolezza di quello che la tecnologia e l'inevitabile progresso aggiungono a questo mestiere. In questo senso, si deve ricordare che quello che si considera oggi “tradizione” altro non è che un'innovazione di successo del passato. Questo significa che è sempre bene guardare al passato, non meno importante guardare al futuro e continuare l'evoluzione. Del resto, qualora l'uomo fosse rimasto fedele alle tradizioni del passato senza considerare il futuro, il genere umano sarebbe ancora fermo all'era paleolitica. Poi ci sono i giovani che decidono di continuare il mestiere dei padri, che a volte fu anche quello dei loro nonni e bisnonni, ricevendo il testimone con l'impegno di portarlo avanti. Non solo, lo portano avanti aggiungendo la loro “giovane” formazione e visione, spesso introducendo moderne tecnologie, senza dimenticare la storia delle proprie famiglie. A differenza delle generazioni passate, i giovani hanno la possibilità di studiare, si diplomano o si laureano nelle materie attinenti all'agricoltura e alla vitivinicoltura, portano il loro “sapere nuovo” al sapere dei padri. Il loro contributo non tradisce comunque lo stile di famiglia, almeno in senso generale. Anzi, molto spesso il loro lavoro è paragonabile a quello dei loro padri, a volte perfino migliore. C'è da essere molto contenti di questo - o almeno, io lo sono - ammirando il loro lodevole impegno e serietà, ma anche per perpetuare un enorme patrimonio alle generazioni future. In fin dei conti, questo è esattamente quello che hanno fatto i loro padri e i loro nonni, i loro avi. Negli ultimi anni, visitando cantine e manifestazioni legate al vino, mi capita sempre più spesso di vedere i figli e le figlie dei produttori affiancare i genitori nella conduzione di vigneti e cantine. Sono presentati, con non poco e comprensibile orgoglio, come la naturale prosecuzione di una storia familiare che guarda al futuro. Per i genitori, non c'è dubbio, la soddisfazione di sapere che la fatica del loro lavoro e di quelli che li hanno preceduti può continuare, magari migliorata da nuove idee e talenti. Seguono i propri figli, in un certo senso, tenendoli per mano e rendendoli partecipi allo stile di famiglia, consapevoli che - prima o poi - saranno proprio loro a custodire il sapere dei padri. Non si tratta di una semplice regola naturale, ma anche una necessaria scelta di evoluzione poiché le nuove generazioni meglio comprendono quello che i tempi moderni chiedono, poiché figli di un tempo nuovo. Quello che fanno è adattare e accompagnare il lavoro dei padri verso il futuro, facendo esattamente quello che è stato fatto da chi li ha preceduti. I vini che producono ricalcano, in termini generali, lo stile di famiglia, al quale aggiungono, com'è giusto che sia, parte del loro carattere, lavorando a fianco dei genitori che, in ogni caso, svolgono l'importante ruolo di “guida”. In certi casi le idee rivoluzionarie che riescono a imporre nello stile di famiglia sono tali da stravolgere il senso di una storia, come se volessero spezzare un legame con il passato, come se fosse un fardello pesante di cui liberarsi. A volte - lo ammetto - faccio fatica a capire questa intraprendenza che, seppure lodevole, lascia perplessi sul risultato, spesso dettato dalla moda del momento piuttosto che da reale competenza enologica. Come sono sempre solito ripetere, quello che non comprendo non significa sia sbagliato, semplicemente è qualcosa che non incontra il mio gusto o il mio modo di vedere il vino. Magari hanno ragione loro - non lo escludo affatto - e la loro concezione di vino è probabilmente più avanti della mia. Ammetto che, a volte, mi sembrano piuttosto clamorosi passi indietro, verso quel modello di vino che, quando iniziai a occuparmi della bevanda di Bacco, erano considerati modelli enologici di rozza qualità da lasciare alle spalle. La cosa più importante, in ogni caso e indipendentemente da quello che penso o apprezzo, è che i giovani - tanti davvero - siano interessati a produrre vino. Qualunque sia il motivo o il modello che li spinge a farlo con passione e determinazione, la cosa più importante è che lo facciano. Un'altra cosa che si apprezza maggiormente, è la rinascita di una nuova coscienza che guarda al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità. In un mondo che sembra essere sempre più piccolo e che deve necessariamente garantire un posto per tutti - poiché tutti hanno pari dignità e diritto - questa è una lodevole sfida per i giovani produttori e agricoltori. Bravi ragazzi: mi auguro e vi auguro che la vostra passione possa sempre accompagnarvi nelle vostre idee e portarle avanti fino in fondo. Una rivoluzione che può passare attraverso un calice di vino, anche quando non la capisco. Magari la capite voi ed è questo quello che veramente conta. Antonello Biancalana
|
||||
Contrasti di Garganega e VermentinoDue grandi uve bianche protagoniste di vini fra i più rappresentativi d'Italia, con caratteri diversi ma certamente espressioni di grande personalità |
|
La varietà di uve autoctone da vino dell'Italia non ha eguali in nessun altro paese del mondo. La bellezza enologica del Bel Paese passa anche per questa particolare caratteristica che consente a ogni regione d'Italia di vantare almeno una varietà autoctona. Una ricchezza inestimabile che consente al nostro Paese di vantare una notevole offerta enologica, con vini diversi ed espressioni territoriali nei quali ogni uva può offrire un carattere unico. Ovviamente questo non significa che ogni uva autoctona sia capace di produrre vini di qualità - e lo stesso vale anche per i territori - ma è certo che questa caratteristica renda l'Italia una terra da vino unica al mondo. Non è un caso, appunto, che gli antichi greci, quando arrivarono in queste terre, chiamarono l'Italia Enotria Tellus. Terra da vino, quindi, ma anche di uve - tante uve - già presenti e radicate ai tempi della Magna Grecia. Gli antichi greci, va detto, introdussero diverse varietà di uve nelle terre che diventeranno poi Italia, e l'influsso degli ellenici nell'enologia e nella viticoltura del nostro Paese è ancora oggi evidente nei nomi di molte uve. Le uve della degustazione per contrasto di questo mese sono importanti rappresentanti dell'enorme patrimonio di uve autoctone d'Italia: Garganega e Vermentino. La prima di queste - la Garganega - è l'uva che ha indiscutibilmente segnato la rinascita di uno dei vini bianchi più celebri d'Italia: il Soave. Il Vermentino è invece il protagonista di molti vini bianchi della Sardegna, tuttavia svolge un ruolo importante anche in Liguria e Toscana. La presenza di queste uve si registra anche in altre regioni d'Italia - seppure marginalmente - mentre il Vermentino è coltivato inoltre in Francia e in Corsica. La Garganega è la varietà a bacca bianca più importante della provincia di Verona e Vicenza, uva che è alla base dei vini di Soave e Gambellara. In particolare, a Soave la Garganega è responsabile della rinascita dei vini bianchi di questo territorio, donando loro maggiore personalità, eleganza e finezza. Le origini della Garganega non sono chiare, tuttavia si ritiene che la sua presenza in queste terre sia decisamente remota, azzardando - perfino - l'introduzione da parte degli etruschi. Pietro de' Crescenzi, il celebre scrittore e agronomo del 1200, cita la Garganega nel suo trattato e, già a quei tempi, si riconosce la vocazione di quest'uva per la produzione di vini dolci. A tale proposito, si crede che la Garganega fosse già utilizzata dai retici per i loro vini dolci, citati anche da Plinio il Vecchio, il quale, fra l'altro, sosteneva che i retici fossero di origine etrusca. La Garganega, ancora oggi, è varietà di sicuro prestigio e versatilità, protagonista di vini secchi e dolci di notevole eleganza. La celebre uva bianca del Veneto è alla base del Soave e del Recioto di Soave, diventandone oggi l'uva principale, spesso l'unica. Con il tempo, la Garganega ha infatti sostituito le altre varietà previste per la produzione di questi vini, in particolare il Trebbiano di Soave, e oggi la maggioranza dei produttori tende a usarla in purezza. Lo stesso si può dire dei vini di Gambellara, nei quali la Garganega è usata in purezza per i vini secchi e dolci del territorio. La diffusione di questa varietà si può ricondurre prevalentemente in Veneto, tuttavia si registra una presenza marginale della Garganega anche in altre regioni, come Umbria e Lombardia. La massima espressione di questa varietà bianca si deve comunque ricondurre alle province di Verona e Vicenza, sia per i vini bianchi sia per quelli dolci da uve appassite. Le origini del Vermentino sembrano essere più chiare. L'origine di questa grande varietà a bacca bianca è riconducibile alla Spagna, ma più probabilmente al Portogallo, viaggia quindi nelle terre di Francia, per poi entrare nel territorio d'Italia. Il Vermentino è particolarmente diffuso in Sardegna, giunto dalla vicina Corsica, ed è oggi la varietà a bacca bianca più diffusa dell'isola. Dalla Sardegna il Vermentino si sarebbe quindi diffuso in Liguria e quindi in Toscana, regioni nelle quali questa uva bianca è ancora oggi ampiamente diffusa. Si ritiene, inoltre, che alcune varietà considerate autoctone, come Pigato, Rollo e Favorita, siano in realtà simili al Vermentino e, pertanto, si tratterebbe del medesimo vitigno. La stessa considerazione è valida anche per i cosiddetti Vermentino di Gallura e Vermentino di Alghero, entrambi coltivati in Sardegna, riconducibili in realtà alla medesima varietà.
Il Vermentino esprime caratteri diversi nelle tre principali terre dove si registra la maggiore diffusione: Sardegna, Liguria e Toscana. In Sardegna il Vermentino produce generalmente vini di maggiore struttura e complessità, mentre in Liguria si fa apprezzare per una migliore finezza di profumi e una struttura inferiore. In Toscana il Vermentino pare esprimere caratteri piuttosto vari, conservando sia eleganza dei profumi sia buona struttura. La Sardegna è oggi considerata la terra principale del Vermentino e i vini prodotti con quest'uva godono del riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata nell'intero territorio dell'isola. L'espressione più prestigiosa resta certamente il Vermentino di Gallura - riconosciuto come DOCG (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita) - dalla personalità decisa tuttavia elegante. Il Vermentino è comunque un'uva versatile, soprattutto in Sardegna dove è utilizzato per la produzione di spumanti, vini secchi da tavola e dolci da uve appassite. I vini della nostra degustazione per contrasto saranno scelti dalle zone di Soave, in Veneto, e Gallura, in Sardegna. Nello specifico, per quanto riguarda la Garganega, sceglieremo un Soave Superiore, mentre per l'altra varietà la nostra scelta sarà fatta per un Vermentino di Gallura. In entrambi i casi, è bene ricordare che i rispettivi disciplinari di produzione prevedono l'uso di altre varietà del territorio, pertanto è indispensabile che i due vini siano prodotti con le rispettive uve in purezza. Questo è particolarmente importante per il Soave Superiore, visto che il disciplinare prevede un minino del 70% di Garganega. Si sceglieranno vini appartenenti all'ultima annata di produzione, poiché avremo bisogno di vini giovani capaci di esprimere il carattere delle rispettive uve. Anche il metodo di produzione è determinante, pertanto faremo attenzione che i due vini siano prodotti in vasche d'acciaio. I campioni da degustare sono serviti alla temperatura di 10 °C e versati in calici da degustazione. Versiamo nei calici i due vini e iniziamo la valutazione dell'aspetto iniziando dal Vermentino di Gallura. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca - allo scopo è sufficiente un semplice foglio di carta - e osserviamo il vino alla base del calice. Si osserva un colore giallo paglierino intenso e brillante e una trasparenza molto elevata, com'è facilmente prevedibile. Non si avrà difficoltà, infatti, a riconoscere i dettagli dell'eventuale oggetto posto fra il calice e la superficie bianca. La sfumatura del colore, osservata all'estremità del vino verso l'apertura del calice, mostra una tonalità giallo verdolino. Osserviamo ora l'aspetto della Garganega espressa dal vino Soave Superiore. Alla base del calice si osserverà un colore giallo paglierino intenso, talvolta tendente al giallo dorato, con una trasparenza - anche in questo caso - molto elevata. La sfumatura della Garganega conferma il suo colore, evidenziando tonalità giallo paglierino tendente al dorato. I profili aromatici di Garganega e Vermentino presentano alcune caratteristiche comuni così come differenze sostanziali, in ogni caso, offrono al naso del degustatore un carattere di sicura personalità. Entrambe le varietà si caratterizzano principalmente per i loro aromi di frutti a polpa bianca, mela e pera su tutti. Il profilo aromatico del Vermentino - in termini generali - esprime qualità che ricordano più direttamente gli agrumi - limone, in particolare - con un carattere, per così dire, più fresco della Garganega. La varietà a bacca bianca del Veneto si fa riconoscere, fra i tanti, per il tipico aroma di mandorla, caratteristica che si rileva sia nei suoi vini secchi sia in quelli dolci da uve appassite. In entrambe le varietà non mancano sensazioni che richiamano la frutta esotica, in particolare l'ananas, e gli aromi che riconducono ai fiori si esprimono principalmente in biancospino e ginestra. Passiamo ora alla valutazione dei profumi delle due uve della nostra degustazione per contrasto. Inizieremo dal Vermentino di Gallura, mantenendo il calice in posizione verticale e senza rotearlo. Eseguiamo la prima olfazione così da valutare gli aromi di apertura. Dal calice si percepiscono aromi di mela, pera e biancospino, intensi e ben percettibili. Ruotiamo ora il calice - così da favorire lo sviluppo degli altri aromi - e procediamo con la seconda olfazione. Dal calice si percepisce il caratteristico aroma di limone al quale seguono ginestra, susina, pesca, ananas e, lieve, il profumo della mandorla. Passiamo ora all'esame degli aromi della Garganega attraverso il Soave Superiore. L'apertura di questo vino regala al naso del degustatore aromi di mela, ginestra e pera, oltre al caratteristico profumo di mandorla. Dopo avere roteato il calice, il profilo olfattivo si completa con biancospino, pesca, susina, ananas e albicocca. Talvolta, nella Garganega, si può inoltre percepire l'aroma del miele. Le qualità gustative di Vermentino e Garganega evidenziano differenze piuttosto sostanziali, in particolare nella struttura. Entrambe le varietà producono vini dal volume alcolico piuttosto elevato - non è raro trovare vini che arrivano al 13% di alcol - caratteristica che influisce chiaramente nel profilo gustativo. L'attacco del Vermentino di Gallura si fa apprezzare per un'evidente freschezza, conferita dall'acidità, qualità che rende il vino molto piacevole. Si noterà l'apporto dell'alcol nell'equilibrio del vino, così come la buona corrispondenza con il naso, in particolare mela, pera e ananas. Prendiamo ora un sorso di Soave Superiore. L'attacco della Garganega si caratterizza per una freschezza più rotonda rispetto a quella del Vermentino e, in termini generali, una maggiore struttura. Anche in questo vino l'alcol svolge un ruolo evidente nell'equilibrio, rendendo inoltre percettibile una discreta morbidezza, chiaramente maggiore rispetto al Vermentino. La corrispondenza con il naso è molto buona, riconoscendo la mela, pera e pesca. Concludiamo la nostra degustazione per contrasto con la valutazione delle sensazioni finali che i due vini lasciano in bocca dopo la deglutizione. Vermentino e Garganega producono vini dalle caratteristiche interessanti che lasciano in bocca sensazioni finali di pregevole qualità. Il finale del Vermentino di Gallura ha buona persistenza facendo percepire in bocca - dopo la deglutizione - piacevoli e netti sapori di mela, pera, ananas e limone. Le sensazioni finali lasciate in bocca dalla Garganega del Soave Superiore sono altrettanto interessanti. La persistenza di questo vino è decisamente buona e in bocca si percepiscono sapori di mela, pera, susina e la caratteristica nota amarognola della mandorla. Rispetto al Vermentino, nella Garganega si percepisce una sensazione di struttura maggiore a discapito della freschezza conferita dall'acidità, più pronunciata nel Vermentino. Si tratta chiaramente di due eccellenti uve, capaci di produrre grandi vini bianchi, di notevole personalità e qualità.
|
||||||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |
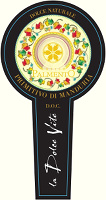
|
|
Primitivo di Manduria Dolce Naturale La Dolce Vite 2011 |
|
| L'Antico Palmento (Puglia, Italia) | |
 Primitivo Primitivo | |
| Prezzo: € 30,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, amarena
e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, carruba, tamarindo,
pepe rosa, mallo di noce e smalto. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, amarena
e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, carruba, tamarindo,
pepe rosa, mallo di noce e smalto.
 Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Crostate di confettura, Torte al cioccolato, Formaggi stagionati e piccanti Crostate di confettura, Torte al cioccolato, Formaggi stagionati e piccanti |
|
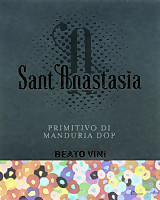
|
|
Primitivo di Manduria Sant'Anastasia 2013 |
|
| Beato Vini (Puglia, Italia) | |
 Primitivo Primitivo | |
| Prezzo: € 22,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con aromi di confettura
di prugna, confettura di amarena e confettura di mora seguite da aromi di
viola appassita, tabacco, vaniglia, cioccolato, macis e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con aromi di confettura
di prugna, confettura di amarena e confettura di mora seguite da aromi di
viola appassita, tabacco, vaniglia, cioccolato, macis e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di confettura di prugna, confettura di
amarena e confettura di mora. Finale persistente con ricordi di confettura di prugna, confettura di
amarena e confettura di mora.
 12 mesi in barrique. 12 mesi in barrique. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
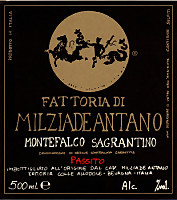
|
|
Montefalco Sagrantino Passito 2011 |
|
| Fattoria Colleallodole - Milziade Antano (Umbria, Italia) | |
 Sagrantino Sagrantino | |
| Prezzo: € 40,00 - 500ml | Punteggio: |
 Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, liquirizia, cioccolato, macis, tabacco, mallo di noce e smalto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, liquirizia, cioccolato, macis, tabacco, mallo di noce e smalto.
 Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. 18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. |
|
 Torte di cioccolato, Formaggi stagionati, Crostate di confettura Torte di cioccolato, Formaggi stagionati, Crostate di confettura |
|

|
|
Montefalco Sagrantino Collepiano 2011 |
|
| Arnaldo Caprai (Umbria, Italia) | |
 Sagrantino Sagrantino | |
| Prezzo: € 75,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
tabacco, macis, pepe rosa, cipria, cioccolato, cannella, cuoio e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
tabacco, macis, pepe rosa, cipria, cioccolato, cannella, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. 22 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia. 22 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati |
|

|
|
Barolo Gramolere 2011 |
|
| Manzone Giovanni (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo Nebbiolo | |
| Prezzo: € 36,60 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, tabacco, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, tabacco, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 30 mesi in botte. 30 mesi in botte. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|

|
|
Barolo Riserva Gramolere 2007 |
|
| Manzone Giovanni (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo Nebbiolo | |
| Prezzo: € 60,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di lampone, rosa
appassita, confettura di fragole, vaniglia, tabacco, liquirizia, cannella,
cacao, cuoio, macis e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di lampone, rosa
appassita, confettura di fragole, vaniglia, tabacco, liquirizia, cannella,
cacao, cuoio, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone.
 48 mesi in botte. 48 mesi in botte. |
|
 Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati |
|
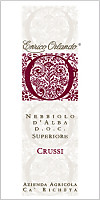
|
|
Nebbiolo d'Alba Superiore Crussi 2013 |
|
| Ca' Richeta (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo Nebbiolo | |
| Prezzo: € 12,20 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, vaniglia, tabacco,
cioccolato e macis. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, vaniglia, tabacco,
cioccolato e macis.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. |
|
 Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto |
|

|
|
Vino da Messa 2006 |
|
| Ca' Richeta (Piemonte, Italia) | |
 Moscato bianco, Sauvignon Blanc, Altre Uve Moscato bianco, Sauvignon Blanc, Altre Uve | |
| Prezzo: € 14,50 - 375ml | Punteggio: |
 Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa,
fico secco e miele seguite da aromi albicocca secca, confettura di pesche,
confettura di mele cotogne, canditi, dattero, mandorla, vaniglia e smalto. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa,
fico secco e miele seguite da aromi albicocca secca, confettura di pesche,
confettura di mele cotogne, canditi, dattero, mandorla, vaniglia e smalto.
 Attacco dolce e piacevolmente morbido, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco dolce e piacevolmente morbido, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele. Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele. 48 mesi in barrique. 48 mesi in barrique. |
|
 Formaggi stagionati, Dessert di frutta secca Formaggi stagionati, Dessert di frutta secca |
|
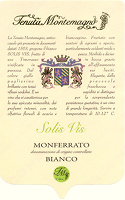
|
|
Monferrato Bianco Solis Vis 2014 |
|
| Tenuta Montemagno (Piemonte, Italia) | |
 Timorasso Timorasso | |
| Prezzo: € 11,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, agrumi e
pera seguite da aromi di nocciola, miele, susina, pesca, biancospino,
ananas e ginestra. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, agrumi e
pera seguite da aromi di nocciola, miele, susina, pesca, biancospino,
ananas e ginestra.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola. Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola. Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Paste ripiene, Carne bianca alla griglia, Pesce alla griglia, Pesce arrosto Paste ripiene, Carne bianca alla griglia, Pesce alla griglia, Pesce arrosto |
|
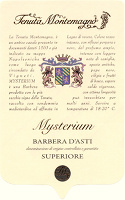
|
|
Barbera d'Asti Superiore Mysterium 2013 |
|
| Tenuta Montemagno (Piemonte, Italia) | |
 Berbera Berbera | |
| Prezzo: € 15,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, mora, vaniglia,
cioccolato, tabacco e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, mora, vaniglia,
cioccolato, tabacco e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e prugna. Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e prugna. 12 mesi in botte e barrique. 12 mesi in botte e barrique. |
|
 Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi |
|
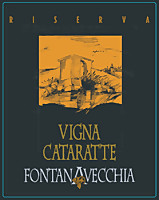
|
|
Aglianico del Taburno Riserva Vigna Cataratte 2008 |
|
| Fontanavecchia (Campania, Italia) | |
 Aglianico Aglianico | |
| Prezzo: € 16,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, vaniglia, cacao, chiodo di garofano, cannella, cuoio, macis e
mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, vaniglia, cacao, chiodo di garofano, cannella, cuoio, macis e
mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. 14 mesi in barrique. 14 mesi in barrique. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
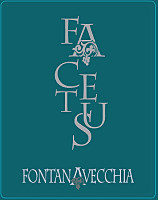
|
|
Taburno Falanghina Facetus 2008 |
|
| Fontanavecchia (Campania, Italia) | |
 Falanghina Falanghina | |
| Prezzo: € 12,00 | Punteggio: |
 Giallo dorato cupo e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato cupo e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela matura, scorza d'agrume e nocciola seguite da aromi di miele, susina,
albicocca secca, confettura di mele cotogne, confettura di pere, vaniglia,
pralina, confettura di pesche, biancospino e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela matura, scorza d'agrume e nocciola seguite da aromi di miele, susina,
albicocca secca, confettura di mele cotogne, confettura di pere, vaniglia,
pralina, confettura di pesche, biancospino e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela matura, albicocca
secca e nocciola. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela matura, albicocca
secca e nocciola.
 9 mesi in barrique. 9 mesi in barrique. |
|
 Carne bianca arrosto, Carne alla griglia, Pesce arrosto, Formaggi stagionati Carne bianca arrosto, Carne alla griglia, Pesce arrosto, Formaggi stagionati |
|
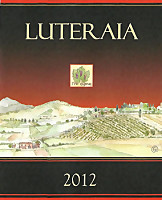
|
|
Luteraia 2012 |
|
| Luteraia (Toscana, Italia) | |
 Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) | |
| Prezzo: € 13,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, cuoio, macis, cannella e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, cuoio, macis, cannella e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
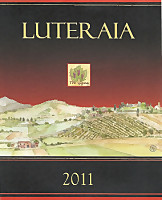
|
|
Vino Nobile di Montepulciano 2011 |
|
| Luteraia (Toscana, Italia) | |
 Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) | |
| Prezzo: € 13,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
vaniglia, tabacco, macis, cuoio, macis e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
vaniglia, tabacco, macis, cuoio, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
Albana Dèi 2016: Cinque Giurie Popolari Chiamate a Votare |
||||
In tutte le occasioni ci saranno banchi di assaggio per dare modo al pubblico di degustare e apprezzare i vini finalisti ed esprimere il proprio giudizio come “giuria popolare”. La proclamazione dei vini vincitori avverrà nel mese di giugno (data ancora da definire). «Con questa nuova edizione dell'Albana Dèi prosegue la messa al centro dell'attenzione pubblica di questo grande vitigno attraverso un contenitore semplice e d'appeal, che mira a fare del mese di maggio la ricorrenza annuale delle nuove annate dei vini DOCG Romagna Albana - sottolineano gli organizzatori della manifestazione - Crediamo che questa via costituisca un concept fresco e popolare per sostenerne l'affezione, la crescita di affermazione e insieme la convinzione commerciale. Un modo per rilanciare il valore della DOP Romagna Albana quale veicolo per fissare l'unicità e straordinarietà di questo vitigno dal grande potenziale, nella ricchezza di interpretazioni dei produttori del territorio. Anche quest'anno il concorso si arricchisce di due nuove località, Faenza e Oriolo, e replica la sua presenza all'interno della Festa del vino di Dozza, poi a Bertinoro e Brisighella, per allargare la schiera dei fans e contribuire con una più significativa incidenza degli amanti del vino alla designazione degli Albana top del territorio». |
||||
La DOC Orcia Riconferma Donatella Cinelli Colombini alla Presidenza per i Prossimi Tre Anni |
| Nata nel 2000, la giovane e ambiziosa Doc Orcia è in veloce innalzamento
qualitativo e va annoverata fra le piccole denominazioni italiane emergenti.
In occasione dell'Orcia Wine Festival 2016, evento che ogni anno porta a San
Quirico d'Orcia migliaia di winelovers, il Consorzio ha rinnovato il suo
Consiglio di Amministrazione riconfermando la Presidente Donatella Cinelli
Colombini con Giulitta Zamperini e Roberto Terzuoli vicepresidenti e i
consiglieri Andrea Giorgi (Sampieri del Fà), Capitoni Marco (dell'omonima
azienda Capitoni), Paolo Salviucci (Campotondo), Emanuele Bizzi (Trequanda),
Antonio Rovito (Val d'Orcia Terre Senesi), Olivi Giuseppe (Olivi-Le Buche),
Roberto Rappuoli (Podere Forte) e Berni Valentino (Loghi). Infine Gabriella
Giannetti (San Savino) ricopre il ruolo di Segretario e Marco Turillazzi
quello di Sindaco Revisore. Donatella Cinelli Colombini inizia il suo secondo mandato, forte del consenso dei soci ottenuto grazie al grosso lavoro dei tre anni passati. Eventi, contatti e comunicazione che si riassumono nel progetto “Orcia, il vino più bello del mondo”. «La Doc Orcia viene prodotta in una settantina di aziende di cui 41 iscritte al Consorzio. Il vino Orcia è ancora qualcosa di artigianale seguito con cura amorevole dai produttori stessi dalla vigna fino al cliente finale» ha spiegato la Cinelli Colombini. La produzione totale della denominazione è di 240.000 bottiglie l'anno con il Sangiovese come principale vitigno dei rossi (Orcia con il minimo di 60% e Orcia Sangiovese con il minimo di 90% di Sangiovese anche nella versione riserva) e piccole quantità di Doc Orcia bianco, rosato e Vin Santo. Il territorio di produzione si estende in 13 comuni ed è fra i comprensori agricoli più belli e incontaminati, per questo è diventato una destinazione turistica di prima grandezza con quasi un milione e mezzo di presenze turistiche e un milione di visitatori giornalieri. «Sono questi visitatori il primo e principale mercato del vino Orcia. Una diversificazione produttiva che riguarda anche le cantine, il 65% delle quali ha una struttura ricettiva o un ristorante. Posso dunque affermare che l'Orcia è la denominazione più turistica d'Italia» ha aggiunto la Presidente. Il Consorzio ha ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con DM 57934 del 25/07/2014 il riconoscimento Erga Omnes e sviluppa ogni anno un gran numero d'iniziative. Nel 2016 sono in programma l'attivazione dell'Orcia Wine Class, a cura della delegazione Onav Siena, che offrirà minicorsi sul vino ai turisti e il potenziamento - in numero e in dimensione - degli eventi sul territorio che riguarderanno 6 dei 13 comuni della denominazione. L'Orcia Wine Festival, appena concluso a San Quirico d'Orcia, ha visto l'afflusso di circa 2.000 appassionati e operatori. Nel futuro il vino Orcia vuole essere più visibile all'esterno anche per aprirsi a nuove opportunità commerciali. Donatella Cinelli Colombini ricopre anche la carica di Presidente nazionale delle Donne del vino e ha nel suo curriculum la creazione - nel 1993 - della giornata Cantine Aperte che ha diffuso in Italia il turismo del vino. Discendente da una famiglia di storici produttori di Brunello è lei stessa titolare di una cantina a Montalcino. Negli ultimi 15 anni ha dedicato una particolare attenzione al vino Orcia, denominazione in cui possiede un'azienda agrituristica e una cantina a Trequanda. |
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
||||||||||||||
Wine Guide ParadeFebbraio 2016
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |