|
La degustazione sensoriale e critica del vino è un esercizio che richiede
dedizione, concentrazione, attenzione e - non da ultimo - passione e curiosità.
In uno scenario enologico così vasto, fatto di centinaia di vitigni diversi che
portano - inevitabilmente - alla produzione di una quantità pressoché infinita
di vini altrettanto diversi, conoscere le loro caratteristiche è molto
importante. Una condizione che può divenire difficile e difficoltosa, proprio a
causa dell'enorme quantità di varietà di uve da vino esistenti nel mondo: solo
in Italia se ne contano circa cinquecento. Molte di queste, evidentemente,
risultano avere un impiego enologico modesto e, in molti casi, addirittura
unico, in ogni caso, ognuna di queste ha dignità enologica propria e, come
tale, merita di essere considerata. Le varietà più diffuse aumentano - di fatto
- la difficoltà e le possibilità di studio.
La degustazione dei vini monovarietali - cioè quelli prodotti da una singola
varietà - ha un valore formativo e didattico molto elevato per qualunque
degustatore. Lo studio di questi particolari vini, nonostante si possa
immaginare come semplice e riduttivo, offre in realtà condizioni
di analisi estremamente vaste e virtualmente infinite. La degustazione dei vini
monovarietali - con lo scopo di comprenderne le caratteristiche - non può
risolversi unicamente con lo studio di un unico caso o di un'unica bottiglia.
Com'è noto, e questo certamente è uno dei tanti aspetti interessanti
dell'enologia e della viticoltura, una varietà può avere interpretazioni
diverse e considerevoli in funzione delle condizioni ambientali, colturali ed
enologiche. A questo possiamo inoltre aggiungere le variabili introdotte dalle
singole annate: i risultati diventano pressoché infiniti.
Le caratteristiche peculiari di ogni varietà possono infatti cambiare - anche
in modo drastico - in funzione di queste variabili, pur rimanendo, per certi
aspetti, pienamente riconoscibili. In altre parole, i vini prodotti in Borgogna
con il Pinot Nero sono piuttosto diversi da quelli prodotti in Oregon,
nonostante molte delle tipiche caratteristiche di questa varietà siano
chiaramente riconoscibili in entrambi i casi. Lo stesso accade per qualunque
altra varietà: le caratteristiche specifiche di ogni uva saranno in ogni caso
riconoscibili indipendentemente dalle condizioni e dalle variabili
viticolturali, ambientali ed enologiche. Altro esempio significativo è offerto
dal Merlot. La sua celebre morbidezza, capace di donare rotondità al vino in
modo spesso inequivocabile, è rilevabile anche in vini prodotti in condizioni,
luoghi e annate molto diverse fra loro.
Lo studio dei vini monovarietali è inoltre fondamentale per la comprensione
della vasta categoria di quelli multivarietali, prodotti dall'unione di più
uve e secondo modalità enologiche distinte. Sapere riconoscere le
caratteristiche salienti delle singole uve è quindi fondamentale per la
comprensione e la valutazione di questi vini, i quali rappresentano una
percentuale molto importante dello scenario enologico. A tale proposito è bene
chiarire quello che, per molti, è considerata una sorta di dote magica:
sapere riconoscere un vino, territorio e l'annata con la semplice osservazione
del colore e annusando il calice. Questo è ovviamente possibile, tuttavia si
tratta di una qualità legata più all'immaginario comune che alla realtà.
Non si tratta, in ogni caso, di qualità sovrannaturale, piuttosto è il
risultato di anni trascorsi a degustare vini e in modo assolutamente analitico.
La superficialità, è bene ricordarlo, non va molto d'accordo con la
degustazione sensoriale e analitica.
|
 | |
| Grappoli di Sangiovese: fra le uve più
diffuse in Italia, i suoi vini offrono notevoli opportunità di studio per la
comprensione delle diversità varietali e territoriali | |
|
Esistono comunque varietà che, nella loro evidente immediatezza, sono
decisamente più semplici da riconoscere anche dopo averle degustate poche
volte. Altre, invece, risultano molto più ostiche e meno espressive: la
capacità di saperle riconoscere chiede lunghi tempi e pratica: in certi casi,
il rischio di confonderle con altre varietà è piuttosto elevato. Si tratta, in
ogni caso, di un percorso di studio che va affrontato a piccoli passi e, come
tale, è opportuno iniziare dalla degustazione delle varietà che possiedono
qualità inconfondibili. A questo scopo risultano essere molto utili tutte le
varietà aromatiche, cioè le uve i quali vini hanno un netto ed evidente profumo
di uva. Data la ridotta quantità di uve appartenenti a questa categoria, lo
studio risulta essere semplice e decisamente efficace. Le varietà aromatiche,
lo ricordiamo, sono Moscato Bianco, Gewürztraminer e Brachetto.
Per iniziare questo tipo di studio, si metteranno a confronto tre vini prodotti
con queste uve, appartenenti alla stessa annata e vinificati in secco.
Indicazione fondamentale, poiché il Moscato Bianco e il Brachetto sono spesso
vinificati per spumantizzazione, in particolare in Italia. Non è necessario che
i vini provengano dallo stesso territorio o paese: quello che ci interessa
indagare - in questo caso - è la caratteristica aromatica di queste uve e dei
loro vini. Questo non significa che tutti i vini prodotti con queste uve
hanno le stesse qualità organolettiche. Con il tempo si comprenderà che anche
per queste uve - dal carattere così intenso ed esuberante - possono esistere
delle differenze notevoli in funzione del territorio e dell'annata. All'inizio
sarà sufficiente comprendere le caratteristiche peculiari di ognuna anche
confrontando i tre vini fra loro con lo scopo di rilevare le loro analogie e
differenze.
Si può iniziare, appunto, dalle cose semplici pur tuttavia non sottovalutando
l'enorme variabilità delle uve aromatiche in funzione dei diversi fattori
viticolturali ed enologici. Il passo successivo che si può compiere - dopo
avere fatto conoscenza con le tre varietà aromatiche - è quello di
concentrare lo studio unicamente su una di queste. Con lo scopo di non
introdurre elementi che potrebbero disturbare eccessivamente la valutazione,
all'inizio è bene evitare vini che siano stati prodotti con tecniche enologiche
particolari, come per esempio l'uso di botti e barrique. Questi elementi
conferiscono infatti ai vini caratteristiche organolettiche tali da confutare -
in certi casi anche in modo esagerato - le qualità specifiche dell'uva. Meglio
concentrarsi all'inizio sulle differenze territoriali e viticolturali, non da
ultimo, quelle prodotte in annate diverse. L'importante è che i vini siano
prodotti in contenitori inerti, come acciaio o cemento.
Si potrebbero considerare, per esempio, vini da Gewürztraminer prodotti in
tre aree diverse, come Alto Adige, Valle del Reno e Alsazia. Volendo aumentare
le possibilità di studio, si potrebbero aggiungere anche Gewürztraminer
prodotti in Sicilia e Australia, così da avere una panoramica più ampia offerta
da zone molto diverse fra loro. Il fattore fondamentale è che tutti siano
prodotti in contenitori inerti e possibilmente appartenenti alla stessa annata
o comunque con annate non molto distanti fra loro. Vini prodotti con la
medesima varietà e provenienti da aree diverse, consente di comprendere
l'influsso del clima e di come il caldo e il freddo influiscano non solo sui
profumi ma anche sulla struttura. La stessa considerazione si può fare anche
per l'annata, il suo andamento meteorologico e il periodo della vendemmia. Un
metodo di studio che, va ricordato, è valido per ogni varietà, nonostante con
le uve aromatiche possa risultare più semplice di quelle non aromatiche.
Con la pratica e con il tempo, possiamo aumentare la difficoltà e passare alla
valutazione dei vini monovarietali prodotti in contenitori di legno, come botti
e barrique. A questo punto dovremmo essere capaci a riconoscere le
caratteristiche principali della varietà presa in esame e pertanto possiamo a
ricercare le sue qualità organolettiche cercando di isolare l'apporto del
legno. Questo esercizio può sembrare semplice, poiché si potrebbe pensare
al riconoscimento delle qualità organolettiche del legno come palesemente
evidenti tanto da risultare facilmente riconoscibili. In realtà, nonostante in
certi casi l'apporto del legno sia eccessivo, quindi dominante, il tempo e
l'uso responsabile della botte potrebbero introdurre caratteristiche
organolettiche lievi e armoniose, tanto da risultare del tutto irrilevanti al
degustatore superficiale.
Continuando lo studio dei vini monovarietali, un altro interessante esercizio è
rappresentato dalla valutazione di quattro campioni - prodotti dallo stesso
produttore e nella stessa zona - aventi caratteristiche enologiche diverse. A
titolo di esempio, si potrebbero prendere in esame quattro bottiglie della
stessa varietà delle quali una giovane e vinificata in contenitori inerti,
un'altra giovane e maturata in legno, infine gli stessi vini maturati per
alcuni anni in bottiglia. Questo esercizio offre la possibilità di comprendere
come una varietà può evolvere nel tempo e in funzione di com'è stata
vinificata, considerando in ogni caso le peculiarità e le caratteristiche
specifiche delle rispettive annate. L'esercizio andrebbe in teoria condotto per
ogni territorio nel quale la varietà in esame è coltivata in modo
significativo, ricordando che le caratteristiche peculiari del vitigno saranno
sempre rilevabili con le dovute interpretazioni e adattamenti.
Da queste considerazioni si evince che le opportunità di studio sono
innumerevoli e, come tali, non è semplice - ma non impossibile - potere
ricordare e fare tesoro delle singole esperienze. A questo proposito è utile
ricorrere a quell'espediente al quale ogni degustatore non dovrebbe mai
rinunciare: trascrivere le proprie impressioni e prendere nota. Un metodo
semplice ed efficace, le nostre note torneranno sempre utili ogni volta che ci
troveremo a degustare un vino prodotto con le varietà delle quali avremo
trascritto le nostre impressioni sensoriali e personali. Con lo scopo di
reperire in tempi rapidi le nostre esperienze di degustazione quando ne avremo
bisogno, è certamente opportuno provvedere alla loro catalogazione e
ordinamento funzionale.
Lo studio dei vini monovarietali non è una pratica riservata unicamente ai
principianti. Questo tipo di studio, in tutte le sue innumerevoli variabili,
accompagna - per così dire - la vita di ogni degustatore. Non solo un esercizio
fondamentale per la comprensione delle singole varietà in funzione del
territorio e dei diversi fattori produttivi, ma anche utile pratica per
migliorare la propria capacità e mantenersi in allenamento. Oltre a questo, la
degustazione dei vini monovarietali è fondamentale per la comprensione e lo
studio di quelli cosiddetti multivarietali, cioè prodotti dall'unione di
più uve. La conoscenza delle singole varietà e della loro espressione enologica
risulterà infatti molto utile per poterle individuare anche in quei vini dove
sono presenti insieme ad altre uve. Del resto, non è possibile riconoscere
un'uva o un territorio se non lo si conosce e non lo si è mai incontrato.
Riconoscere una varietà in mezzo a tante altre è motivo di grande
soddisfazione, la giusta ricompensa per il tempo dedicato a questo tipo di
studio.
|



 Abrusco
Abrusco Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, impenetrabile alla luce.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, impenetrabile alla luce. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e
mirtillo seguite da aromi di prugna, violetta, vaniglia, tabacco, pepe rosa
e macis.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e
mirtillo seguite da aromi di prugna, violetta, vaniglia, tabacco, pepe rosa
e macis.
 Buona corrispondenza con il naso, attacco tannico e comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Buona corrispondenza con il naso, attacco tannico e comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, mora e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di amarena, mora e mirtillo. 18 mesi in barrique, 8 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique, 8 mesi in bottiglia. Carne arrosto, Carne alla griglia, Stufati di carne, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Carne alla griglia, Stufati di carne, Formaggi stagionati
 Merlot (58%), Cabernet Franc (25%), Petit Verdot (10%), Teroldego (7%)
Merlot (58%), Cabernet Franc (25%), Petit Verdot (10%), Teroldego (7%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e prugna seguite da aromi di violetta, vaniglia, mirtillo, tabacco,
cioccolato, macis ed eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e prugna seguite da aromi di violetta, vaniglia, mirtillo, tabacco,
cioccolato, macis ed eucalipto.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.
Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. 18 mesi in barrique, 8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 8 mesi in
bottiglia.
18 mesi in barrique, 8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 8 mesi in
bottiglia.
 Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
 Sangiovese
Sangiovese Rosa tenue intenso e sfumature rosa tenue, trasparente.
Rosa tenue intenso e sfumature rosa tenue, trasparente. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, susina e
mora seguite da aromi di lampone, fragole e ciclamino.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, susina e
mora seguite da aromi di lampone, fragole e ciclamino.
 Buona corrispondenza con il naso, attacco fresco e comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.
Buona corrispondenza con il naso, attacco fresco e comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina. 6 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
6 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia. Antipasti di carne, Pasta con pesce, Pesce arrosto, Latticini
Antipasti di carne, Pasta con pesce, Pesce arrosto, Latticini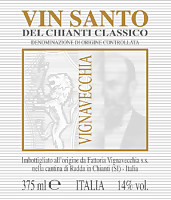
 Malvasia Bianca
Malvasia Bianca Giallo ambra cupo e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.
Giallo ambra cupo e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva
passa, fico secco e caramello seguite da aromi di mandorla, dattero, miele,
vaniglia, lavanda, noce, scorza d'agrume, tabacco e smalto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva
passa, fico secco e caramello seguite da aromi di mandorla, dattero, miele,
vaniglia, lavanda, noce, scorza d'agrume, tabacco e smalto.
 Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dall'alcol, buon pieno,
sapori intensi, piacevole freschezza.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dall'alcol, buon pieno,
sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e dattero.
Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e dattero. 5 anni in caratelli.
5 anni in caratelli. Crostate di confettura e frutta secca, Formaggi stagionati e piccanti
Crostate di confettura e frutta secca, Formaggi stagionati e piccanti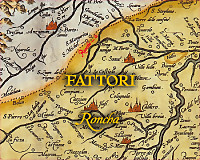
 Garganega (50%), Pinot Grigio (20%), Trebbiano di Soave (20%), Durella (10%)
Garganega (50%), Pinot Grigio (20%), Trebbiano di Soave (20%), Durella (10%) Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
biancospino seguite da aromi di pera, ananas, ginestra, pesca, mandorla e
minerale.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
biancospino seguite da aromi di pera, ananas, ginestra, pesca, mandorla e
minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina. Una piccola parte della Garganega è appassita per 5-6 mesi. Maturazione
in botte e in vasche d'acciaio.
Una piccola parte della Garganega è appassita per 5-6 mesi. Maturazione
in botte e in vasche d'acciaio.
 Paste ripiene, Pesce alla griglia, Carne bianca arrosto
Paste ripiene, Pesce alla griglia, Carne bianca arrosto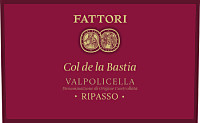
 Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%)
Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, prugna e
amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, prugna e
amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, macis e mentolo.
 Buona corrispondenza con il naso, attacco giustamente tannico e
comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole
morbidezza.
Buona corrispondenza con il naso, attacco giustamente tannico e
comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole
morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.
Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. 18 mesi in botte.
18 mesi in botte. Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia
Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia
 Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (30%)
Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (30%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora,
lampone, vaniglia, anice, cioccolato, tabacco, pepe rosa, macis, cannella e
mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora,
lampone, vaniglia, anice, cioccolato, tabacco, pepe rosa, macis, cannella e
mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e
mirtillo.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e
mirtillo.
 12 mesi in barrique, 4 anni in bottiglia.
12 mesi in barrique, 4 anni in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
 Cabernet Sauvignon (50%), Sangiovese (40%), Canaiolo Nero (10%)
Cabernet Sauvignon (50%), Sangiovese (40%), Canaiolo Nero (10%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, mora,
mirtillo, vaniglia, liquirizia, cioccolato, tabacco, cuoio, macis ed
eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, mora,
mirtillo, vaniglia, liquirizia, cioccolato, tabacco, cuoio, macis ed
eucalipto.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ribes e amarena.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ribes e amarena. 12 mesi in barrique, almeno 36 mesi in bottiglia.
12 mesi in barrique, almeno 36 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
