|
La varietà di uve autoctone da vino dell'Italia non ha eguali in nessun altro
paese del mondo. La bellezza enologica del Bel Paese passa anche per
questa particolare caratteristica che consente a ogni regione d'Italia di
vantare almeno una varietà autoctona. Una ricchezza inestimabile che consente
al nostro Paese di vantare una notevole offerta enologica, con vini diversi ed
espressioni territoriali nei quali ogni uva può offrire un carattere unico.
Ovviamente questo non significa che ogni uva autoctona sia capace di
produrre vini di qualità - e lo stesso vale anche per i territori - ma è certo
che questa caratteristica renda l'Italia una terra da vino unica al mondo. Non
è un caso, appunto, che gli antichi greci, quando arrivarono in queste terre,
chiamarono l'Italia Enotria Tellus. Terra da vino, quindi, ma anche di
uve - tante uve - già presenti e radicate ai tempi della Magna Grecia.
Gli antichi greci, va detto, introdussero diverse varietà di uve nelle terre
che diventeranno poi Italia, e l'influsso degli ellenici nell'enologia e nella
viticoltura del nostro Paese è ancora oggi evidente nei nomi di molte uve. Le
uve della degustazione per contrasto di questo mese sono importanti
rappresentanti dell'enorme patrimonio di uve autoctone d'Italia: Garganega e
Vermentino. La prima di queste - la Garganega - è l'uva che ha
indiscutibilmente segnato la rinascita di uno dei vini bianchi più celebri
d'Italia: il Soave. Il Vermentino è invece il protagonista di molti vini
bianchi della Sardegna, tuttavia svolge un ruolo importante anche in Liguria e
Toscana. La presenza di queste uve si registra anche in altre regioni d'Italia
- seppure marginalmente - mentre il Vermentino è coltivato inoltre in Francia e
in Corsica.
La Garganega è la varietà a bacca bianca più importante della provincia di
Verona e Vicenza, uva che è alla base dei vini di Soave e Gambellara. In
particolare, a Soave la Garganega è responsabile della rinascita dei vini
bianchi di questo territorio, donando loro maggiore personalità, eleganza e
finezza. Le origini della Garganega non sono chiare, tuttavia si ritiene che la
sua presenza in queste terre sia decisamente remota, azzardando - perfino -
l'introduzione da parte degli etruschi. Pietro de' Crescenzi, il celebre
scrittore e agronomo del 1200, cita la Garganega nel suo trattato e, già a quei
tempi, si riconosce la vocazione di quest'uva per la produzione di vini dolci.
A tale proposito, si crede che la Garganega fosse già utilizzata dai retici
per i loro vini dolci, citati anche da Plinio il Vecchio, il quale, fra
l'altro, sosteneva che i retici fossero di origine etrusca.
La Garganega, ancora oggi, è varietà di sicuro prestigio e versatilità,
protagonista di vini secchi e dolci di notevole eleganza. La celebre uva bianca
del Veneto è alla base del Soave e del Recioto di Soave, diventandone oggi
l'uva principale, spesso l'unica. Con il tempo, la Garganega ha infatti
sostituito le altre varietà previste per la produzione di questi vini, in
particolare il Trebbiano di Soave, e oggi la maggioranza dei produttori tende a
usarla in purezza. Lo stesso si può dire dei vini di Gambellara, nei quali la
Garganega è usata in purezza per i vini secchi e dolci del territorio. La
diffusione di questa varietà si può ricondurre prevalentemente in Veneto,
tuttavia si registra una presenza marginale della Garganega anche in altre
regioni, come Umbria e Lombardia. La massima espressione di questa varietà
bianca si deve comunque ricondurre alle province di Verona e Vicenza, sia per i
vini bianchi sia per quelli dolci da uve appassite.
Le origini del Vermentino sembrano essere più chiare. L'origine di questa
grande varietà a bacca bianca è riconducibile alla Spagna, ma più probabilmente
al Portogallo, viaggia quindi nelle terre di Francia, per poi entrare nel
territorio d'Italia. Il Vermentino è particolarmente diffuso in Sardegna,
giunto dalla vicina Corsica, ed è oggi la varietà a bacca bianca più diffusa
dell'isola. Dalla Sardegna il Vermentino si sarebbe quindi diffuso in Liguria e
quindi in Toscana, regioni nelle quali questa uva bianca è ancora oggi
ampiamente diffusa. Si ritiene, inoltre, che alcune varietà considerate
autoctone, come Pigato, Rollo e Favorita, siano in realtà simili al Vermentino
e, pertanto, si tratterebbe del medesimo vitigno. La stessa considerazione è
valida anche per i cosiddetti Vermentino di Gallura e Vermentino di Alghero,
entrambi coltivati in Sardegna, riconducibili in realtà alla medesima varietà.
|
 | |
| Il colore del
Vermentino. Si noti la sfumatura giallo verdolino. | |
|
Il Vermentino esprime caratteri diversi nelle tre principali terre dove si
registra la maggiore diffusione: Sardegna, Liguria e Toscana. In Sardegna il
Vermentino produce generalmente vini di maggiore struttura e complessità,
mentre in Liguria si fa apprezzare per una migliore finezza di profumi e una
struttura inferiore. In Toscana il Vermentino pare esprimere caratteri
piuttosto vari, conservando sia eleganza dei profumi sia buona struttura. La
Sardegna è oggi considerata la terra principale del Vermentino e i vini
prodotti con quest'uva godono del riconoscimento della Denominazione d'Origine
Controllata nell'intero territorio dell'isola. L'espressione più prestigiosa
resta certamente il Vermentino di Gallura - riconosciuto come DOCG
(Denominazione d'Origine Controllata e Garantita) - dalla personalità decisa
tuttavia elegante. Il Vermentino è comunque un'uva versatile, soprattutto in
Sardegna dove è utilizzato per la produzione di spumanti, vini secchi da tavola
e dolci da uve appassite.
I vini della nostra degustazione per contrasto saranno scelti dalle zone di
Soave, in Veneto, e Gallura, in Sardegna. Nello specifico, per quanto riguarda
la Garganega, sceglieremo un Soave Superiore, mentre per l'altra varietà la
nostra scelta sarà fatta per un Vermentino di Gallura. In entrambi i casi, è
bene ricordare che i rispettivi disciplinari di produzione prevedono l'uso di
altre varietà del territorio, pertanto è indispensabile che i due vini siano
prodotti con le rispettive uve in purezza. Questo è particolarmente importante
per il Soave Superiore, visto che il disciplinare prevede un minino del 70% di
Garganega. Si sceglieranno vini appartenenti all'ultima annata di produzione,
poiché avremo bisogno di vini giovani capaci di esprimere il carattere delle
rispettive uve. Anche il metodo di produzione è determinante, pertanto faremo
attenzione che i due vini siano prodotti in vasche d'acciaio. I campioni da
degustare sono serviti alla temperatura di 10 °C e versati in calici da
degustazione.
Versiamo nei calici i due vini e iniziamo la valutazione dell'aspetto iniziando
dal Vermentino di Gallura. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca -
allo scopo è sufficiente un semplice foglio di carta - e osserviamo il vino
alla base del calice. Si osserva un colore giallo paglierino intenso e
brillante e una trasparenza molto elevata, com'è facilmente prevedibile. Non si
avrà difficoltà, infatti, a riconoscere i dettagli dell'eventuale oggetto posto
fra il calice e la superficie bianca. La sfumatura del colore, osservata
all'estremità del vino verso l'apertura del calice, mostra una tonalità giallo
verdolino. Osserviamo ora l'aspetto della Garganega espressa dal vino Soave
Superiore. Alla base del calice si osserverà un colore giallo paglierino
intenso, talvolta tendente al giallo dorato, con una trasparenza - anche in
questo caso - molto elevata. La sfumatura della Garganega conferma il suo
colore, evidenziando tonalità giallo paglierino tendente al dorato.
I profili aromatici di Garganega e Vermentino presentano alcune caratteristiche
comuni così come differenze sostanziali, in ogni caso, offrono al naso del
degustatore un carattere di sicura personalità. Entrambe le varietà si
caratterizzano principalmente per i loro aromi di frutti a polpa bianca, mela e
pera su tutti. Il profilo aromatico del Vermentino - in termini generali -
esprime qualità che ricordano più direttamente gli agrumi - limone, in
particolare - con un carattere, per così dire, più fresco della Garganega. La
varietà a bacca bianca del Veneto si fa riconoscere, fra i tanti, per il
tipico aroma di mandorla, caratteristica che si rileva sia nei suoi vini secchi
sia in quelli dolci da uve appassite. In entrambe le varietà non mancano
sensazioni che richiamano la frutta esotica, in particolare l'ananas, e gli
aromi che riconducono ai fiori si esprimono principalmente in biancospino e
ginestra.
Passiamo ora alla valutazione dei profumi delle due uve della nostra
degustazione per contrasto. Inizieremo dal Vermentino di Gallura, mantenendo il
calice in posizione verticale e senza rotearlo. Eseguiamo la prima olfazione
così da valutare gli aromi di apertura. Dal calice si percepiscono aromi di
mela, pera e biancospino, intensi e ben percettibili. Ruotiamo ora il calice -
così da favorire lo sviluppo degli altri aromi - e procediamo con la seconda
olfazione. Dal calice si percepisce il caratteristico aroma di limone al quale
seguono ginestra, susina, pesca, ananas e, lieve, il profumo della mandorla.
Passiamo ora all'esame degli aromi della Garganega attraverso il Soave
Superiore. L'apertura di questo vino regala al naso del degustatore aromi di
mela, ginestra e pera, oltre al caratteristico profumo di mandorla. Dopo avere
roteato il calice, il profilo olfattivo si completa con biancospino, pesca,
susina, ananas e albicocca. Talvolta, nella Garganega, si può inoltre percepire
l'aroma del miele.
Le qualità gustative di Vermentino e Garganega evidenziano differenze piuttosto
sostanziali, in particolare nella struttura. Entrambe le varietà producono vini
dal volume alcolico piuttosto elevato - non è raro trovare vini che arrivano al
13% di alcol - caratteristica che influisce chiaramente nel profilo gustativo.
L'attacco del Vermentino di Gallura si fa apprezzare per un'evidente
freschezza, conferita dall'acidità, qualità che rende il vino molto piacevole.
Si noterà l'apporto dell'alcol nell'equilibrio del vino, così come la buona
corrispondenza con il naso, in particolare mela, pera e ananas. Prendiamo ora
un sorso di Soave Superiore. L'attacco della Garganega si caratterizza per una
freschezza più rotonda rispetto a quella del Vermentino e, in termini generali,
una maggiore struttura. Anche in questo vino l'alcol svolge un ruolo evidente
nell'equilibrio, rendendo inoltre percettibile una discreta morbidezza,
chiaramente maggiore rispetto al Vermentino. La corrispondenza con il naso è
molto buona, riconoscendo la mela, pera e pesca.
Concludiamo la nostra degustazione per contrasto con la valutazione delle
sensazioni finali che i due vini lasciano in bocca dopo la deglutizione.
Vermentino e Garganega producono vini dalle caratteristiche interessanti
che lasciano in bocca sensazioni finali di pregevole qualità. Il finale del
Vermentino di Gallura ha buona persistenza facendo percepire in bocca - dopo la
deglutizione - piacevoli e netti sapori di mela, pera, ananas e limone. Le
sensazioni finali lasciate in bocca dalla Garganega del Soave Superiore sono
altrettanto interessanti. La persistenza di questo vino è decisamente buona e
in bocca si percepiscono sapori di mela, pera, susina e la caratteristica nota
amarognola della mandorla. Rispetto al Vermentino, nella Garganega si
percepisce una sensazione di struttura maggiore a discapito della freschezza
conferita dall'acidità, più pronunciata nel Vermentino. Si tratta chiaramente
di due eccellenti uve, capaci di produrre grandi vini bianchi, di notevole
personalità e qualità.
|


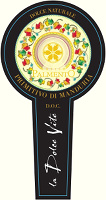
 Primitivo
Primitivo Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, amarena
e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, carruba, tamarindo,
pepe rosa, mallo di noce e smalto.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, amarena
e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, carruba, tamarindo,
pepe rosa, mallo di noce e smalto.
 Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. Maturazione in vasche d'acciaio.
Maturazione in vasche d'acciaio. Crostate di confettura, Torte al cioccolato, Formaggi stagionati e piccanti
Crostate di confettura, Torte al cioccolato, Formaggi stagionati e piccanti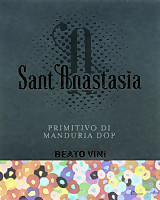
 Primitivo
Primitivo Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con aromi di confettura
di prugna, confettura di amarena e confettura di mora seguite da aromi di
viola appassita, tabacco, vaniglia, cioccolato, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con aromi di confettura
di prugna, confettura di amarena e confettura di mora seguite da aromi di
viola appassita, tabacco, vaniglia, cioccolato, macis e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di confettura di prugna, confettura di
amarena e confettura di mora.
Finale persistente con ricordi di confettura di prugna, confettura di
amarena e confettura di mora.
 12 mesi in barrique.
12 mesi in barrique. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati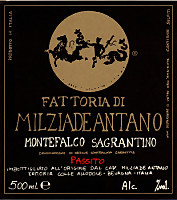
 Sagrantino
Sagrantino Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, liquirizia, cioccolato, macis, tabacco, mallo di noce e smalto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, liquirizia, cioccolato, macis, tabacco, mallo di noce e smalto.
 Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco dolce e tannico, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno,
sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.
Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. 18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. Torte di cioccolato, Formaggi stagionati, Crostate di confettura
Torte di cioccolato, Formaggi stagionati, Crostate di confettura
 Sagrantino
Sagrantino Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
tabacco, macis, pepe rosa, cipria, cioccolato, cannella, cuoio e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
tabacco, macis, pepe rosa, cipria, cioccolato, cannella, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. 22 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia.
22 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
 Nebbiolo
Nebbiolo Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, tabacco, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, tabacco, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 30 mesi in botte.
30 mesi in botte. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
 Nebbiolo
Nebbiolo Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di lampone, rosa
appassita, confettura di fragole, vaniglia, tabacco, liquirizia, cannella,
cacao, cuoio, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di lampone, rosa
appassita, confettura di fragole, vaniglia, tabacco, liquirizia, cannella,
cacao, cuoio, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone.
 48 mesi in botte.
48 mesi in botte. Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati
Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati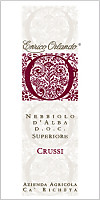
 Nebbiolo
Nebbiolo Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, vaniglia, tabacco,
cioccolato e macis.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, vaniglia, tabacco,
cioccolato e macis.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.
24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto
Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto
 Moscato bianco, Sauvignon Blanc, Altre Uve
Moscato bianco, Sauvignon Blanc, Altre Uve Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente.
Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa,
fico secco e miele seguite da aromi albicocca secca, confettura di pesche,
confettura di mele cotogne, canditi, dattero, mandorla, vaniglia e smalto.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva passa,
fico secco e miele seguite da aromi albicocca secca, confettura di pesche,
confettura di mele cotogne, canditi, dattero, mandorla, vaniglia e smalto.
 Attacco dolce e piacevolmente morbido, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Attacco dolce e piacevolmente morbido, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele.
Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e miele. 48 mesi in barrique.
48 mesi in barrique. Formaggi stagionati, Dessert di frutta secca
Formaggi stagionati, Dessert di frutta secca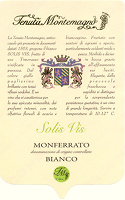
 Timorasso
Timorasso Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, agrumi e
pera seguite da aromi di nocciola, miele, susina, pesca, biancospino,
ananas e ginestra.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, agrumi e
pera seguite da aromi di nocciola, miele, susina, pesca, biancospino,
ananas e ginestra.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola. Maturazione in vasche d'acciaio.
Maturazione in vasche d'acciaio. Paste ripiene, Carne bianca alla griglia, Pesce alla griglia, Pesce arrosto
Paste ripiene, Carne bianca alla griglia, Pesce alla griglia, Pesce arrosto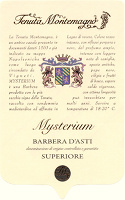
 Berbera
Berbera Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, mora, vaniglia,
cioccolato, tabacco e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
mirtillo e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, mora, vaniglia,
cioccolato, tabacco e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e prugna.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, mirtillo e prugna. 12 mesi in botte e barrique.
12 mesi in botte e barrique. Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi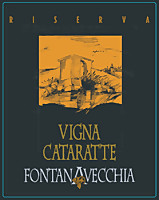
 Aglianico
Aglianico Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, vaniglia, cacao, chiodo di garofano, cannella, cuoio, macis e
mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, vaniglia, cacao, chiodo di garofano, cannella, cuoio, macis e
mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. 14 mesi in barrique.
14 mesi in barrique. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati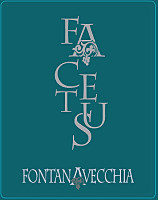
 Falanghina
Falanghina Giallo dorato cupo e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Giallo dorato cupo e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela matura, scorza d'agrume e nocciola seguite da aromi di miele, susina,
albicocca secca, confettura di mele cotogne, confettura di pere, vaniglia,
pralina, confettura di pesche, biancospino e minerale.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela matura, scorza d'agrume e nocciola seguite da aromi di miele, susina,
albicocca secca, confettura di mele cotogne, confettura di pere, vaniglia,
pralina, confettura di pesche, biancospino e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela matura, albicocca
secca e nocciola.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela matura, albicocca
secca e nocciola.
 9 mesi in barrique.
9 mesi in barrique. Carne bianca arrosto, Carne alla griglia, Pesce arrosto, Formaggi stagionati
Carne bianca arrosto, Carne alla griglia, Pesce arrosto, Formaggi stagionati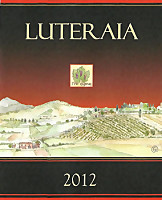
 Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%)
Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, cuoio, macis, cannella e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco, vaniglia,
cioccolato, cuoio, macis, cannella e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia.
12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati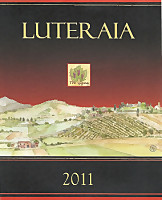
 Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%)
Sangiovese (70%), Canaiolo Nero (20%), Mammolo, Malvasia Aromatica Bianca (10%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso aranciato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
vaniglia, tabacco, macis, cuoio, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
vaniglia, tabacco, macis, cuoio, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mirtillo. 12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia.
12 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
