|
I vini frizzanti hanno da sempre svolto un ruolo importante nella produzione
enologica così come nell'immaginario dei consumatori. Questo stile di vino, nel
quale non fanno parte gli spumanti, ha sempre vissuto momenti di alterna
fortuna, il loro apprezzamento è cambiato nel corso del tempo e delle proposte
dei produttori. I vini frizzanti - che hanno una minore pressione in bottiglia
rispetto agli spumanti - riscuotono un discreto successo e rappresentano
un'importante quota del mercato enologico. Il loro consumo è tipicamente legato
a momenti informali e in certe tradizioni gastronomiche, ai vini frizzanti si
riconosce in genere un minore prestigio rispetto al più “elaborato e brioso”
spumante. Compagni insostituibili nelle tavole di molti territori, i vini
frizzanti meritano certamente una maggiore attenzione, riconoscendo - a onore
del vero - che spesso sono mortificati da produzioni decisamente mediocri.
In accordo alle direttive europee, i vini frizzanti devono avere una pressione
in bottiglia di almeno 1 atmosfera e non superiore a 2,5 alla temperatura di
20 °C. A titolo di completezza, si ricorda che i vini spumanti di qualità
devono avere una pressione minima di 3,5 atmosfere, 3 nel caso di vini spumanti
generici. I vini frizzanti sono prodotti con tecniche diverse, delle quali la
più diffusa è la fermentazione in autoclave. In molti casi, soprattutto nei
vini di largo consumo, si impiega la tecnica della gassificazione, aggiungendo
cioè anidride carbonica a un vino fermo. In Italia sono particolarmente diffusi
nella pianura padana, spesso definiti come “vivaci”, e trovano felice
abbinamento con la cucina di quelle terre. Le uve appartenenti alla vasta
famiglia dei lambruschi, così come la Croatina, risultano essere
particolarmente adatte alla produzione di vini frizzanti. Va detto, a titolo di
completezza, che queste uve sono inoltre impiegate - e con successo - nella
produzione di vini fermi da tavola.
La famiglia dei lambruschi è piuttosto ricca e le uve che ne fanno parte sono
ampiamente utilizzate per la produzione di vini frizzanti, in particolare nella
zona occidentale dell'Emilia Romagna. La diffusione delle uve Lambrusco si
estende anche nella parte orientale della regione, tuttavia in queste terre -
nella cosiddetta Romagna - l'enologia si dedica maggiormente ai vini fermi.
Il Lambrusco vanta una lunga storia ed è considerato una delle più antiche
varietà autoctone d'Italia, poiché si tratta di una pianta spontanea selvatica
già conosciuta al tempo degli antichi Romani. Si suppone infatti che il
Lambrusco derivi direttamente dalla Vitis Vinifera Silvestre, cioè
selvatica e che cresce spontanea, giunto fino ai giorni nostri dando
vita a uno dei vini più conosciuti d'Italia. Virgilio, Catone, Varrone e Plinio
il Vecchio hanno scritto infatti della Vitis Labrusca, pur non riferendo
le eventuali pratiche e usi enologici.
Dell'esistenza dei vini da Lambrusco se ne parlerà a partire dal 1300. Nel 1567
Andrea Bacci - medico di papa Sisto V - scrisse che nelle colline di Modena si
producevano vini da uve lambrusche dal carattere speziato e spumeggiante. Si
deve a Francesco Agazzotti - poco dopo la metà del 1800 - la prima
classificazione del Lambrusco identificando i tre tipi principali: Lambrusco di
Sorbara, Lambrusco Salamino e Lambrusco Grasparossa. A queste si uniranno più
tardi il Lambrusco Maestri, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Montericco e
Lambrusco Marani, oltre ad altre di minore diffusione e uso enologico. Il
Lambrusco è oggi prevalentemente prodotto con fermentazione in autoclave negli
stili secco, amabile e dolce, sia in rosso sia in rosato. Il Lambrusco
Grasparossa - protagonista della nostra degustazione - si caratterizza per
l'intenso colore rosso rubino cupo e sfumature violacee, oltre a una
particolare ricchezza di aromi. Questo Lambrusco è la principale varietà con la
quale si producono i vini della DOC Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
|
 | |
| Il colore
del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e la sua sfumatura porpora | |
|
La Croatina, l'altra uva protagonista della nostra degustazione per contrasto,
è particolarmente diffusa nel territorio di Piacenza e nell'Oltrepo Pavese. La
sua presenza è inoltre registrata in Piemonte, Veneto e altre zone della
Lombardia. La Croatina è talvolta confusa con la Bonarda - molto diffusa in
Piemonte, in particolare nel territorio di Novara - poiché nell'Oltrepo Pavese
e a Piacenza questa varietà è spesso chiamata con questo nome. Va detto che la
Croatina non ha nessun legame con la Bonarda piemontese e si tratta di due
varietà distinte. Nei vini dell'Oltrepo Pavese e dell'area di Piacenza nei
quali si fa riferimento alla Bonarda, si deve pertanto intendere Croatina.
Questa varietà si ritiene originaria di Rovescala, in provincia di Pavia e
vicino a quella di Piacenza, dove si suppone fosse presente già dal medioevo.
Le prime citazioni risalgono però verso la fine del 1800, quando la Croatina
inizia a diffondersi in modo significativo.
La Croatina è prevalentemente coltivata nei territori delle Denominazioni
d'Origine Controllata dell'Oltrepo Pavese e dei Colli Piacentini. È inoltre
presente in Piemonte e in Veneto dove può essere impiegata anche nella
produzione dei vini della Valpolicella. In Lombardia è presente anche nella DOC
di San Colombano al Lambro, l'unica della provincia di Milano. Nei Colli
Piacentini, insieme a Barbera e Uva rara, entra nella composizione del vino più
celebre di questo territorio: il Gutturnio. Nell'Oltrepo Pavese, la Croatina -
qui tradizionalmente chiamata Bonarda - è utilizzata nella produzione di vini
fermi e frizzanti, questi ultimi generalmente indicati con il termine
vivace. Nell'Oltrepo Pavese lo stile frizzante è decisamente più comune
di quello fermo, quest'ultimo certamente interessante, sebbene meno diffuso. La
Croatina è in genere utilizzata per la produzione di vini destinati al pronto
consumo - quindi dal carattere giovane e diretto - e generalmente vinificata
in contenitori inerti come la vasca d'acciaio.
Con lo scopo di mettere ulteriormente in evidenza le differenze, i vini che
sceglieremo per la nostra degustazione per contrasto apparterranno a due stili
distinti. Il primo vino è il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Frizzante
nello stile secco. Il disciplinare di produzione di questo vino prevede un
minimo di 85% di Lambrusco Grasparossa e la parte restante può essere
costituita da altre varietà Lambrusco e Malbo Gentile. Il vino che sceglieremo
dovrà essere possibilmente prodotto con Lambrusco Grasparossa in purezza, o
comunque nella percentuale più alta possibile. Il secondo vino della nostra
degustazione è la Bonarda dell'Oltrepo Pavese nello stile fermo, maturato in
contenitori inerti. Anche in questo caso si deve fare attenzione sulla
composizione poiché il disciplinare prevede un minimo di 85% di Croatina
e la restante parte di Barbera, Vespolina (qui detta Ughetta) e Uva Rara. Si
sceglieranno per entrambi i vini l'ultima annata in produzione e
saranno serviti alla temperatura di 16 °C.
Il primo vino del quale analizzeremo l'aspetto il Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro. Non appena inizieremo a versare questo vino nel calice, noteremo
immediatamente il formarsi di una schiuma abbondante dal colore rosa, a
conferma della celebre vivacità di questo stile di vino. Quando la schiuma si
sarà esaurita e sarà possibile vedere la superficie del vino, incliniamo il
calice sopra una tovaglietta bianca. Il colore di questo Lambrusco - osservato
alla base del calice - rivela una tonalità rosso rubino intenso, quasi cupo, e
una trasparenza piuttosto ridotta. La sfumatura, osservata all'estremità del
vino, verso l'apertura del calice, mostra un netto colore rosso porpora.
Passiamo ora all'osservazione della Bonarda dell'Oltrepo Pavese che, lo
ricordiamo, è in realtà prodotta con Croatina. Tenendo il calice inclinato
sopra una superficie bianca, alla base si osserverà un colore rosso rubino
intenso, con una trasparenza superiore rispetto al Lambrusco. La sfumatura,
osservata all'estremità del vino verso l'apertura del calice, mostra un colore
rosso rubino.
I profili olfattivi del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e della Bonarda
dell'Oltrepo Pavese si caratterizzano per i freschi e intensi profumi che
ricordano prevalentemente i frutti rossi e neri. Il Lambrusco Grasparossa
regala al naso del degustatore intese sensazioni di lampone, ciliegia, fragola,
melagrana e, spesso, la mandorla. Il profilo dei fiori si esprime in genere con
violetta e ciclamino. Nei profumi della Croatina si riconoscono prevalentemente
aromi di mora, ciliegia, prugna, mirtillo, lampone e amarena. Anche in
quest'uva si apprezzano sensazioni riconducibili ai fiori, in modo particolare
violetta, ciclamino e rosa. In misura minore, nella Croatina si può percepire
talvolta anche il profumo della mandorla amara. Non è raro percepire nella
Croatina l'aroma di fragola e, talvolta, quello del ribes. Nel Lambrusco
Grasparossa - grazie all'effervescenza, quindi all'effetto dell'anidride
carbonica - i profumi sembreranno avere un carattere fresco e pungente.
Iniziamo l'analisi dei profumi dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Manteniamo il calice in posizione verticale e, senza rotearlo, procediamo con
la prima olfazione che permetterà la valutazione degli aromi di apertura. Dal
calice percepiremo aromi di ciliegia, lampone e fragola, un profilo decisamente
orientato nelle sensazioni di frutti rossi e neri. Dopo avere roteato il
calice, operazione che favorirà la formazione di schiuma, pertanto sarà
necessario attendere che si dissolva, procediamo con la seconda olfazione. Il
profilo del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro si completa con aromi di
melagrana, violetta, ciclamino e un piacevole tocco di mandorla. Passiamo ora
alla valutazione dei profumi della Croatina espressi dalla Bonarda dell'Oltrepo
Pavese. L'apertura di questo vino regala mora, ciliegia e prugna, oltre a
mirtillo e violetta. Dopo avere roteato il calice, il profilo è completato da
ciclamino, rosa e, talvolta, ribes e mandorla. Si confrontino ora i due vini:
l'anidride carbonica del Lambrusco Grasparossa fa sembrare i suoi profumi più
“freschi” rispetto a quelli della Croatina.
La valutazione del gusto dei due vini metterà in evidenza le enormi differenze,
soprattutto il ruolo dell'anidride carbonica nella percezione delle altre
sensazioni. Iniziamo dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e prendiamo un
sorso di questo vino. In bocca percepiremo subito l'attacco intenso
dell'effervescenza che, fra le altre cose, contribuisce ad accentuare l'acidità
e l'astringenza dei tannini. L'apporto dell'alcol sembra piuttosto modesto: non
solo per l'effetto delle cosiddette sostanze dure (effervescenza, astringenza e
acidità) ma anche del moderato contenuto di alcol, in genere di 10,5°. Passiamo
all'assaggio della Bonarda dell'Oltrepo Pavese, prodotta con Croatina. In bocca
si percepisce un profilo completamente diverso e l'assenza dell'anidride
carbonica consente di meglio apprezzare le caratteristiche morbide del vino.
L'attacco è comunque di piacevole freschezza, con una sensazione di astringenza
moderata e che consente di percepire l'effetto pseudo calorico dell'alcol.
L'ultima fase della degustazione riguarda le sensazioni finali che i vini
lasciano in bocca dopo la deglutizione e come si sviluppano nel tempo. Dopo
avere deglutito il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, valutiamo il suo
finale. Questo vino ha generalmente buona persistenza e lascia in bocca ricordi
di ciliegia, lampone e fragola, oltre a una piacevole percezione di astringenza
e freschezza. Due sensazioni che, certamente, invitano ad apprezzare
ulteriormente questo vino. Il finale della Bonarda dell'Oltrepo Pavese -
prodotto con Croatina - si caratterizza di buona persistenza, lasciando in
bocca ricordi di mora, ciliegia e prugna. Si confrontino le sensazioni finali
dei due vini, in particolare la struttura, astringenza e acidità. Due vini
immediati e piacevoli che invitano certamente ad apprezzarli nuovamente dai
rispettivi calici. Due caratteri molto diversi, ma comunque ottimi
rappresentanti di come un vino può essere anche piacevole e gioioso, da
cogliere per l'esuberante e immediata fresca giovinezza.
|



 Sangiovese (85%), Syrah (15%)
Sangiovese (85%), Syrah (15%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, lampone e
ciclamino seguite da aromi di violetta, mirtillo, garofano e prugna.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, lampone e
ciclamino seguite da aromi di violetta, mirtillo, garofano e prugna.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, lampone e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di amarena, lampone e mirtillo. 6 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.
6 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia. Affettati, Pasta con carne e funghi, Carne saltata
Affettati, Pasta con carne e funghi, Carne saltata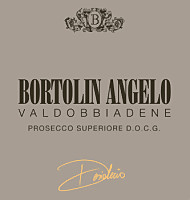
 Glera
Glera Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
glicine seguite da aromi di pera, ananas, biancospino, ginestra, camomilla
e mandarino.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
glicine seguite da aromi di pera, ananas, biancospino, ginestra, camomilla
e mandarino.
 Attacco effervescente e fresco, piacevolmente dolce, comunque
equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, piacevolmente dolce, comunque
equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pera.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pera. Fermentazione in autoclave per 40 giorni.
Fermentazione in autoclave per 40 giorni. Dessert alla crema, Dessert alla frutta
Dessert alla crema, Dessert alla frutta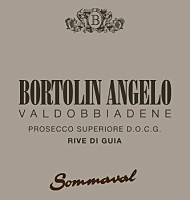
 Glera
Glera Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, ananas e glicine seguite da aromi di pera, mandarino, ginestra,
biancospino, pesca, crosta di pane, salvia e minerale.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, ananas e glicine seguite da aromi di pera, mandarino, ginestra,
biancospino, pesca, crosta di pane, salvia e minerale.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas. Fermentazione in autoclave per 60 giorni.
Fermentazione in autoclave per 60 giorni. Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Crostacei saltati, Latticini
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Crostacei saltati, Latticini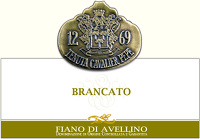
 Fiano
Fiano Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, pesca e nocciola seguite da aromi di pera, biancospino, mallo di
noce, ananas, nespola, susina, ginestra, minerale e vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, pesca e nocciola seguite da aromi di pera, biancospino, mallo di
noce, ananas, nespola, susina, ginestra, minerale e vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, pesca e nocciola.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e nocciola. 12 mesi in barrique, 10 mesi in bottiglia.
12 mesi in barrique, 10 mesi in bottiglia. Carne bianca arrosto, Stufati di pesce con funghi, Pesce arrosto
Carne bianca arrosto, Stufati di pesce con funghi, Pesce arrosto
 Aglianico
Aglianico Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora,
vaniglia, cacao, tabacco, grafite, liquirizia, macis, cuoio e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora,
vaniglia, cacao, tabacco, grafite, liquirizia, macis, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
 Syrah
Syrah Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, pepe nero, vaniglia,
cioccolato e grafite.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, pepe nero, vaniglia,
cioccolato e grafite.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e mirtillo. Una parte matura per 12 mesi in botte.
Una parte matura per 12 mesi in botte. Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi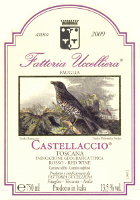
 Sangiovese (60%), Cabernet Sauvignon (40%)
Sangiovese (60%), Cabernet Sauvignon (40%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso aranciato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso aranciato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ribes e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, tabacco, liquirizia, cioccolato, cuoio, macis ed eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ribes e viola appassita seguite da aromi di amarena, mirtillo,
vaniglia, tabacco, liquirizia, cioccolato, cuoio, macis ed eucalipto.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena.
Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena. 14 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
14 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati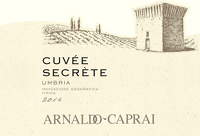
 n.d.
n.d. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pesca, pera e banana seguite da aromi di uva spina, mela, agrumi, susina,
ginestra, acacia, ortica, sambuco, minerale e un accenno di vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pesca, pera e banana seguite da aromi di uva spina, mela, agrumi, susina,
ginestra, acacia, ortica, sambuco, minerale e un accenno di vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, pesca e banana.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e banana. 6 mesi in barrique, 4 mesi in bottiglia.
6 mesi in barrique, 4 mesi in bottiglia. Pasta con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di legumi
Pasta con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di legumi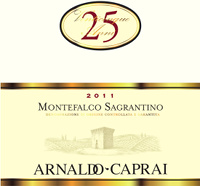
 Sagrantino
Sagrantino Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
peonia, cioccolato, tabacco, cannella, macis, pepe rosa, cuoio e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, vaniglia,
peonia, cioccolato, tabacco, cannella, macis, pepe rosa, cuoio e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, amarena e prugna.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, amarena e prugna. 24 mesi in barrique, almeno 8 mesi in bottiglia.
24 mesi in barrique, almeno 8 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
