
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 220, Settembre 2022 |
Sommario |
|
|
Vendemmia 2022: Fra Caldo Torrido e Siccità |
|
Da qualche anno, parlando della vendemmia e cercando di fare sommarie previsioni, si finisce sempre per sottolineare il crescente e preoccupante aumento delle temperature estive – e ogni anno sembra essere peggio – e la conseguente condizione di siccità. Negli ultimi anni, infatti, si ripetono le medesime condizioni climatiche e le impressioni dei produttori sembrano puntualmente coincidere con quelle dell'anno precedente. Troppo caldo, vendemmia anticipata, buona qualità con diminuzione più o meno seria della quantità, scarsità delle precipitazioni di piogge, sofferenza idrica della vite, conseguenti e inevitabili condizioni critiche in vigna. Il 2022, poi, è stato evidentemente più afoso e caldo del 2021, con pochissime piogge, maturazione delle uve – ovviamente in sofferenza idrica – ampiamente anticipata ovunque in Italia. Non è un caso, per esempio, che la vendemmia sia già iniziata in diverse regioni italiane e non solo per le cantine che producono vini spumanti. L'Italia, ovviamente, non è l'unico paese a fare i conti con le severe condizioni climatiche di questa estate, poiché situazioni analoghe sono segnalate praticamente in tutti i paesi dell'emisfero boreale. Non si tratta solamente di una condizione critica per la viticoltura, poiché riguarda l'intero comparto agricolo. La Francia, poi, sta registrando condizioni di siccità preoccupanti, tali da sottoporre la vite a un'eccessiva sofferenza idrica. Questa particolare condizione critica produce conseguenze diverse in accordo a diversi fattori. Il peggiore, decisamente, riguarda il corso della maturazione, soprattutto in estate, quando si realizza la fondamentale fase dello sviluppo degli acini e delle sostanze in esso contenute. In altre parole, è un momento fondamentale e cruciale che determina la qualità dell'uva e tutto quello che questa contribuisce al migliore risultato enologico, per qualunque stile di vino. A questo, inoltre, si deve considerare che non tutte le viti sono uguali. Va detto, infatti, che la capacità della vite di adattarsi a uno specifico tipo di terreno e scendere nella profondità del suolo alla ricerca dell'acqua, cambia in accordo alla varietà, più specificamente, al tipo e alle caratteristiche del portainnesto sul quale cresce. Com'è ben noto, a seguito della nefasta comparsa della fillossera nei vigneti europei alla fine del'1800 e inizi 1900, la coltivazione della vite è assicurata dall'impiego di portainnesti di varietà resistenti agli attacchi di questo temibile afide. I portainnesti, esattamente come le varietà di vite, sono diversi fra loro e ognuno ha capacità e caratteristiche colturali tali da renderli adatti e opportuni per il tipo di suolo specifico dove sarà piantato. Ci sono quindi portainnesti capaci di resistere maggiormente alle condizioni di stress idrico, mentre altri necessitano suoli umidi e capaci di trattenere l'acqua. La scelta del portainnesto della vite – infatti – è eseguita in modo meticoloso sia in base alla varietà dell'uva, sia del suolo dove nascerà il futuro vigneto. Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione in Italia, la vendemmia è iniziata con una settimana di anticipo rispetto all'anno scorso e si prevede un calo dei raccolti del 10%. Il motivo, in entrambi i casi, è determinato dalla siccità e dalle temperature che, soprattutto nel mese di luglio, hanno abbondantemente superato i 40 °C. I primi grappoli a essere raccolti in Italia sono stati quelli della Sicilia, ai primi di agosto, seguita dalla Franciacorta con la vendemmia delle varietà Pinot e Chardonnay. La produzione di vino in Italia è attualmente stimata in circa 45,5 milioni di ettolitri, con un calo – come già detto – del 10% rispetto al 2021. Le stime per la vendemmia 2022 fanno prevedere, in questo momento, un'annata di buona qualità, salvo cambiamenti meteorologici improvvisi nel corso delle prossime settimane e che potrebbero danneggiare i vigneti. In modo particolare, il verificarsi di piogge a ridosso della vendemmia e, ancor peggio, di grandine, evento – quest'ultimo – che causerebbe gravi danni alla sanità delle uve. A onore del vero, non tutte le regioni italiane lamentano danni dal caldo e dalla siccità allo stesso modo. Le differenze geografiche, territoriali e climatiche – così diverse da nord a sud – determinano necessariamente la criticità dei vigneti in modo diverso. In alcune regioni, infatti, le condizioni sembrano essere più critiche, mentre in altre, soprattutto al nord del paese e nei territori di montagna, non si registrano criticità particolari tali da compromettere il raccolto. In verità, in nessuna regione d'Italia si registrano – in questo momento – condizioni gravi e irreversibili tali da compromettere la vendemmia, salvo il calo generale delle quantità che si registra un po' ovunque in Italia. Poi, com'è ben noto per chiunque svolga un'attività agricola, viticoltura compresa, è proprio nelle annate come questa – segnate da caldo afoso e siccità più o meno grave – che si possono verificare episodi meteorologici improvvisi e funesti, come per esempio grandini e piogge abbondanti, che lasciano poco spazio alle speranze di raccogliere il frutto del proprio lavoro. La grave siccità, ovviamente, beneficerebbe enormemente da provvidenziali piogge capaci di placare la sete del suolo e consentire quindi alle radici di approvvigionarsi di acqua, un evento che potrebbe anche cambiare, in meglio, l'esito della vendemmia 2022. Questo, ovviamente, riguarderebbe solamente le varietà cosiddette tardive, cioè che maturano più tardi rispetto ad altre e che potrebbero temere gli effetti di improvvisi cambiamenti meteorologici negativi. Le varietà precoci, molto probabilmente, saranno state già raccolte un po' ovunque e sicuramente nelle regioni più calde del Paese, visto che le temperature di queste estate hanno imposto l'anticipo della vendemmia in diverse parti d'Italia. Se la zona centromeridionale europea guarda da anni con non poca preoccupazione all'aumento delle temperature estive e i lunghi periodi di siccità, più a nord, invece, beneficiano con soddisfazione di questi cambiamenti tanto da immaginare un importante futuro enologico. Dal Regno Unito, infatti, fanno sapere che i cambiamenti climatici che si sono verificati negli ultimi anni, stanno trasformando il paese in un territorio ideale per la produzione di vino, in particolare quelli prodotti con certe uve e certi stili. Se fino a qualche decennio fa la coltivazione della vite, quindi la produzione di vino, era una possibilità inimmaginabile in quelle terre, l'aumento delle temperature consentono oggi di produrre, e con successo, vini prodotti con uve che prediligono climi freschi, come il Pinot Nero. Da oltremanica, infatti, fanno sapere da tempo riescono a produrre vini spumanti che, nello stile, sono piuttosto simili agli Champagne francesi, proprio per il fatto che il clima sta cambiando, diventando sempre più simile a quello della Francia centrale e settentrionale. Non solo: nel Regno Unito prevedono – non da meno – che il probabile aumento delle temperature consentirà loro di divenire terra ideale per i vini rossi, in particolare quelli prodotti con Pinot Nero. Insomma, la Borgogna – e non solo – potrebbe avere un nuovo e temibile concorrente nell'arco di una decina di anni. Il professor Stephen Dorling, della Scuola di Scienze Ambientali dell'Università di East Anglia, osserva infatti che l'attuale produzione spumantistica del Regno Unito è caratterizzata da uno stile molto simile alle bollicine della Champagne francese. Un risultato che è stato principalmente determinato dai cambiamenti climatici tali da rendere il Regno Unito simile alla Francia. Questo cambiamento fa inoltre pensare che le migliori condizioni di coltivazione per il Pinot Nero si sposteranno, dalla Francia, verso nord, quindi nel Regno Unito. Nel frattempo, fanno inoltre sapere da oltremanica, che nel 2018, e per la prima volta, la produzione di vino rosso del Regno Unito ha superato quota 15,6 milioni di bottiglie. Insomma, se nei paesi europei storicamente dediti alla viticoltura e all'enologia – come l'Italia, appunto – ci si interroga con non poca preoccupazione sul futuro del vino a causa dell'aumentare delle temperature estive e della siccità, più a nord si intravvede un nuovo e glorioso futuro. Intanto, secondo le previsioni, – con la vendemmia 2022 e grazie all'andamento dell'annata – il Regno Unito confida di migliorare il risultato del 2018. Personalmente, sono certamente convinto che i vignaioli dell'Europa enologica – indipendentemente da quello che accadrà in Regno Unito – saranno capaci di regalarci magnifici vini per l'annata 2022 e per quelle future. Italia compresa e soprattutto, nonostante la difficile annata segnata da questo caldo opprimente e terribilmente afoso. Alla salute! Antonello Biancalana
|
||||
Contrasti di Gavi e Sannio FalanghinaCortese e Falanghina a confronto nei calici della degustazione per contrasto di questo mese. Due uve capaci di produrre straordinari vini, primarie glorie dell'enologia nelle provincia di Alessandria e Benevento. |
|
La produzione dei vini bianchi non è esattamente semplice e, senza nulla togliere agli altri stili di vini, produrre un vino bianco di elevata qualità è certamente più complesso e difficoltoso rispetto ad altri tipi. Ribadendo che, in ogni caso, fare vino di qualità è comunque difficile, quelli bianchi aggiungono l'ulteriore difficoltà di essere un prodotto soggetto a fattori ancor più critici e tali da comprometterne la loro finezza e qualità. Questo, ovviamente, in accordo allo stile e al tipo di vino da produrre, non da ultimo le uve impiegate per la sua produzione e le pratiche agronomiche ed enologiche adottate per il conseguimento di uno specifico risultato. Fra i fattori critici che possono compromettere la produzione di un vino bianco – salvo i casi quando questo è una qualità ricercata e voluta – è l'effetto dell'ossigeno, capace di alterare ogni aspetto organolettico di un vino bianco. L'ossigeno, infatti, oltre a rendere il colore di un vino bianco più “scuro”, appiattisce anche il suo profilo olfattivo, aumentando – nel contempo – la morbidezza gustativa a discapito della freschezza, restituendo, nel complesso, un vino bianco poco elegante e decisamente ordinario. Non fanno eccezione, ovviamente, i vini che verseremo nei calici della degustazione per contrasto di questo mese: Gavi e Sannio Falanghina. Questi due bianchi sono fra i protagonisti dell'enologia delle loro provincie – rispettivamente, Alessandria e Benevento – capaci di esprimere finezza e qualità, sebbene in modi e caratteri diversi. Alla base di questi due interessanti vini troviamo il Cortese, per quanto concerne il Gavi, e la Falanghina per il bianco prodotto nel grande territorio del Sannio, in provincia di Benevento. Si tratta di due varietà che vantano una lunga storia e sono presenti anche in altri territori, non solo in quelli delle rispettive regioni di origine. In entrambi i casi, sono vini di assoluta finezza ed eleganza, prodotti – nei rispettivi territori – in stili diversi e tutti di sicuro interesse. Queste due uve, infatti, dimostrano eccellente versatilità enologica, dai bianchi secchi a quelli da vendemmia tardiva, dagli spumanti ai vini dolci da uve appassite. Risultati interessanti, inoltre, sono ottenuti anche con la maturazione in legno, tecnica che permette comunque di conservare le qualità organolettiche specifiche delle due uve.
|
|
Il Gavi è un vino bianco del Piemonte, notoriamente terra di rossi, il quale territorio di produzione è riconosciuto dal sistema di qualità italiano come Denominazione d'Origine Controllata e Garantita, DOCG. Si tratta – considerando la vocazione enologica della sua regione – di un vino decisamente raro e unico, poiché in Piemonte, salvo alcune eccezioni, i vigneti sono per la maggioranza dei casi colorati da uve rosse. Il Gavi – o Cortese di Gavi – è protagonista di rilievo della provincia di Alessandria e vanta una storia antica e significativa. La prima menzione ufficiale riguardante il vino di Gavi risale, infatti, al 1659, citato in una lettera indirizzata al marchese Doria. Gavi è il nome della località in provincia di Alessandria dalla quale prende il nome il vino e che, a sua volta, porta questo nome – così narra la leggenda – alla bella principessa Gavia, figlia di Clodomiro, re dei franchi. Nel 528, la storia racconta, la principessa si stabilì in queste terre – per intercessione del papa – nel tentativo di sfuggire alle truppe del re Clodomiro, ricercata per essersi sposata in segreto e contro il parere del padre, con un giovane paggio di corte. Anche l'uva con la quale si produce il Gavi – il Cortese – pare debba il suo nome alla principessa Gavia, come omaggio alla sua bellezza e cortesia. Il Gavi è oggi vino a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (DOCG) ed è prodotto in undici comuni in provincia di Alessandria, esclusivamente con uva Cortese. Questo vino, che può essere chiamato anche “Cortese di Gavi”, è prodotto – in accordo al disciplinare di produzione – negli stili tranquillo, frizzante, spumante, riserva e riserva spumante metodo classico. Le tipologie tranquillo frizzante e spumante consentono opzionalmente l'indicazione geografica di provenienza, nello specifico, il comune e le frazioni dalle quali provengono effettivamente le uve. Il caso più emblematico è rappresentato dalla produzione svolta nel comune che da il nome al vino, spesso indicato in etichetta come “Gavi di Gavi”. La produzione del Gavi è prevalentemente condotta con la fermentazione e affinamento in contenitori inerti, in modo particolare, la vasca d'acciaio, tuttavia si registrano casi nei quali si ricorre all'uso di contenitori in legno, tecnica che, comunque, ben si adatta alle qualità specifiche dell'uva Cortese.
|
||||
|
Il Sannio è il grande territorio che si trova in provincia di Benevento ed è da anni un'affermata terra di produzione vitivinicola ed enologica. Riconosciuto come territorio a Denominazione d'Origine Controllata (DOC), il Sannio, in termini di superficie, è fra le principali denominazioni della Campania. L'area del Sannio comprende diverse sottozone, un tempo considerate come denominazioni specifiche – Solopaca, Sant'Agata dei Goti, Guardia Sanframondi o Guardiolo e Taburno – oggi incluse in questo ampio territorio, prevedendo l'impiego di varietà di uve bianche e rosse tipiche del territorio e della Campania. Fra queste, in modo particolare, la produzione di vini con uva Falanghina – grazie alla sua particolare personalità – si distingue per la definizione di una denominazione specifica e che – di fatto – si estende per l'intera superficie del Sannio DOC. I vini di questo territorio e prodotti con Falanghina, infatti, si denominano come “Sannio Falanghina” o “Falanghina del Sannio”, dal punto di vista legale, si tratta di una denominazione specifica e distinta. La Falanghina, varietà della Campania capace di produrre vini di notevole eleganza e personalità, è pressoché diffusa nell'intero territorio della regione e la sua presenza si registra anche in altre regioni, in particolare nel Molise e Puglia. Uva di notevoli potenzialità enologiche, la storia della Falanghina è ancora oggi incerta, a parte la sua origine riconducibile nel territorio alle pendici del monte Taburno – nell'appennino campano in provincia di Benevento – e dei Campi Flegrei in provincia di Napoli. In accordo al suo disciplinare di produzione, esattamente come accade per molti altri vini DOC italiani, il Sannio Falanghina prevede l'utilizzo minimo dell'85% dell'omonima varietà, mentre il restante 15% può essere costituito da uve non aromatiche ammesse alla coltivazione nella provincia di Benevento. Questo vino si produce negli stili “tranquillo”, spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, vendemmia tardiva e passito, prevedendo, inoltre le sottozone Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant'Agata dei Goti, Solopaca e Taburno. La vinificazione può essere condotta sia in contenitori inerti sia in botti di legno, tuttavia è bene osservare che la maggioranza della produzione ricorre all'impiego delle vasche d'acciaio, proprio per esaltare le qualità organolettiche specifiche della Falanghina.
|
Prima di versare nei nostri calici i vini della degustazione per contrasto di questo mese, provvediamo al loro acquisto, un'operazione che è certamente semplice vista la buona diffusione e disponibilità di questi vini nel mercato. Gavi e Sannio Falanghina sono infatti pressoché presenti e reperibili in qualunque negozio di vino, sia in stili diversi sia prodotti da cantine diverse. La scelta, come spesso accade per le nostre degustazioni per contrasto, è a favore di vini fermentati e maturati in contenitori inerti, in questo caso specifico, la vasca d'acciaio. La scelta del Gavi è certamente più semplice poiché – in accordo al suo disciplinare di produzione – è prodotto esclusivamente con uva Cortese. Per il Sannio Falanghina, invece, dovremo assicurarci che sia prodotto esclusivamente con l'omonima varietà poiché il suo disciplinare prevede un impiego minino dell'85%. Va detto, in ogni caso, che questa è la scelta più frequente di tutti i produttori, tuttavia è bene assicurarsi su questa caratteristica produttiva. Entrambi i vini appartengono all'ultima vendemmia disponibile e sono versati in calici da degustazione alla temperatura di 10 °C. La prima caratteristica organolettica che prenderemo in esame – come di consueto – è l'aspetto, cioè il modo con il quale i due vini si presentano alla nostra vista in termini di colore e trasparenza. Il primo vino che prendiamo in esame è il Gavi, quindi, inclinando il suo calice sopra una superficie bianca, osserviamo la base, dove la massa liquida è più spessa. Il colore del vino piemontese si presenta con un giallo paglierino brillante e intenso – tipico dei vini prodotti con uva Cortese – e, osservando verso l'apertura del calice, dove la massa liquida è più sottile, osserviamo una sfumatura dello stesso colore, talvolta giallo verdolino. La trasparenza del Gavi, valutata ponendo un oggetto fra il calice e la superficie bianca, è molto elevata. Passiamo ora alla valutazione dell'aspetto del Sannio Falanghina e, come per il vino precedente, incliniamo il suo calice sopra la superficie bianca. Il colore del vino campano, osservato alla base del calice, è caratterizzato da giallo paglierino brillante e intenso, non molto diverso dal Gavi. Anche la sfumatura conferma il colore di base, a volte con evidenti accenni di giallo verdolino. La trasparenza del Sannio Falanghina è, come nel vino precedente, molto elevata. I profili olfattivi di Gavi e Sannio Falanghina esprimono al naso profumi decisamente diversi, nonostante in entrambi si percepiscano caratteristiche comuni rappresentati da fiori e frutti a polpa bianca e gialla. Il protagonista del Gavi – vino a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita della provincia di Alessandria, in Piemonte – è il Cortese, varietà che ritroviamo anche in altri vini della regione ed è presente, sebbene marginalmente, anche in altre regioni italiane. Al naso, il Gavi esprime aromi di fiori e frutti, nei quali si riconoscono prevalentemente i profumi di biancospino e ginestra, oltre ad aromi di pera, mela, pesca e agrumi. Talvolta è inoltre possibile percepire il profumo della mandorla. Nel Sannio Falanghina si percepiscono aromi floreali di ginestra e biancospino, spesso di camomilla. Per quanto concerne i profumi di frutti, nell'uva campana si percepiscono prevalentemente mela, pera, susina e pesca, oltre a sensazioni di frutta esotica, in particolare ananas. Inoltre, non mancano accenni alla frutta secca, su tutti la nocciola. Riprendiamo la nostra degustazione per contrasto e analizziamo i profili olfattivi di Gavi e Sannio Falanghina, iniziando – come nella fase precedente – dal vino piemontese. Mantenendo il calice in posizione verticale e senza rotearlo, procediamo con l'analisi dell'apertura, cioè la valutazione dei profumi identificativi del vino. Dopo avere effettuato la prima olfazione, dal calice percepiamo aromi intensi e puliti di pera e mela, oltre al profumo floreale della ginestra. Provvediamo a roteare il calice, operazione che favorisce lo sviluppo dei restanti aromi, e procediamo con una nuova olfazione. Il profilo del Gavi è completato da profumi che ricordano agrumi, pesca, susina e mandorla, oltre alla sensazione floreale del biancospino e camomilla. Spesso, in questo vino, si percepisce anche il profumo dell'ananas. Passiamo alla valutazione dell'apertura del Sannio Falanghina ed effettuiamo la prima olfazione. Dal calice si percepiscono i profumi di mela, pera e susina oltre a un buon profumo di nocciola. Dopo avere roteato il calice e provveduto alla seconda olfazione, il profilo del vino campano si completa con biancospino, ginestra, agrumi, pesca, nespola oltre a sensazioni di frutta tropicale nelle quali riconosciamo l'ananas. Passiamo ora alla valutazione dei profili gustativi di Gavi e Sannio Falanghina, iniziando – come nelle fasi precedenti – dal vino prodotto nella provincia di Alessandria. Prendiamo il primo sorso così da valutare l'attacco del vino, cioè le sue qualità gustative primarie e identificative. In bocca si percepisce immediatamente la piacevole freschezza del Gavi conferita dall'acidità, ben equilibrata dall'effetto dell'alcol. Il vino ha inoltre buon corpo e struttura, oltre a esprimere ottima corrispondenza con il naso, in particolare nella chiara percezione dei sapori di mela, pera e susina. Passiamo ora alla valutazione dell'attacco del Sannio Falanghina e, quindi, prendiamo il primo sorso. Anche in questo vino notiamo immediatamente la piacevole freschezza conferita dall'acidita, prontamente equilibrata dall'effetto dell'alcol, generalmente maggiore rispetto al Gavi. Il Sannio Falanghina è inoltre caratterizzato da un buon corpo e struttura, oltre a esprimere ottima corrispondenza con il naso, riconoscibile nei sapori di mela, pera e pesca. Siamo giunti al termine della degustazione per contrasto di questo mese, quindi procediamo con la valutazione delle sensazioni finali che i due vini lasciano in bocca dopo la deglutizione, in modo particolare la persistenza gusto-olfattiva, primario fattore della qualità di un vino. Il finale del Gavi è persistente, lasciando in bocca la sua piacevole sensazione di freschezza oltre ai sapori di mela, pera e susina. Si noti, inoltre, la sensazione leggermente amarognola che si percepisce in bocca e nella quale si riconosce la mandorla. Il finale del Sannio Falanghina è parimenti persistente e, anche in questo caso, è la sensazione della freschezza conferita dall'acidità a dominare le fasi finali della sua degustazione. In bocca percepiamo inoltre i sapori di mela, pera e pesca, oltre a un'altra sensazione nella quale riconosciamo la nocciola. Entrambi i vini lasciano in bocca una netta sensazione di buon corpo, a conferma delle qualità enologiche delle uve con le quali sono stati prodotti. Prima di concludere, poniamo i calici di fianco e provvediamo con un'ultima olfazione dei due vini: le differenze olfattive risultano evidenti e distanti nonostante condividano le sensazioni di alcuni aromi riconducibili a fiori e frutti.
|
||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |

|
|
Vino Nobile di Montepulciano I Quadri 2018 |
|
| Bindella (Toscana, Italia) | |
 Sangiovese Sangiovese | |
| Prezzo: € 30,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e violetta seguite da aromi di peonia, geranio, lampone,
mirtillo, mora, cioccolato, cannella, tabacco, cuoio, pepe rosa, macis,
vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e violetta seguite da aromi di peonia, geranio, lampone,
mirtillo, mora, cioccolato, cannella, tabacco, cuoio, pepe rosa, macis,
vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
lampone.
 20 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 20 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati |
|
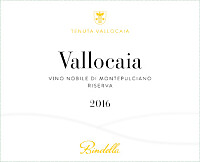
|
|
Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2016 |
|
| Bindella (Toscana, Italia) | |
 Sangiovese (90%), Colorino del Valdarno (10%) Sangiovese (90%), Colorino del Valdarno (10%) | |
| Prezzo: € 35,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
peonia, mirtillo, lampone, mora, cannella, cacao, tabacco, cipria,
liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
peonia, mirtillo, lampone, mora, cannella, cacao, tabacco, cipria,
liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
mirtillo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
mirtillo.
 2 anni in botte, 1 anno in bottiglia. 2 anni in botte, 1 anno in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
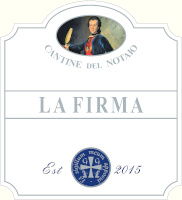
|
|
Aglianico del Vulture La Firma 2015 |
|
| Cantine del Notaio (Basilicata, Italia) | |
 Aglianico Aglianico | |
| Prezzo: € 32,90 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, lampone,
tabacco, cacao, carruba, cannella, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e
mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, lampone,
tabacco, cacao, carruba, cannella, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e
mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, mora e
prugna, Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, mora e
prugna,
 12 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 12 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati |
|
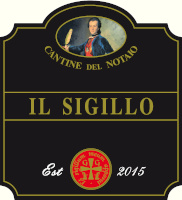
|
|
Aglianico del Vulture Il Sigillo 2015 |
|
| Cantine del Notaio (Basilicata, Italia) | |
 Aglianico Aglianico | |
| Prezzo: € 36,30 | Punteggio: |
 Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
carruba, tabacco, cioccolato, cannella, cipria, macis, cuoio, liquirizia,
vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
carruba, tabacco, cioccolato, cannella, cipria, macis, cuoio, liquirizia,
vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mora. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mora. 24 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati |
|

|
|
Frank! 2018 |
|
| Barollo (Veneto, Italia) | |
 Cabernet Franc Cabernet Franc | |
| Prezzo: € 22,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
lampone, peperone, cioccolato, caffè, tabacco, foglia di pomodoro,
cannella, cipria, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
lampone, peperone, cioccolato, caffè, tabacco, foglia di pomodoro,
cannella, cipria, vaniglia ed eucalipto.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna. 14 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 14 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. |
|
 Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi |
|
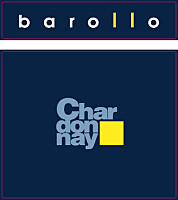
|
|
Venezia Chardonnay 2018 |
|
| Barollo (Veneto, Italia) | |
 Chardonnay Chardonnay | |
| Prezzo: € 22,00 | Punteggio: |
 Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, cedro e acacia seguite da aromi di biancospino, albicocca, mela,
pera, mango, papaia, susina, pompelmo, ananas, pralina, burro, miele,
pietra focaia e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, cedro e acacia seguite da aromi di biancospino, albicocca, mela,
pera, mango, papaia, susina, pompelmo, ananas, pralina, burro, miele,
pietra focaia e vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, cedro e
albicocca. Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, cedro e
albicocca.
 10 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 10 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. |
|
 Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Crostacei alla griglia Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Crostacei alla griglia |
|
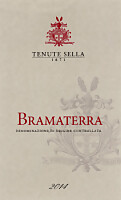
|
|
Bramaterra 2014 |
|
| Tenute Sella (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo (70%), Croatina (20%), Vespolina (10%) Nebbiolo (70%), Croatina (20%), Vespolina (10%) | |
| Prezzo: € 24,50 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso arancio, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso arancio, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
lampone, cannella, cacao, cuoio, tabacco, liquirizia, rabarbaro, vaniglia e
mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
lampone, cannella, cacao, cuoio, tabacco, liquirizia, rabarbaro, vaniglia e
mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 28 mesi in botte. 28 mesi in botte. |
|
 Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi |
|
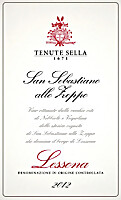
|
|
Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2012 |
|
| Tenute Sella (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo (85%), Vespolina (15%) Nebbiolo (85%), Vespolina (15%) | |
| Prezzo: € 40,00 | Punteggio: |
 Rosso granato brillante e sfumature rosso arancio, poco trasparente. Rosso granato brillante e sfumature rosso arancio, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
lampone, fragola, cacao, tabacco, cannella, cuoio, liquirizia, macis,
sottobosco, timo, zenzero, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita,
lampone, fragola, cacao, tabacco, cannella, cuoio, liquirizia, macis,
sottobosco, timo, zenzero, vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 36 mesi in botte. 36 mesi in botte. |
|
 Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi |
|
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
I Vini d'Abruzzo Ottengono il “Si Rating” |
||||
Per Ada Rosa Balzan, fondatrice e amministratore delegato di ARB: «Il mondo del vino sta già affrontando da tempo il tema della sostenibilità soprattutto nelle pratiche in campo, con attenzione alla riduzione degli impatti ambientali. È altrettanto importante misurare tutti i criteri ESG della sostenibilità, in ottica integrale del valore delle cantine, quindi anche economica finanziaria e questo è possibile con lo strumento SI rating». “Si Rating - Sustainability impact rating” è un indice basato su strumenti riconosciuti a livello internazionale e, al contempo, uno strumento strategico di analisi, di gestione e di comunicazione della sostenibilità. A crearlo ARB, start up innovativa con sede a Trento e società benefit per azioni dal 2021, in collaborazione con SASB, organizzazione no-profit che sviluppa standard contabili di sostenibilità, utilizzati dai più grandi player finanziari, tra cui Blackrock. Il risultato complessivo ottenuto dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha superato i canoni richiesti per la certificazione. A rafforzare il giudizio le ottime performance in alcuni settori, in particolare sul fronte delle Condizioni di Lavoro (80%), della Qualità del Servizio-Prodotto (71%) e del Codice di Condotta e Whistleblowing (73%). Il Consorzio tutela i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) – Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Villamagna – e i vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) come Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti , Terre Aquilane o Terre de L'Aquila. |
||||
Grappa: per la Prima Volta nella Lista Mondiale dei Cocktail |
| Si chiama Ve.N.To. ed è il primo cocktail a base di grappa a entrare nella
prestigiosa lista dei IBA (International Bartenders Association). La ricetta è
stata realizzata da Samuele Ambrosi (vice presidente Aibes) e Leonardo
Veronesi. «La storia della grappa porta in sé aromi e sentori della tradizione,
quindi l'idea di miscelarla e raccontare il territorio con un distillato che si
presta così bene alla miscelazione è stato naturale», racconta Ambrosi che
continua «la grappa è un distillato molto complesso, che in miscelazione non
permette errori. Per valorizzarla al meglio nei cocktail occorre innanzitutto
conoscere, gustare e analizzare con attenzione punti di forza e criticità di
ogni singolo prodotto». Insomma la miscelazione come nuovo modo di far
conoscere un prodotto della tradizione italiana, tra i distillati più
apprezzati al mondo, anche al pubblico dei più giovani. «Sta cambiando il
consumatore, ci stiamo avvicinando alla generazione Z ed è giusto raccontare la
nostra storia anche attraverso nuovi metodi di avvicinamento a questi nostri
futuri potenziali ambasciatori – spiegano dall'Istituto Tutela Grappa del
Trentino – portare le nostre grappe anche lontano dal territorio d'origine è
importante, per farlo tuttavia occorre affidarsi a professionisti che non solo
sappiano gestire la grappa con le sue qualità e peculiarità, ma che allo stesso
tempo sappiano raccontarne i valori». Il Cocktail Ve.N.To è genesi di una rivoluzione nei consumi della grappa di qualità. Il nome del Vento è un acronimo di Veneto e Trentino, per rimarcare la territorialità del drink, che in queste regioni vede nascere tutti gli ingredienti. La Grappa del Trentino punta proprio sul suo territorio grazie al rigido disciplinare che prevede di distillare solo bucce trentine. Il drink ha avuto un successo inaspettato, soprattutto all'estero, dove blog e riviste segnalano i favori del pubblico rispetto al Vento. Il drink permette che la grappa sia bevuta anche da coloro che di solito non la bevono, questo concetto è molto importante. La ricetta ufficiale prevede 45 ml di grappa giovane, 22,5 ml di Succo fresco di limone del Garda, 15 ml di Honey mix (l'acqua può essere sostituita da infuso di camomilla), 15 ml di cordiale alla camomilla e 10ml di bianco d'uovo (facoltativo). La tecnica utilizzata è quella dello Shake&Strain. Il cocktail viene servito su un bicchiere tumbler e guarnito con scorza di limone e acini di uva bianca. |
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
||||||||||||
Wine Guide ParadeMaggio 2022
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |