|
Franciacorta e Prosecco di Valdobbiadene sono certamente gli spumanti italiani
più celebri nel mondo. Rappresentanti delle bollicine italiane - ovviamente non
gli unici - esprimono metodi e stili produttivi molto diversi: il primo è
risultato del metodo classico, il secondo della rifermentazione in autoclave.
Due metodi diversi e che producono risultati spesso distanti fra loro, ognuno
capace di esaltare particolari caratteristiche enologiche e stili produttivi.
Non si può infatti parlare - e non avrebbe molto senso - di quale dei due sia
il migliore, poiché ognuno di questi ha caratteristiche proprie capaci di
esaltare aspetti enologici specifici. Allo stesso modo, sia il metodo classico
sia la rifermentazione in autoclave producono risultati apprezzabili solo con
determinate uve, non sempre utilizzabili, in termini qualitativi, con entrambi
i metodi.
La rifermentazione in autoclave tende all'esaltazione delle caratteristiche
aromatiche dell'uva, mentre il metodo classico trova il migliore impiego nella
produzione di spumanti di maggiore struttura e complessità sensoriale. Per
questi motivi, le uve generalmente utilizzate per la rifermentazione in
autoclave sono caratterizzate da un spiccata o comunque rilevante esuberanza
aromatica. Non è infatti un caso che con questo metodo si producono i celebri
Asti - da uve Moscato Bianco - e il Prosecco di Valdobbiadene, dall'omonima
uva, alla quale si preferisce oggi l'antico nome Glera. Il metodo classico
trova maggiore applicazione con uve capaci di produrre vini strutturati e non
particolarmente aromatiche, fra queste si ricordano Chardonnay, Pinot Nero e
Pinot Bianco. I tempi di produzione sono decisamente diversi in entrambi i
casi: alcuni mesi per la rifermentazione in autoclave, un minimo di un anno per
il metodo classico, tempo che comunque si considera - in questo caso -
brevissimo.
Due metodi molto diversi fra loro, adatti per una degustazione per contrasto.
Prima di iniziare la nostra valutazione dei vini, è opportuno ricordare - in
termini generali - le caratteristiche produttive dei due metodi. La
rifermentazione in autoclave è largamente impiegata nella produzione di
innumerevoli spumanti, nei quali si cerca di esaltare la giovane e fresca
aromaticità delle uve e dei vini. Il metodo fu ideato e brevettato da Federico
Martinotti nel 1895, all'epoca direttore dell'Istituto Sperimentale per
l'Enologia di Asti. Il metodo è stato ripreso nel 1910 dal francese Eugène
Charmat che, dopo averlo perfezionato, si diffuse e attribuito a quest'ultimo.
Questa tecnica è stata infine rivista e ulteriormente sviluppata nel 1970
dall'italiano Nereo Cavazzani, introducendo degli agitatori così da ottenere
maggiore complessità del vino e allungando i tempi di produzione. Il metodo è
oggi noto come “Martinotti-Charmat”, così come “metodo italiano”, “metodo
Martinotti” e, infine, “metodo Charmat”.
La produzione di uno spumante mediante questo metodo prevede generalmente
l'impiego di un vino base e successivamente introdotto all'interno di un
autoclave, pertanto un contenitore tenuta stagna. Si introduce anche una
miscela di lieviti, operazione che darà inizio alla seconda fermentazione del
vino. A causa della tenuta stagna dell'autoclave, l'anidride carbonica non si
disperde e pertanto si solubilizza con il vino producendo la caratteristica
effervescenza. La fermentazione si conclude generalmente in circa venti giorni,
mentre l'intero processo ha durata variabile a seconda del tipo di vino che si
desidera ottenere. Lo “Charmat corto” si realizza in circa tre mesi, mentre
raddoppiando questo tempo - sei mesi - il metodo prende nome di “Charmat
lungo”, usato per la produzione di vini di maggiore complessità. Il metodo
ideato da Cavazzeni prevede tempi che possono arrivare anche a 12 mesi,
aumentando sia la struttura del vino sia la complessità organolettica.
La produzione di uno spumante con il metodo classico è decisamente più antica e
prevede la rifermentazione di un vino base all'interno di una bottiglia. Reso
celebre nel mondo dallo Champagne, il metodo classico è detto méthode
champenoise in Francia, mentre in Italia è noto come “metodo tradizionale” o
“metodo benedettino”. Al vino base si aggiunge una miscela di lieviti
selezionati e si pone in una bottiglia capace di resistere all'alta pressione.
La particolarità del metodo classico consiste nel lungo tempo di permanenza del
vino all'interno della bottiglia, ed è proprio questa caratteristica a
conferire maggiore complessità a questi vini. Un tempo che può durare anche
molti anni, in ogni caso è raro che questo sia inferiore ai dodici mesi. I
lieviti, al termine della fermentazione, si decompongono e rilasciano al vino
le proprie caratteristiche sensoriali, aumentandone - nel contempo - la
struttura.
|
 | |
| Il perlage di uno spumante prodotto
con il metodo della rifermentazione in autoclave | |
|
La bottiglia è successivamente aperta - operazione detta sboccatura - si
rimuove la frazione di sedimento prodotta dai lieviti, si aggiunge
eventualmente la cosiddetta liqueur d'expédition, quindi ritappata con
il classico tappo a fungo. Ruolo determinante nella definizione del carattere
di uno spumante metodo classico è svolto dalla liqueur d'expédition, che
definisce, fra l'altro, anche la dolcezza del vino. Prodotta con ricette
segrete e che caratterizzano ogni produttore, è generalmente composta da vino e
zucchero - talvolta anche acquaviti - e sovente vini maturati in botte o
barrique. L'aggiunta di questo composto prende il nome di dosaggio e il
suo uso non è previsto per gli stili pas dosé o nature, poiché si
tratta di vini assolutamente secchi e, per così dire, non corretti.
L'aggiunta della liqueur d'expédition consente infatti ai produttori di
effettuare correzioni sulle caratteristiche sensoriali di un vino: gli spumanti
metodo classico pas dosé di qualità esigono - di fatto - pratiche di
produzione ineccepibili.
Per ogni eventuale approfondimento sulle rispettive tecniche di produzione, si
rimandano i lettori agli articoli sull'argomento pubblicati in passato. La
nostra degustazione per contrasto prenderà in esame un Franciacorta Brut non
millesimato e prodotto con le tipiche tre uve previste dal disciplinare:
Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco. A tale proposito, si ricorda che il
disciplinare di produzione del Franciacorta, prevede un tempo minimo di
permanenza sui lieviti di 18 mesi, ma non è raro che sia più lungo. Nello
scegliere il Prosecco di Valdobbiadene si avrà cura di selezionarne uno
prodotto interamente con uva Glera, ricordando che in questo vino possono
essere impiegate anche altre varietà, fra queste Verdiso e Perera. Si sceglierà
uno stile Extra Dry, di fatto, il grado di dolcezza più consueto per questo
vino. La degustazione sensoriale sarà svolta in due calici distinti e i vini
serviti alla temperatura di 10 °C, così da esaltare - per quanto possibile - il
rispettivo profilo olfattivo, assicurando quindi un buon sviluppo
dell'effervescenza.
Versiamo i due vini nei calici e iniziamo la nostra degustazione comparativa,
procedendo con la valutazione dell'aspetto. Una delle caratteristiche
specifiche di questo tipo di vini è rappresentato dall'effervescenza, in
particolare dallo sviluppo delle bollicine. Il primo contrasto che si rileva
dall'osservazione dei due calici è infatti relativo sia alla dimensione delle
bollicine sia al loro sviluppo. Gli spumanti prodotti con il metodo della
rifermentazione in autoclave presentano, in termini generali, delle bollicine
più grandi rispetto a quelle prodotte dal metodo classico. Si noteranno inoltre
differenze sullo sviluppo dell'effervescenza: più ordinata e lineare nel
Franciacorta, più vivace e rapida nel Prosecco. A causa dei tempi di
produzione, decisamente più lunghi nel Franciacorta, il colore del Prosecco
mostra delle sfumature giallo verdolino, qualità difficilmente presente nel
Franciacorta.
I contrasti continuano in modo evidente anche al naso. In termini generali, le
varietà aromatiche o semi aromatiche si adattano molto bene alla
rifermentazione in autoclave, pertanto il Prosecco è certamente adatto a questo
tipo di spumantizzazione. Le uve con minore impatto aromatico - ma comunque
capaci di produrre vini di buona struttura - trovano migliore impiego nella
rifermentazione in bottiglia. Va detto che anche nella rifermentazione in
autoclave si possono produrre vini con lungo affinamento, caratteristica che
conferisce maggiore struttura e complessità olfattiva. La complessità
sensoriale è comunque caratteristica dei metodo classico - a patto che si
consenta un'adeguata permanenza in bottiglia prima della sboccatura - nella
quale la decomposizione dei lieviti svolge un ruolo fondamentale. Questa
particolarità produttiva rende il metodo classico poco adatto alle varietà
aromatiche poiché i loro caratteristici profumi sarebbero persi o modificati
in modo sostanziale.
Iniziamo la valutazione degli aromi dal Prosecco di Valdobbiadene. Manteniamo
il calice in posizione verticale e senza rotearlo, quindi procediamo con
l'analisi degli aromi di apertura. Il profilo olfattivo di questo vino è
prevalentemente orientato verso sensazioni di frutti e fiori, in particolare
pera, mela, glicine e ginestra. L'apertura del Franciacorta si esprime
decisamente su aromi diversi, più complessi rispetto al Prosecco. Dal calice si
percepiranno sensazioni di mela, crosta di pane, lievito e banana, spesso la
nocciola. Procediamo con la roteazione dei calici così da favorire lo sviluppo
delle restanti caratteristiche olfattive. Il Prosecco prosegue la sequenza
olfattiva con sensazioni riconducibili a frutti e fiori, in particolare ananas,
biancospino e susina, compresi accenni di agrumi e frutta esotica. Lo sviluppo
del Franciacorta prosegue su sensazioni complesse così come frutti, ad esempio
susina, pera, burro, pralina, pompelmo, pralina, brioche e scorza d'agrume.
Contrasti che proseguono, inevitabilmente, anche all'esame gustativo.
Assaggiamo il Prosecco di Valdobbiadene: in bocca conferma il profilo fruttato
già percepito al naso - si riconoscono mela, pera e pesca - con un attacco
effervescente accompagnato da moderata dolcezza e viva freschezza. La struttura
è di medio corpo e, talvolta, anche leggero. Si valuti ora il Franciacorta:
l'attacco è effervescente e fresco, con un impatto dell'anidride carbonica meno
aggressivo rispetto al vino precedente. Il sapore è secco con un lievissimo
accenno di dolcezza, tuttavia bilanciato dall'acidità. La struttura, messa a
confronto con il Prosecco, è decisamente maggiore. Si percepirà - inoltre - una
maggiore morbidezza: non solo il segno di una maturazione più lunga, ma anche
il contributo dei lieviti e delle varietà tipicamente usate nella produzione di
questo vino.
La fase finale della degustazione, nella quale si valutano le sensazioni
prodotte in bocca dai vini dopo la loro deglutizione, continua a mettere in
evidenza i contrasti tra Franciacorta e Prosecco di Valdobbiadene. Entrambi i
vini - in termini generali - sono caratterizzati da una persistenza certamente
lunga, a conferma della qualità per la quale si conoscono. Il finale del
Prosecco di Valdobbiadene lascia in bocca una sensazione più esile rispetto al
Franciacorta, oltre a un vago ricordo di dolcezza, totalmente assente del
celebre metodo classico lombardo. Il Prosecco di Valdobbiadene si fa apprezzare
per i sapori di frutti, gli stessi percepiti al naso, mentre il Franciacorta
regala un profilo decisamente più complesso e morbido. Due stili di produzione
spumantistica totalmente diversi fra loro, due modi di interpretare le
bollicine a volte in modo opposto, sia in termini produttivi sia per le
diverse caratteristiche organolettiche.
|


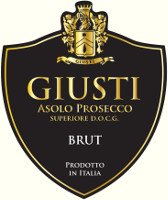
 Glera
Glera Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e
glicine seguite da aromi di pesca, biancospino, ananas, agrumi e ginestra.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e
glicine seguite da aromi di pesca, biancospino, ananas, agrumi e ginestra.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
leggero, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
leggero, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca. Fermentazione in autoclave.
Fermentazione in autoclave. Aperitivi, Latticini, Risotto con crostacei e verdure, Uova
Aperitivi, Latticini, Risotto con crostacei e verdure, Uova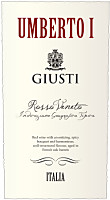
 Merlot, Cabernet Sauvignon
Merlot, Cabernet Sauvignon Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco,
liquirizia, vaniglia, cioccolato, cuoio, macis ed eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, tabacco,
liquirizia, vaniglia, cioccolato, cuoio, macis ed eucalipto.
 Attaco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attaco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.
Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena. 30 mesi in barrique.
30 mesi in barrique. Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
 Nero d'Avola
Nero d'Avola Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di prugna, amarena e mora
seguite da aromi di violetta, mirtillo e geranio.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di prugna, amarena e mora
seguite da aromi di violetta, mirtillo e geranio.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. 6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.
6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. Paste ripiene, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi
Paste ripiene, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi
 Passerina
Passerina Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
ananas seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino, ginestra e susina.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
ananas seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino, ginestra e susina.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca.
Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca. Maturazione in vasche d'acciaio.
Maturazione in vasche d'acciaio. Pasta con pesce e funghi, Pesce stufato, Zuppe di funghi
Pasta con pesce e funghi, Pesce stufato, Zuppe di funghi
 Montepulciano (65%), Sangiovese (25%), Cabernet Sauvignon (10%)
Montepulciano (65%), Sangiovese (25%), Cabernet Sauvignon (10%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna,
amarena e ribes seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, vaniglia,
tabacco, cioccolato e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna,
amarena e ribes seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, vaniglia,
tabacco, cioccolato e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e ribes.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e ribes. 14 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.
14 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
 Sangiovese (90%), Cabernet Sauvignon (10%)
Sangiovese (90%), Cabernet Sauvignon (10%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e ribes seguite da aromi di violetta, mirtillo, ciclamino, vaniglia,
tabacco, cioccolato e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e ribes seguite da aromi di violetta, mirtillo, ciclamino, vaniglia,
tabacco, cioccolato e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes. 12 mesi in barrique.
12 mesi in barrique. Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati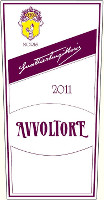
 Sangiovese (75%), Cabernet Sauvignon (20%), Syrah (5%)
Sangiovese (75%), Cabernet Sauvignon (20%), Syrah (5%) Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, ribes e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, mora,
vaniglia, cipria, cacao, tabacco, cannella, macis ed eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, ribes e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, mora,
vaniglia, cipria, cacao, tabacco, cannella, macis ed eucalipto.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, ribes e prugna.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, ribes e prugna. 12 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.
12 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
 Uva di Troia
Uva di Troia Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
mirtillo e mora seguite da aromi di prugna, viola appassita, tabacco,
carruba, cioccolato, vaniglia e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
mirtillo e mora seguite da aromi di prugna, viola appassita, tabacco,
carruba, cioccolato, vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. 12 mesi in barrique, 3 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
12 mesi in barrique, 3 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia. Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi stagionati
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi stagionati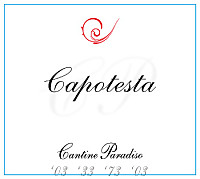
 Primitivo
Primitivo Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, mora e
amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, vaniglia,
cioccolato, tabacco, cannella, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, mora e
amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, vaniglia,
cioccolato, tabacco, cannella, macis e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di prugna, mora e amarena.
Finale persistente con ricordi di prugna, mora e amarena. 12 mesi in barrique, 5 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
12 mesi in barrique, 5 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia. Paste ripiene con carne, Stufati di carne, Carne alla griglia, Carne arrosto
Paste ripiene con carne, Stufati di carne, Carne alla griglia, Carne arrosto
 Barbera (40%), Nebbiolo (40%), Dolcetto (20%)
Barbera (40%), Nebbiolo (40%), Dolcetto (20%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ciliegia e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, cioccolato, pepe rosa, cipria, tabacco e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, ciliegia e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo,
vaniglia, rosa, cioccolato, pepe rosa, cipria, tabacco e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. 12 mesi in botte, 2 mesi in bottiglia.
12 mesi in botte, 2 mesi in bottiglia. Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati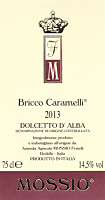
 Dolcetto
Dolcetto Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, fragola,
lampone, geranio, ciclamino, anice, mandorla e menta.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, fragola,
lampone, geranio, ciclamino, anice, mandorla e menta.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, mora e
mirtillo.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, mora e
mirtillo.
 Maturazione in vasche d'acciaio.
Maturazione in vasche d'acciaio. Salumi, Pasta con carne e funghi, Carne bianca arrosto, Carne saltata
Salumi, Pasta con carne e funghi, Carne bianca arrosto, Carne saltata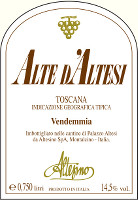
 Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, ribes e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, mora,
vaniglia, tabacco, cioccolato, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, ribes e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, mora,
vaniglia, tabacco, cioccolato, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna.
Finale persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna. 14 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.
14 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia. Carne arrosto, Carne alla griglia, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Carne alla griglia, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
 Sangiovese
Sangiovese Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e lampone seguite da aromi di violetta, mirtillo, rosa
appassita, vaniglia, tabacco, cioccolato, liquirizia, cannella, pepe rosa,
macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e lampone seguite da aromi di violetta, mirtillo, rosa
appassita, vaniglia, tabacco, cioccolato, liquirizia, cannella, pepe rosa,
macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
lampone.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e
lampone.
 24 mesi in botte, 4 mesi in barrique, 4 mesi in bottiglia.
24 mesi in botte, 4 mesi in barrique, 4 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
