|
Questo mese versiamo nei nostri calici due vini bianchi del Friuli Venezia
Giulia e prodotti con due delle uve bianche più celebri di questa terra. Questa
regione del nord est d'Italia offre un panorama di uve e territori piuttosto
singolare, certamente fra le terre da vino più celebri del nostro Paese anche
al di fuori dei nostri confini. Celebre in particolare per i suoi vini bianchi,
il Friuli Venezia Giulia, oltre a ospitare nei suoi vigneti varietà alloctone,
propone vini di notevole interesse enologico prodotti con uve assolutamente
autoctone. Il legame del Friuli Venezia Giulia con le uve bianche è profondo e
storico, nonostante oggi le uve rosse coltivate nella regione riscuotano un
enorme successo e non solo in Italia. I vini bianchi del Friuli Venezia Giulia,
e quindi delle sue uve autoctone e internazionali, ricoprono infatti un ruolo
di primaria importanza nello scenario enologico italiano.
Molte le uve che si trovano in questa regione e tutte di straordinario valore
enologico, con una produzione che abbraccia virtualmente ogni stile di vino,
dai bianchi ai vini dolci da uve appassite. Fra le uve bianche, spicca
certamente per fama e prestigio, quello che oggi si chiama Friulano, dopo le
vicende recenti che hanno imposto il cambio di nome a quello che è stato per
lunghissimo tempo noto come Tocai Friulano. Non si tratta, comunque, dell'unica
gloria del Friuli Venezia Giulia, poiché tante le uve che hanno reso celebre la
regione, come le bianche Ribolla Gialla, Verduzzo, Malvasia Istriana e Picolit,
le rosse Refosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe.
Nella regione abbondano anche le varietà internazionali, introdotte
copiosamente nel territorio, esattamente come tutto il nord est d'Italia, dopo
i nefasti effetti della fillossera. La diffusione delle uve internazionali è
ancora oggi significativa, tanto che si ritrovano ampiamente presenti in molti
vini a Denominazione d'Origine Controllata della regione.
Il Friulano ha ricevuto enorme attenzione in tempi recenti a causa della lunga
vicenda che lo ha visto opposto al vino ungherese Tokaji, al termine della
quale fu imposto il cambiamento di nome. A seguito di questa decisione, a
partire dal Marzo 2007, al glorioso Tocai Friulano - spesso chiamato
semplicemente “Tocai” - è stato attribuito il nome di Friulano, dopo avere
valutata anche la possibile adozione di Tai. Il Friuli Venezia Giulia
tentò, senza successo, di opporsi a questa decisione, pertanto a partire dalla
vendemmia 2008 nelle etichette delle bottiglie è scomparso Tocai
Friulano per essere sostituito con Friulano. Si tratta, ovviamente,
della stessa uva, alla quale è stato imposto di cambiare nome ma certamente non
la sua gloria e grandezza. Si deve in ogni caso notare che nessuna delle uve
usate per la produzione del vino ungherese Tokaji - la più celebre di queste è
il Furmint - ha legami con il Friulano e si tratta di varietà completamente
diverse.
I vini prodotti con il Friulano offrono ai sensi del degustatore qualità
tipiche tali da conferire loro una spiccata personalità. La mandorla amara è
certamente una delle principali sensazioni olfattive che si possono cogliere
dal calice di un vino di Friulano, qualità che - va detto - condivide anche con
altre uve. I vini prodotti con Friulano si fanno apprezzare anche per un
piacevole sapore amarognolo che si può percepire dopo avere deglutito in vino.
La maggioranza dei vini prodotti con quest'uva sono secchi, tuttavia si
registrano alcuni esempi di vini dolci. Il Friulano raggiunge la massima
diffusione nel Friuli Venezia Giulia, sua terra di origine. Si deve comunque
notare che è inoltre presente, in misura marginale, in Veneto - lo ritroviamo
anche nel Bianco di Custoza - e in Lombardia nei vini di San Martino della
Battaglia. Il Friulano è generalmente vinificato in contenitori inerti -
con lo scopo di conservare il suo caratteristico aroma di mandorla amara -
e non mancano comunque vini fermentati e maturati in botte.
Diversa è la storia della Malvasia Istriana, per meglio dire, delle Malvasie,
visto che con questo nome si identifica generalmente una famiglia piuttosto
vasta di uve. Si tratta di varietà molto antiche e che hanno da sempre riscosso
notevole attenzione, grazie ai loro celebri vini dei quali si trovano numerose
testimonianze in molti documenti del passato. Il nome Malvasia deriva dalla
città greca di Monemvasia, nel Peloponneso, dove i celebri vini prodotti
in questa zona prendevano la via del mare per raggiungere tutta Europa.
Monemvasia subisce le modifiche linguistiche del tempo e diviene
Malvasia, termine usato per definire i vini che ricordavano lo stile enologico
originale della città greca. La diffusione delle Malvasie è vastissima, tanto
da registrare - solo in Italia - numerose varietà diverse e che portano
questo nome, sia a bacca bianca sia nera.
|
 | |
| Il colore
giallo paglierino del Colli Orientali del Friuli Friulano | |
|
Le uve appartenenti alla famiglia delle Malvasie si considerano, in termini
generali, varietà semi aromatiche, cioè capaci di produrre vini con qualità
sensoriali che ricordano l'uva, seppure non in modo dominante. Questa
caratteristica è variamente presente nei vini prodotti con le varietà
cosiddette Malvasie, tuttavia quella Istriana rappresenta un'eccezione a questa
particolare qualità. Se è vero che nei vini prodotti con Malvasie si può
percepire il profumo dell'uva, lo stesso che si percepisce nel Moscato Bianco,
nella Malvasia Istriana questa caratteristica è assente. Delle Malvasie, quella
Istriana conserva la qualità di produrre vini di corpo moderato tuttavia
eleganti, soprattutto quelli da uve coltivate in zone di pianura. La Malvasia
Istriana è diffusa particolarmente nel Collio e nel Carso - da qui provengono
le migliori espressioni della regione - ed è inoltre coltivata nella vicina
Slovenia e in Croazia dove è conosciuta con il nome di Malvazija
Istarska. Come nel caso del Friulano, la Malvasia Istriana è prevalentemente
vinificata in contenitori inerti e la produzione in botte è decisamente meno
diffusa.
La nostra degustazione per contrasto prenderà in esame un Colli Orientali del
Friuli Friulano e un Collio Malvasia. Da notare che, generalmente, nelle
bottiglie di Malvasia raramente è riportato il termine “Istriana”,
caratteristica che si deve comunque intendere sottintesa, poiché si tratta
esclusivamente di Malvasia Istriana. Nella scelta dei vini ci orienteremo su
esemplari vinificati in contenitori inerti, preferibilmente vasche d'acciaio,
così da potere meglio apprezzare le qualità specifiche delle due uve. La
ricerca dei due vini con queste caratteristiche non dovrebbe essere difficile
poiché la vinificazione in contenitori inerti è quella più frequentemente
impiegata per entrambe le varietà. I due vini dovranno appartenere all'ultima
annata in commercio, pertanto ci concentreremo sulla comparazione di vini
giovani. Il nostro Colli Orientali del Friuli Friulano e Collio Malvasia
saranno serviti in calici da degustazione alla temperatura di 10 °C.
Dopo avere versato nei calici i due vini, iniziamo la nostra degustazione per
contrasto dall'esame visivo, cioè dalla fase nella quale si valuta il colore e
la trasparenza. Inizieremo l'esame visivo valutando il calice del Colli
Orientali del Friuli Friulano. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca
e osserviamo il vino alla base. Il colore che il Friulano regala alla nostra
vista è giallo paglierino intenso e brillante, spesso con tonalità che si
uniscono al giallo verdolino. La sfumatura del Friulano, osservata
all'estremità del calice, mostra un colore giallo verdolino, anche a
testimoniare la giovane eta del vino. Il colore del Collio Malvasia è
decisamente più chiaro del Friulano: qui è il giallo verdolino che si
percepisce in modo netto, brillante e intenso, a volte con richiami di giallo
paglierino. La sfumatura della Malvasia non è diversa da quanto osservato alla
base del calice, confermando un'evidente tonalità giallo verdolino.
I profumi espressi dal Friulano e dalla Malvasia Istriana offrono ai sensi del
degustatore profili olfattivi nei quali si evidenziano notevoli differenze. Una
delle qualità dominanti del Friulano si esprime con un deciso aroma di mandorla
amara, una caratteristica molto apprezzata nei vini prodotti con questa
varietà. Per completezza, va detto che l'aroma di mandorla amara si percepisce
anche in altre varietà, prevalentemente a bacca bianca, non mancando comunque
casi di uve rosse. Nel Friulano, ovviamente, c'è molto più della mandorla
amara, un profilo olfattivo nel quale si esprimono aromi di frutti a polpa
bianca e gialla e fiori. Il profilo olfattivo della Malvasia Istriana
differisce in modo sostanziale rispetto al Friulano, trovando anche nei vini di
questa varietà interessanti espressioni di frutti e fiori. La maturazione in
legno dei vini prodotti con queste due varietà, sebbene sia pratica meno
diffusa, aggiunge aromi terziari che a volte tendono a coprire le qualità
tipiche delle due uve. Per questo motivo, è proprio la bravura del produttore a
preservare la personalità del Friulano e della Malvasia Istriana aggiungendo,
nel contempo, complessità ai profumi del vino.
Iniziamo la valutazione dei profumi partendo dal Colli Orientali del Friuli
Friulano. Manteniamo il calice in posizione verticale e senza rotearlo,
procedendo con la prima olfazione così da apprezzare l'apertura del vino. Dal
calice si percepisce, in modo netto ed evidente, il caratteristico profumo di
mandorla amara, ben amalgamato a sensazioni che ricordano frutti a polpa
bianca. Nello specifico, il Friulano regala aromi di apertura di mela, pera e
mandorla amara. Dopo avere roteato il calice, lo incliniamo verso il naso,
completando il profilo con biancospino, pesca, ginestra, susina, ananas e,
talvolta, fieno. Passiamo ora all'apertura del Collio Malvasia. La prima
olfazione porta ai nostri sensi gli aromi di mela, pesca e biancospino, ben
diverso dal Friulano. Si noterà l'assenza della mandorla amara, così come
l'accenno di uva, spesso presente nelle uve appartenenti alla famiglia delle
Malvasie. Dopo avere roteato il calice, il profilo olfattivo del Collio
Malvasia si completa con pera, susina, albicocca, agrumi, così come sensazioni
di frutti tropicali come ananas e banana.
L'assaggio dei due vini mette in evidenza differenze sostanziali, non solo
nel gusto ma anche nelle sensazioni tattili, la struttura in particolare.
L'attacco del Colli Orientali del Friuli Friulano è caratterizzato da una
piacevole freschezza e una buona struttura. In bocca si percepisce la
corrispondenza con il naso, in particolare con la mandorla amara, mela, susina
e pesca. Anche l'attacco del Collio Malvasia è di piacevole freschezza ma, a
differenza del Friulano, la percezione della struttura è decisamente più esile,
pur conservando una notevole piacevolezza. La corrispondenza con il naso è
decisamente buona e si potranno cogliere i netti sapori di mela, pesca e pera,
a volte l'ananas. In entrambi i casi è evidente il ruolo dell'alcol -
facilmente raggiunge i 13° - donando equilibrio alla freschezza dei due vini e
rendendoli particolarmente asciutti.
La parte conclusiva della nostra degustazione per contrasto continua a
evidenziare sostanziali differenze fra il Friulano e la Malvasia Istriana. Il
finale del Colli Orientali del Friuli Friulano fa emergere ancora il
caratteristico sapore di mandorla amara, donando al vino il tipico finale
amarognolo, piacevole quando non è eccessivamente intenso. La persistenza è
generalmente molto buona, lasciando in bocca, oltre alla già citata mandorla
amara, sapori di mela, susina, pesca e pera. Ben diverso il finale del Collio
Malvasia che si fa apprezzare per la sua piacevole freschezza, con una buona
persistenza nella quale si percepiscono i sapori di pesca, mela, susina e
ananas. La sensazione di struttura è diversa nei due vini: nel finale, il
Friulano lascia in bocca una sensazione di struttura più robusta rispetto alla
Malvasia Istriana. Si tratta, in ogni caso, di due vini piacevoli e immediati,
spesso prodotti proprio per favorire l'estrema piacevolezza che le due varietà
del Friuli Venezia Giulia riescono a regalare ai loro vini.
|



 Trebbiano Spoletino
Trebbiano Spoletino Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
nespola, mela e pera seguite da aromi di pesca, litchi, susina, biancospino,
ananas, ginestra, miele, minerale e accenni di vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
nespola, mela e pera seguite da aromi di pesca, litchi, susina, biancospino,
ananas, ginestra, miele, minerale e accenni di vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, nespola e susina.
Finale persistente con ricordi di mela, nespola e susina. 6 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.
6 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia. Salumi, Pasta con carne, Pesce arrosto, Carne bianca saltata
Salumi, Pasta con carne, Pesce arrosto, Carne bianca saltata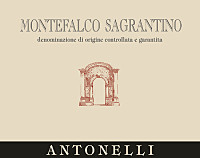
 Sagrantino
Sagrantino Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, cioccolato, cuoio, vaniglia, cannella, macis, pepe rosa e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
tabacco, cioccolato, cuoio, vaniglia, cannella, macis, pepe rosa e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. 24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.
24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati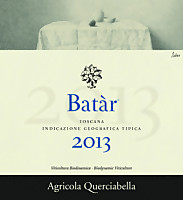
 Chardonnay (50%), Pinot Bianco (50%)
Chardonnay (50%), Pinot Bianco (50%) Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, mela e susina seguite da aromi di acacia, pera, pompelmo, burro,
mango, bergamotto, vaniglia, biancospino, miele e minerale.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, mela e susina seguite da aromi di acacia, pera, pompelmo, burro,
mango, bergamotto, vaniglia, biancospino, miele e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e susina.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e susina. Fermentazione in barrique, circa 12 mesi di maturazione in barrique.
Fermentazione in barrique, circa 12 mesi di maturazione in barrique. Pesce arrosto, Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Carne bianca stufata
Pesce arrosto, Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Carne bianca stufata
 Merlot
Merlot Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, prugna e amarena seguite da aromi di mirtillo, violetta, peonia,
cioccolato, tabacco, vaniglia, cuoio, pepe rosa, macis ed eucalipto.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ribes, prugna e amarena seguite da aromi di mirtillo, violetta, peonia,
cioccolato, tabacco, vaniglia, cuoio, pepe rosa, macis ed eucalipto.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e
mirtillo.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e
mirtillo.
 18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati
Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati
 Pinot Nero
Pinot Nero Rosa ciliegia intenso e sfumature rosa ciliegia, moderata trasparenza,
perlage fine e persistente.
Rosa ciliegia intenso e sfumature rosa ciliegia, moderata trasparenza,
perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mela
e lampone seguite da aromi di mirtillo, susina, lievito, fragola e
ciclamino.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mela
e lampone seguite da aromi di mirtillo, susina, lievito, fragola e
ciclamino.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mela.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mela. Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per 24
mesi.
Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per 24
mesi.
 Pasta con carne, Pesce stufato, Carne saltata, Zuppe di funghi
Pasta con carne, Pesce stufato, Carne saltata, Zuppe di funghi
 Pinot Nero
Pinot Nero Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
crosta di pane seguite da aromi di lampone, lievito, ananas, biancospino,
pera e nocciola.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
crosta di pane seguite da aromi di lampone, lievito, ananas, biancospino,
pera e nocciola.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, ananas e susina.
Finale persistente con ricordi di mela, ananas e susina. Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per 24
mesi.
Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per 24
mesi.
 Pasta con pesce, Pesce stufato, Carne bianca arrosto, Crostacei alla griglia
Pasta con pesce, Pesce stufato, Carne bianca arrosto, Crostacei alla griglia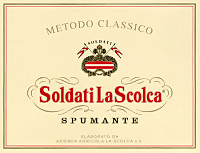
 Cortese
Cortese Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
crosta di pane seguite da aromi di pesca, mandorla, lievito, pera,
biancospino, ginestra e minerale.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e
crosta di pane seguite da aromi di pesca, mandorla, lievito, pera,
biancospino, ginestra e minerale.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca. Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per oltre
24 mesi.
Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui propri lieviti per oltre
24 mesi.
 Pasta con carne, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato, Zuppe di funghi
Pasta con carne, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato, Zuppe di funghi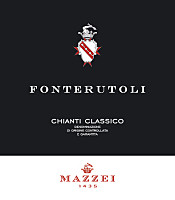
 Sangiovese (90%), Malvasia Nera, Colorino, Merlot (10%)
Sangiovese (90%), Malvasia Nera, Colorino, Merlot (10%) Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, vaniglia,
macis e carruba.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, vaniglia,
macis e carruba.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. 12 mesi in barrique e botte.
12 mesi in barrique e botte. Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
 Sangiovese (92%), Malvasia Nera, Colorino (8%)
Sangiovese (92%), Malvasia Nera, Colorino (8%) Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, mora, cacao,
tabacco, macis, cuoio, mentolo e vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, mora, cacao,
tabacco, macis, cuoio, mentolo e vaniglia.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. 20 mesi in barrique e botte.
20 mesi in barrique e botte. Carne arrosto, Carne alla brace, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Carne arrosto, Carne alla brace, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati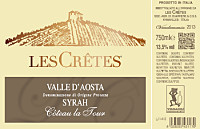
 Syrah
Syrah Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e mirtillo seguite da aromi di prugna, violetta, mora, lampone, pepe nero,
cioccolato e vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ribes, amarena
e mirtillo seguite da aromi di prugna, violetta, mora, lampone, pepe nero,
cioccolato e vaniglia.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e mirtillo. 12 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.
12 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia, Formaggi
Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia, Formaggi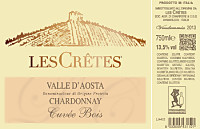
 Chardonnay
Chardonnay Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, acacia e susina seguite da aromi di mela, pera, burro, biancospino,
vaniglia, nocciola, pompelmo, pralina e minerale.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, acacia e susina seguite da aromi di mela, pera, burro, biancospino,
vaniglia, nocciola, pompelmo, pralina e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e susina.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e susina. Fermentazione in botte, 10 mesi di affinamento in botte, 8 mesi di
affinamento in bottiglia.
Fermentazione in botte, 10 mesi di affinamento in botte, 8 mesi di
affinamento in bottiglia.
 Pasta con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Formaggi
Pasta con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Formaggi
