|
La ricchezza di uve da vino coltivate in Italia non ha uguali in nessun altro
luogo del mondo. Da nord a sud, ogni regione ha le proprie varietà autoctone,
spesso presenti anche in altre regioni, talvolta perfino diffuse in larghe aree
del paese. A queste si aggiungono, infine, le varietà cosiddette
alloctone, cioè diffuse in molti paesi vitivinicoli del mondo e
generalmente di origine francese. Un patrimonio immenso capace di generare una
quantità innumerevole di vini, ognuno espressione della propria terra e degli
uomini che li producono. Considerando poi che i vini sono prodotti anche
dall'unione di uve diverse, le combinazioni diventano virtualmente infinite,
soprattutto se si prendono in considerazione i diversi territori, uomini e
pratiche enologiche. Per fare comprendere la vastità del patrimonio italiano,
il registro nazionale delle uve da vino riporta attualmente oltre cinquecento
varietà diverse.
Questo mese prendiamo in esame due varietà molto diverse fra loro, dal punto di
vista geografico perfino opposte. Il Grignolino, varietà a bacca rossa del
Piemonte, e il Gaglioppo, uva rossa regina della Calabria, si confrontano nei
nostri calici così da svelare le rispettive differenze. Uve molto diverse fra
loro, producono vini altrettanto diversi, con qualità organolettiche tali da
conferire a entrambe una spiccata personalità e riconoscibilità. Grazie alle
rispettive caratteristiche, assolutamente uniche e tali da collocarle - per
così dire - su fronti decisamente opposti, la nostra degustazione per contrasto
non presenterà particolari difficoltà. Anche le tecniche utilizzate nei due
vini sono spesso diverse, soprattutto per esigenze di integrità, cioè tese a
mantenere l'opportuna espressione delle personalità organolettiche delle due
uve. Il Grignolino è prevalentemente vinificato in contenitori inerti, il
Gaglioppo si avvale spesso della maturazione in botte, non mancando comunque
casi nei quali questo processo è svolto in vasche d'acciaio o cemento.
Il Grignolino è una varietà a bacca rossa prevalentemente diffusa nelle aree
dell'astigiano e del Monferrato in Piemonte. Questa varietà si rileva in
quantità piuttosto marginali anche nel territorio delle Langhe, mentre è
pressoché assente nelle altre aree del Piemonte e d'Italia. In passato il
Grignolino era piuttosto diffuso e la sua forte riduzione si deve alla comparsa
della fillossera, un destino che questa varietà condivide con molte alte
varietà. In conseguenza degli effetti del temibile afide, i viticoltori
preferirono coltivare - per ovvie ragioni e, non da ultimo, per necessità -
altre varietà più resistenti, sacrificando quindi il Grignolino. Testimonianze
rilevate in documenti antichi avvalorano la tesi dell'origine piemontese, più
in particolare nel territorio di Asti e del Monferrato. Si deve inoltre notare
che, da quello che si rileva in documenti del passato, la presenza del
Grignolino, seppure in termini marginali, era testimoniata anche nell'Oltrepo
Pavese e in Veneto.
Il nome dell'uva deriva probabilmente dalla voce dialettale astigiana
grignòle, termine con il quale si chiamano i vinaccioli dell'uva, i
quali si trovano in abbondanza nell'acino di questa varietà. Il Grignolino
entra nella produzione di tre vini a Denominazione d'Origine e Controllata del
Piemonte: Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese e Piemonte
Grignolino. I vini prodotti con quest'uva presentano sovente caratteristiche
olfattive che richiamano le spezie, oltre a frutti a bacca rossa e sensazioni
floreali. Il Grignolino è prevalentemente utilizzato in purezza e produce vini
piacevoli e diretti che esprimono il meglio del loro carattere in gioventù. In
termini generali, proprio per preservare le qualità specifiche dell'uva, il
Grignolino è vinificato e maturato in contenitori inerti, tuttavia sono noti
alcuni esempi di maturazione in botte. In quest'ultimo caso, il vino acquisisce
un carattere più complesso, accentuando i tipici caratteri speziati di questa
varietà, in particolare pepe e chiodo di garofano.
Ben diverse sono le caratteristiche del Gaglioppo, gloria enologica della
Calabria, terra dalla quale ha origine. Varietà considerata autoctona di questa
regione, il Gaglioppo è l'uva sulla quale si basano i vini rossi dell'area
vinicola di Cirò, certamente la più celebre della Calabria. Varietà dalla
notevole resistenza, ben si adatta alle severe condizioni della Calabria, in
particolare la siccità e il terreno tendenzialmente arido. Il Gaglioppo è una
varietà dalle origini molto antiche, i quali vini erano celebri e apprezzati
già al tempo della Magna Grecia. Si suppone che, in tempi antichi, il Gaglioppo
fosse diffuso in un territorio molto più esteso di quello attuale, lungo la
fascia adriatica e arrivando addirittura nelle terre dove oggi si trovano le
Marche. La diffusione attuale del Gaglioppo è praticamente limitata alla
Calabria, sua terra di origine, ed è l'uva rossa più celebre e diffusa della
regione, protagonista assoluta dei vini rossi di questa terra.
|
 | |
| Così si presenta il
Grignolino del Monferrato Casalese nel calice: si noti la trasparenza e il
colore rosso rubino | |
|
In Calabria il Gaglioppo è utilizzato per la produzione di vini sia rossi sia
rosati. Reso celebre dai vini della zona a Denominazione d'Origine Controllata
di Cirò, questa varietà entra comunque nella composizione di innumerevoli vini
rossi e rosati della regione. Il Gaglioppo si presta alla vinificazione sia in
contenitori inerti sia in quelli di legno, tecnica che consente, inoltre, di
mitigare l'irruenza della sua astringenza. I vini prodotti con questa varietà
presentano caratteristiche organolettiche molto interessanti, non solo
sensazioni riconducibili a frutti rossi e neri, ma anche fiori e qualità
speziate. I vini prodotti con Gaglioppo, dipendentemente dalla tecnica di
produzione, si fanno apprezzare sia in gioventù - periodo durante il quale si
percepisce maggiormente il suo carattere severo - sia dopo alcuni anni,
assumendo un profilo più austero. Il carattere speziato del Gaglioppo è
talvolta percettibile anche nei suoi vini rosati, in particolare l'aroma di
pepe nero.
Per la nostra degustazione prenderemo in esame un Grignolino del Monferrato
Casalese e un Cirò Rosso. Nello scegliere i nostri vini, è bene fare attenzione
ai rispettivi disciplinari di produzione. La DOC del Grignolino del Monferrato
Casalese prevede l'impiego dell'omonima uva per una quota minima del 90% e
nella restante parte Freisa. Si sceglierà pertanto un vino prodotto con
Grignolino in purezza. La stessa considerazione vale per il Cirò Rosso, nel
quale è previsto l'uso del Gaglioppo per una quota minima dell'80%. Pertanto -
anche in questo caso - si farà attenzione che il vino sia effettivamente
prodotto con Gaglioppo in purezza. Faremo inoltre attenzione anche al metodo
di produzione, scegliendo vini fermentati e maturati in contenitori inerti.
Infine, è preferibile che l'annata di produzione sia la stessa per entrambi i
vini, possibilmente non oltre i due anni di età. I vini sono degustati a una
temperatura di 18 °C e versati nei rispettivi calici da degustazione.
Come di consueto, iniziamo la degustazione per contrasto dall'esame
dell'aspetto dei due vini così da valutare il colore e la trasparenza. Versiamo
nel calice il Grignolino del Monferrato Casalese e incliniamolo sopra una
superficie bianca, come per esempio un foglio di carta. Osservando il vino alla
base del calice, si nota un colore rosso rubino brillante e una trasparenza
piuttosto elevata, tale da consentire la visione dell'oggetto posto dietro al
calice. L'osservazione della sfumatura, verso l'apertura del calice, rivela un
colore rosso rubino, talvolta tendente al granato, confermando il modesto
potere colorante del Grignolino. Passiamo ora all'oservazione del Cirò Rosso.
Alla base del calice si osserva un colore rosso rubino intenso, decisamente
meno trasparente del Grignolino. La sfumatura presenta lo stesso colore e,
in questo caso, il Gaglioppo conferma il suo buon potere colorante. Si
osservino ora i due calici così da mettere in evidenza le differenze nei due
vini.
I profili olfattivi di Grignolino e Gaglioppo sono piuttosto diversi fra loro,
trovando - come punto di unione - una certa nota speziata che può richiamare il
pepe nero e bianco. Per il resto, nei vini prodotti con queste due uve si
possono rilevare altri elementi olfattivi comuni, tuttavia con profili
complessivi molto diversi. Nel Grignolino si percepiranno infatti aromi di
frutti a bacca rossa e fiori, mentre nel Gaglioppo saranno i frutti neri a
essere maggiormente percepiti, unitamente a sensazioni riconducibili a fiori.
Il potenziale di evoluzione del tempo è diverso nelle due varietà. Il
Grignolino è generalmente considerato una varietà che produce vini non molto
longevi. In realtà, anche il Grignolino - dipendentemente da come si coltiva e
trasforma in vino - può produrre vini di discreta longevità e mostrare perfino
uno sviluppo olfattivo decisamente interessante. Il Gaglioppo ha certamente un
potenziale di maturazione nel tempo più significativa rispetto al Grignolino,
sviluppando sensazioni organolettiche di buona complessità.
Procediamo con la valutazione degli aromi di apertura del Grignolino del
Monferrato Casalese. Manteniamo il calice in posizione verticale e senza
rotearlo, quindi eseguiamo la prima olfazione. L'apertura del Grignolino è
caratterizzata da profumi che ricordano i frutti rossi, in particolare
ciliegia, lampone e prugna ai quali si aggiunge la fragola. Si noterà anche la
tipica nota di pepe nero, spesso presente nei vini prodotti con Grignolino.
Dopo avere roteato il calice, il vino completa il suo profilo olfattivo con
mirtillo e sensazioni floreali di geranio, ciclamino e rosa. Ben diverso il
profilo olfattivo del Gaglioppo. L'apertura del Cirò Rosso si compone infatti
di prugna, amarena e mirtillo. Dopo avere roteato il calice, la sequenza degli
aromi si completa con sensazioni di mora e fragola, oltre a percezioni floreali
di ciclamino e rosa. Si percepirà, anche in questo caso, il profumo speziato
del pepe nero, caratteristica tipica del Gaglioppo.
Le differenze fra Grignolino e Gaglioppo diventano ancor più evidenti nella
fase dell'analisi gustativa. L'attacco del Grignolino del Monferrato Casalese
si fa apprezzare per una piacevole freschezza alla quale si unisce una moderata
astringenza. Queste due sensazioni organolettiche trovano equilibrio grazie al
contributo dell'alcol, nonostante il suo effetto bruciante non risulti
eccessivamente intenso. In bocca si percepiscono sapori di ciliegia, lampone e
fragola, già percepiti al naso. L'attacco del Cirò Rosso, prodotto con
Gaglioppo, si caratterizza per una struttura più robusta rispetto al
Grignolino. Si percepisce inoltre una maggiore morbidezza, ulteriormente
accentuata dall'alcol, e una freschezza decisamente inferiore. La sensazione di
astringenza del Gaglioppo è evidentemente più intensa rispetto al Grignolino,
pur conservando una notevole piacevolezza. In bocca si percepiscono i sapori di
prugna, amarena, mirtillo e fragola, confermando la buona corrispondenza con il
naso.
Le differenze fra i due vini si percepiscono anche nella fase finale della
degustazione, quella che si esegue dopo avere deglutito il vino. Il finale del
Grignolino del Monferrato Casalese è generalmente di buona persistenza,
lasciando in bocca i sapori delle percezioni principali: ciliegia, lampone e
fragola. Dopo la deglutizione, la sensazione di freschezza del Grignolino
continua a essere percepita in bocca, molto piacevole e che invita certamente
a un nuovo assaggio. Il finale del Cirò Rosso è di buona persistenza, lasciando
in bocca le sensazioni già percepite durante l'assaggio e nel quale si
riconoscono prugna, amarena e lampone. La sensazione finale è decisamente più
robusta rispetto al Grignolino, più rotonda e calda, non meno piacevole e
che invita comunque a un nuovo assaggio. Due uve diverse, non solo per la
distanza delle rispettive terre di origine, capaci di offrire due
interpretazioni enologiche distinte e comunque riconoscibili per la loro
personalità.
|


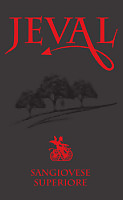
 Sangiovese
Sangiovese Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo, ciclamino e
cannella.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo, ciclamino e
cannella.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. 8 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
8 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia. Carne alla griglia, Paste ripiene con carne, Carne bianca arrosto, Formaggi
Carne alla griglia, Paste ripiene con carne, Carne bianca arrosto, Formaggi
 Sangiovese
Sangiovese Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
tabacco, macis, vaniglia, cannella, cuoio e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, cioccolato,
tabacco, macis, vaniglia, cannella, cuoio e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. 24 mesi in barrique e botte, 12 mesi in bottiglia.
24 mesi in barrique e botte, 12 mesi in bottiglia. Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Grechetto
Grechetto Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, nocciola
e susina seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino, ginestra, ananas e
vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, nocciola
e susina seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino, ginestra, ananas e
vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e nocciola. 12 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia.
12 mesi in botte, 4 mesi in bottiglia. Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto
Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto
 Sagrantino
Sagrantino Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao,
vaniglia, cannella, macis, liquirizia e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao,
vaniglia, cannella, macis, liquirizia e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mora, amarena e mirtillo.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e mirtillo. 18 mesi in barrique e botte, 6 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique e botte, 6 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
 Pinot Nero (85%), Chardonnay (15%)
Pinot Nero (85%), Chardonnay (15%) Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage
fine e persistente.
Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage
fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
lampone e crosta di pane seguite da aromi di mela, mandarino, fragola,
ciclamino, lievito, nocciola e susina.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia,
lampone e crosta di pane seguite da aromi di mela, mandarino, fragola,
ciclamino, lievito, nocciola e susina.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina. Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti per almeno 30 mesi.
Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti per almeno 30 mesi. Paste ripiene con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di funghi
Paste ripiene con carne, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di funghi
 Chardonnay (55%), Pinot Nero (45%)
Chardonnay (55%), Pinot Nero (45%) Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
crosta di pane, susina e banana matura seguite da aromi di pralina, miele,
mela, lievito, agrumi, biancospino, brioche, lampone, burro e vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
crosta di pane, susina e banana matura seguite da aromi di pralina, miele,
mela, lievito, agrumi, biancospino, brioche, lampone, burro e vaniglia.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di susina, mela e pralina.
Finale persistente con ricordi di susina, mela e pralina. Il vino base è maturato in botte. Rifermentazione in bottiglia sui
propri lieviti per almeno 60 mesi.
Il vino base è maturato in botte. Rifermentazione in bottiglia sui
propri lieviti per almeno 60 mesi.
 Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Paste ripiene, Stufati di carne
Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Paste ripiene, Stufati di carne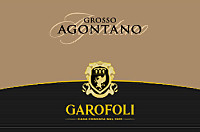
 Montepulciano
Montepulciano Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, impenetrabile alla luce.
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, impenetrabile alla luce. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, mora e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, ribes,
vaniglia, cipria, tabacco, cuoio, liquirizia, cioccolato, macis e mentolo.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, mora e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, ribes,
vaniglia, cipria, tabacco, cuoio, liquirizia, cioccolato, macis e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, mora e prugna.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, mora e prugna. 18 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.
18 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia. Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati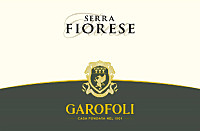
 Verdicchio
Verdicchio Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e mandorla seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino,
ananas, ginestra, anice, miele, pesca matura, minerale e vaniglia.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e mandorla seguite da aromi di pera, agrumi, biancospino,
ananas, ginestra, anice, miele, pesca matura, minerale e vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina, pera e
mandorla.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina, pera e
mandorla.
 Fermentazione in barrique, 12 mesi di maturazione in barrique, almeno 2
anni in bottiglia.
Fermentazione in barrique, 12 mesi di maturazione in barrique, almeno 2
anni in bottiglia.
 Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato
Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato
