
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 118, Maggio 2013 |
Sommario |
|
|
Riusciremo a Riparlare di Vino? |
|
Lo so, torno spesso su questo argomento. Il fatto è che guardo il mondo del vino, dell'informazione del vino - più o meno competente, più o meno becera al limite del volgare e dell'ingiuria - e non posso che restare perplesso di fronte ad accuse, spesso infondate e delle quali non si ha nessuna consapevolezza in materia, dette solo con lo scopo di “dire qualcosa tanto per recriminare la propria discutibile presenza”. Che noia! Uno spettacolo patetico, triste e inutile, dove si fa un gran parlare di tutto - alla fine di niente - di tutto tranne che di vino. Eppure sono tutti fermamente convinti di parlare di vino, forse confondendo la propria vanità, la presunta competenza, le religioni, la voglia di emergere dal nulla facendosi scudo di una posizione integralista - pertanto sciocca e cieca - urlando parole dette perché vanno dette con la vacua speranza di sentirsi “importanti”. Tutti convinti di emettere la sentenza definitiva e confidando che tutti siano pronti a berla come verità rivelata. Si fa un gran parlare di correnti di pensiero, di religioni enologiche, di disciplinari, di chi lo sa fare meglio - il vino, ovviamente - di chi ha avuto il dono dell'onniscienza enologica, chi è stato folgorato sulla via di Bacco, chi è pronto a giurare che il proprio vino è il migliore in assoluto, mentre quello degli altri è, nella migliore delle ipotesi, il male assoluto da combattere. Mi sforzo, cerco davvero di farlo, forte solamente delle mie possibilità - certamente ricche di limiti e ignoranza - ma proprio non ci riesco, non riesco a capire questo tanto rumore per nulla. Tutti che si affannano a mettere davanti al proprio vino - sia i produttori, sia gli sciocchi megafoni di turno - parole, supposizioni, congetture, presunte superiorità, tra l'altro, mai avvalorate da ragioni oggettivamente provabili, prima ancora di parlare dei propri vini, come se dovessero giustificare o nascondere qualcosa. Tutto questo mi fa venire in mente la saggezza di tempi passati, segno che, in fin dei conti, questi atteggiamenti hanno sempre fatto parte delle diatribe di ogni tempo: excusatio non petita, accusatio manifesta. La locuzione, è traducibile come scusa non richiesta, accusa manifesta, o più correntemente come se non si ha nulla per cui giustificarsi, non serve scusarsi. Certi produttori di vino, certi sostenitori strenui di una posizione - di qualunque corrente e di qualunque credo - mi sembrano spesso i bambini che, sorpresi con le mani nel vasetto della marmellata, dicono, con una certa “faccia tosta”, di non essere colpevoli. Per quale ragione, al momento di assaggiare un vino in presenza di un produttore, questo debba continuamente sostenere che si tratta di un vino fatto in un certo modo, che risponde a certi requisiti produttivi, appartenente a specifiche religioni enologiche, e come tali devono classificare il vino in un certo modo, prima ancora di metterlo nel calice e permettermi di assaggiarlo, negandomi il diritto di farmi un'idea, la mia idea maturata dall'ascolto di quel vino? L'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo: non riconosco nessuna importanza o garanzia alle denominazioni - mentre riconosco importanza assoluta al territorio - ai certificati, alle religioni, alle posizioni ideologiche integraliste, alle mode “che vanno e vengono”, soprattutto quando sono ostentate in modo violento e volgare, con lo scopo di “nascondere altro”. È un insulto sia alla mia intelligenza sia alla mia capacità di degustatore di vino, qualità che riconosco, entrambe e senza paura, limitate in modo desolante. Non mi interessa - in alcun modo - che un vino sia naturale, biologico, biodinamico, convenzionale, tecnologico o di qualunque altra categoria, e tutto il gran parlare che si fa di questo “nulla”, solo per imporre la propria mediocrità sugli altri, mi rende tutto opaco e inutile. Tristemente inutile. Riusciremo mai a capire che la qualità non si impone per legge - fatta la legge, trovato l'inganno - e che la moralità e l'onestà sono qualità che non si impongono ma che sono intimamente parte delle persone e della loro etica? Un produttore onesto non ha bisogno di leggi o dogmi, e non li impone nemmeno agli altri a protezione di quello che fa: lascia unicamente al vino il compito di raccontare sé stesso e quello che fa. Atteggiamenti e schieramenti di parte che si traducono innegabilmente in nuove mode, spesso riesumate dal passato, quando - ai loro tempi - erano state apertamente osteggiate e rifiutate. Mode che ottengono un clamoroso successo e finiscono - spesso - per distogliere l'attenzione dal vino alimentando dibattiti e raccogliendo agguerriti proseliti. Posizioni che diventano ipocrite e assolutamente tristi, fino a sostenere a spada tratta un vino appartenente alla categoria “del cuore” anche quando è evidentemente di pessima qualità, ma che diviene capolavoro assoluto solo per il fatto di essere figlio della “verità rivelata” di turno. Non tollero, infatti, che si metta davanti alla qualità del vino la categoria di appartenenza e la tecnica di produzione - qualunque essa sia, senza distinzione alcuna - come se fosse un pregio o, peggio, la giustificazione a certi palesi difetti o eccessi. Allo stesso modo, riportare in auge stili di vino, di discutibile esecuzione enologica e in passato definiti di bassa qualità in modo pressoché unanime, vestendoli di nuovi nomi romantici all'insegna del “puro” e del “tradizionale”, del “salutare” e “sano”. Ed è perfino troppo ovvio che a chiunque interessi un vino salutare e una viticoltura rispettosa dell'ambiente ed ecosostenibile, senza eccezione da parte di alcuno, me compreso e in modo indiscutibile. Tutto questo mi fa davvero sorridere se ripenso a mio nonno, che ha sempre fatto vino bianco facendo fermentare il mosto insieme alle bucce - tutte le bucce - mantenendole dentro la botte fino alla svinatura. Il suo vino aveva un colore dorato intenso e un corpo piuttosto robusto per essere un vino bianco. Tutto quello che usava in vigna era zolfo e “verderame” - cioè cristalli di solfato di rame disciolti in acqua - e in cantina solo pastiglie di zolfo da bruciare nei contenitori vinari e travasi. Oggi, un vino bianco simile, prodotto da lunga macerazione con le bucce, sarebbe equiparato ai cosiddetti orange wine, e - per i prodotti usati - di diritto incluso nella categoria dei naturali, precisando che il vino di mio nonno non è mai stato né ossidato né torbido. Anzi, un vino torbido o ossidato lo indisponeva alquanto, definendo il produttore come incapace, oltre a usare “coloriti” aggettivi dialettali che, per limiti linguistici, non renderebbero giustizia al significato esatto qualora fossero tradotti in Italiano. Purtroppo, il tempo e il naturale corso della vita, non mi permette di chiedere a mio nonno la sua opinione sul fatto che il suo vino era in realtà un naturale orange wine. Chissà cosa penserebbe di una definizione come questa, lui che ha sempre chiamato il frutto della sua vigna semplicemente “vino”. Antonello Biancalana
|
||||
La Degustazione fra Gusto e OmologazioneOgni epoca e ogni tempo ha avuto i propri riferimenti di qualità enologica, un percorso evolutivo ed enologico che ha subito profondi cambiamenti |
|
Il gusto per il cibo e per le bevande, allo stesso modo, per le arti, la cultura e qualunque espressione legata agli intimi sentimenti dell'uomo, subisce continui adattamenti con il tempo e si sviluppa in accordo ai contesti sociali e culturali di ogni luogo del mondo. Il vino non si è mai sottratto a questa regola e, nel corso della sua millenaria storia, si è trasformato in accordo allo sviluppo culturale del gusto. Applicato al vino, gusto e tecnologia enologica si sono supportati a vicenda. Senza entrare nel merito delle questioni legate alla forma d'uso della tecnologia nella produzione del vino, è innegabile che questa ha portato, per molti aspetti, al miglioramento del prodotto finale, condizionando - per certi aspetti - l'evoluzione del gusto. Allo stesso modo, le pratiche tradizionali e la loro forma d'uso, hanno condizionato lo sviluppo del gusto, anche a livello intellettuale e sentimentale. Non è comunque opportuno definire quale sia il “vero” gusto del vino e quale pratica enologica sia migliore per produrre vino: in entrambi i casi sarebbe semplicemente una dimostrazione di arroganza intellettuale: in tutti i casi valga l'antico detto de gustibus non est disputandum. Se è certamente accettabile, e auspicabile, l'esistenza di gusti diversi, idee e opinioni diverse, è del tutto inaccettabile quando questi sono imposti agli altri definendoli come assoluti, migliori e indiscutibili. Ricordando che la differenza è sempre una grande ricchezza e un'infinita risorsa per tutti, è comunque innegabile che, nei gusti così come nelle opinioni, esista una certa “condivisione”, determinata su base puramente statistica in funzione di una maggioranza espressa, e che tende a definire il modello di riferimento. Questi modelli di riferimento sono fortemente determinati dai contesti culturali, storici, sociali, tradizionali e psicologici nei quali sono definiti e definibili. Allo stesso modo, anche il concetto di qualità enologica è condizionato dai medesimi fattori, oltre che da ragioni di tipo etico e morale. In questo senso, è proprio l'etica e la moralità del produttore a stabilire il confine fra la qualità e il compromesso produttivo e viticolturale. Ogni tecnica di produzione e di coltivazione hanno la capacità di determinare il profilo organolettico di un vino, sia in termini positivi sia in quelli negativi. L'adozione di qualsiasi tecnica è condizionata dall'orientamento morale ed etico di ogni singolo produttore, oltre - ovviamente - dalla personale opinione o pregiudizio sulla tecnica stessa. Lo stesso orientamento, nella definizione della qualità e del gusto, è quindi adottato dai consumatori, ognuno dei quali ha riferimenti e preferenze proprie.
Il riferimento del gusto e della qualità enologica sono pertanto fortemente condizionati da questo tipo di scelte, pregiudizi e orientamenti. A titolo di esempio, l'impiego di lieviti selezionati - che hanno il potere di orientare in modo determinante il profilo organolettico di un vino, esattamente come i cosiddetti lieviti indigeni - può essere elemento pregiudiziale nella determinazione qualitativa di un vino. I degustatori e i consumatori apertamente contrari all'impiego dei lieviti selezionati tenderanno a penalizzare, o a non preferire, quei vini prodotti con questa tecnica, mentre saranno più disponibili a definire di maggiore qualità quei vini nei quali non sono stati impiegati. Allo stesso modo, vini prodotti dalla fermentazione svolta da lieviti indigeni, potrebbero essere penalizzati e non preferiti da chi invece gradisce i tipici profumi dei lieviti selezionati. A titolo di chiarezza e completezza, va ricordato che qualunque lievito - selezionato o indigeno che sia - ha in ogni caso il potere di orientare il profilo organolettico di un vino. Non è un caso se i cosiddetti “aromi secondari” di un vino sono anche definiti “aromi di fermentazione”, proprio a sottolineare il ruolo fondamentale dei lieviti, di qualunque tipo, nella formazione del profilo olfattivo di un vino. Inoltre, si dice anche che gli aromi primari dell'uva sono rivelati dalla fermentazione, cioè dai lieviti, che, inevitabilmente, aggiungeranno agli aromi dell'uva anche i propri aromi. Infine, è sempre bene ricordare che la selezione dei lieviti, e quindi il controllo delle qualità organolettiche di un vino al termine della fermentazione, può essere efficacemente svolto attraverso la temperatura. Questo concetto è valido sia per i lieviti selezionati sia per quelli indigeni, i quali, attraverso il controllo della temperatura, così come l'impiego di anidride solforosa, subiscono notevoli alterazioni biologiche, inibendo o favorendo l'attività di particolari specie. La degustazione sensoriale di un vino, nonostante debba essere svolta in modo oggettivo e secondo dei criteri qualitativi di riferimento, è innegabile che sia spesso condizionata da gusti e predisposizioni personali e soggettive. Questa condizione, ovviamente non trascurabile, è comunque capace di orientare la definizione sia della qualità del vino, sia del gusto. Fattori che non sono unicamente dettati da ragioni pregiudiziali nei confronti di stili o tecniche enologiche specifiche, ma anche dall'influenza di mode o riferimenti qualitativi imposti. A titolo di esempio, che può essere adattato a ogni singolo fattore produttivo o stilistico, si ricordi la moda della barrique e di come ogni vino fermentato o maturato nella piccola botte bordolese, incontrasse facilmente il consenso e l'approvazione di critica e consumatori. In poco meno di venti anni, l'atteggiamento nei confronti della barrique è radicalmente cambiato, tanto da essere perfino osteggiata così come i vini che sono prodotti con questo strumento enologico, anche quando usata con criterio e senza abusarne. I riferimenti della degustazione sensoriale, e con questi, anche la tecnica, sono cambiati nel corso della storia del vino. Con il cambiare delle mode e dei gusti, sono cambiati anche i riferimenti e le modalità di esecuzione della degustazione del vino. In questo senso, un grande aiuto è giunto dalle ricerche svolte a partire dal 1900 e che hanno consentito una migliore comprensione di cosa fosse il vino anche a livello chimico e biologico. La ricerca ha infatti consentito di definire in modo più rigoroso le pratiche della degustazione sensoriale, facendola uscire, per certi aspetti, dalle modalità spesso empiriche - basate su semplici, ma comunque importanti, osservazioni - fino a comprendere l'interazione fra i singoli stimoli gustativi e tattili sulla fisiologia del gusto. Con questo non si vuole affermare che in passato non fossero capaci di degustare il vino, ma è innegabile che il risultato di ricerche e studi ha consentito di migliorare sia la tecnica sia la comprensione. Un processo che ha interessato qualunque fenomeno inerente la conoscenza e la percezione del mondo nel quale viviamo: basti pensare, per esempio, che prima delle straordinarie intuizioni di Galileo Galilei, il mondo era considerato il centro di un sistema nel quale era il sole a girargli intorno. Allo stesso modo, oggi sappiamo che, per esempio, l'effervescenza dei vini frizzanti e spumanti - un tempo definiti bruschi - è prodotta dall'anidride carbonica, così come sappiamo che l'alcol etilico è prodotto dai lieviti attraverso la conversione degli zuccheri. La migliore conoscenza dei fenomeni che consentono la produzione del vino e della sua evoluzione nel tempo, è stata quindi fondamentale per la comprensione della degustazione sensoriale e organolettica. Questo ha portato anche al reciproco condizionamento delle due discipline: spesso la produzione del vino è svolta in funzione dei criteri della degustazione sensoriale così da soddisfare determinati parametri. Il medesimo influsso è esercitato, forse in modo ancor più sostanziale, dalle mode e dalle tendenze dei consumatori; non solo per soddisfare semplici esigenze di mercato, quindi assicurarsi un maggiore profitto, ma anche per conformarsi a determinati stili enologici. Se osserviamo gli ultimi venti anni di produzioni enologiche, più in particolare, i riferimenti di qualità stabiliti sia dalla critica sia dai consumatori, questi ultimi spesso condizionati dalla critica stessa, hanno condizionato fortemente la produzione di vino. Mode che vanno e vengono, spesso si ripetono ciclicamente a distanza di anni, stabiliscono inevitabilmente criteri di riferimento che alterano anche la valutazione sensoriale di un vino. Va detto, infatti, che sarebbe inopportuno stabilire un riferimento assoluto di qualità enologica, proprio per il fatto che questo si esprime, essenzialmente, attraverso la percezione dei sensi, pertanto, in continua evoluzione e determinata da fattori soggettivi e culturali di ogni tempo. La storia del vino è la testimonianza di quanto le mode e le tendenze di ogni tempo siano destinate a nascere, crescere e, infine, scomparire, per poi tornare a nuova vita, perfino rinnegando il loro declino. Abbiamo infatti visto l'era dei vini bianchi, seguita da quella dei vini rossi, il ritorno dei bianchi e poi dei rossi, in un inseguimento pressoché infinito che non vede segni di cedimento. Allo stesso modo, se oggi i vini cosiddetti naturali vivono un innegabile momento di notorietà - ricordando che fino a qualche anno fa erano considerati in ben altro modo - saranno inevitabilmente destinati a minore consenso non appena farà il suo ingresso una nuova moda. Va anche detto che le mode - tutte le mode, quelle del vino compreso - nascono, vivono, si trasformano e si avviano al loro inevitabile declino, nell'ambito di determinati contesti sociali e culturali, definendo rigidi criteri di valutazione sensoriale, fortemente condizionati dai fattori ritenuti assoluti ma non sempre accettati da altri come tali. Il rischio concreto che si corre in questi casi è la definizione dell'omologazione del gusto, fenomeno che si verifica non solo per il vino, poiché tutti gli stili e le tecniche di produzione - senza distinzione alcuna - tendono a conferire al vino qualità organolettiche identificative e riconoscibili. I vini tecnologici sono chiaramente riconoscibili già nelle prime fasi di degustazione, così come lo sono i vini appartenenti a stili di produzione più artigianali. Infatti, è sufficiente una rapida osservazione del calice, così come una rapida valutazione olfattiva degli aromi, per comprendere - seppure in modo sommario - lo stile produttivo di ogni vino. La preferenza per un determinato stile di vino, atteggiamento e scelta del tutto lecita, ovviamente, costituisce un serio rischio per il degustatore, poiché tenderà a definire migliori certi vini, ritenuti preferiti, escludendo gli altri in modo del tutto pregiudiziale, anche quando prodotti in modo qualitativamente accettabile. L'omologazione rappresenta infatti per il degustatore uno dei maggiori pericoli per l'attendibilità del proprio lavoro. Riconoscendo alle mode e alle tendenze di ogni momento un ruolo determinante per la formazione del gusto di riferimento in ogni ambito sociale e culturale, questo non dovrebbe - in ogni caso - influire sulla valutazione di un vino quando svolto con finalità che vanno oltre il semplice consumo. Considerazioni che, evidentemente, non trovano riscontro nella valutazione dei consumatori che, legittimamente, determinano la qualità e la piacevolezza di un vino secondo il proprio gusto senza considerare fattori di tipo tecnico. In definitiva, questo non significa che la valutazione del consumatore non sia attendibile o significativa: al contrario, contribuisce alla definizione del modello enologico che meglio riflette il gusto di ogni tempo e pertanto deve essere valutato con attenzione.
|
||||||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |
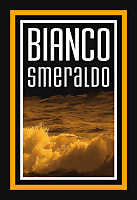
|
|
Vermentino di Gallura Bianco Smeraldo 2010 |
|
| Un Mare Di Vino (Sardegna, Italia) | |
| Uvaggio: Vermentino | |
| Prezzo: € 14,50 | Punteggio: |
| Vermentino di Gallura Bianco Smeraldo si presenta con un colore giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di pera, mela e pesca seguite da aromi di susina, biancospino, ananas, ginestra, limone e mandorla. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di pera, pesca e mandorla. Vermentino di Gallura Bianco Smeraldo matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Pesce fritto, Risotto e pasta con crostacei e pesce, Pesce saltato, Latticini | |

|
|
Oltremare 2010 |
|
| Un Mare Di Vino (Sardegna, Italia) | |
| Uvaggio: Carignano, Merlot, Cabernet Franc | |
| Prezzo: € 26,00 | Punteggio: |
| Oltremare si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di mirtillo, ribes, violetta, vaniglia, tabacco, cioccolato, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, mora e prugna. Oltremare matura per 18 mesi in botte. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Carne alla griglia, Formaggi stagionati | |

|
|
Jazz 2009 |
|
| Ferlaino (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese (37%), Merlot (32%), Cabernet Franc (26%), Petit Verdot (5%) | |
| Prezzo: € 25,50 | Punteggio: |
| Jazz si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e ribes seguite da aromi di violetta, mirtillo, vaniglia, cioccolato, macis, peperone ed eucalipto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes. Jazz matura per 18 mesi in barrique, 8 mesi in vasche d'acciaio e per almeno 8 mesi in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati | |

|
|
Tango 2009 |
|
| Ferlaino (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Merlot (58%), Cabernet Franc (25%), Petit Verdot (17%) | |
| Prezzo: € 30,00 | Punteggio: |
| Tango si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di mirtillo, violetta, vaniglia, peperone, peonia, cioccolato ed eucalipto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. Tango matura per 18 mesi in barrique a cui seguono 8 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati | |
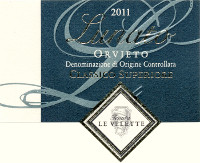
|
|
Orvieto Classico Superiore Lunato 2011 |
|
| Le Velette (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Grechetto (40%), Procanico (20%), Malvasia Bianco (20%), Verdello (15%), Drupeggio (5%) | |
| Prezzo: € 6,60 | Punteggio: |
| Orvieto Classico Superiore Lunato si presenta con un colore giallo dorato chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di pera, ginestra, miele, mandorla, agrumi e minerale. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di susina, mela e miele. Orvieto Classico Superiore Lunato matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Pesce stufato | |
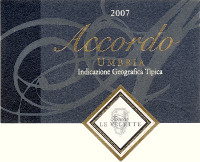
|
|
Accordo 2007 |
|
| Le Velette (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese | |
| Prezzo: € 8,70 | Punteggio: |
| Accordo si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di prugna, amarena e violetta a cui seguono aromi di mirtillo, vaniglia, cioccolato, tabacco, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Accordo matura per 12 mesi in barrique a cui seguono 12 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Tutti Santi 2010 |
|
| Villa Acquaviva (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca, Verdello | |
| Prezzo: € 12,00 | Punteggio: |
| Tutti Santi si presenta con un colore giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela cotogna, susina e mandorla seguite da aromi di confettura di pesche, biancospino, miele, scorza d'agrume, uva passa, vaniglia e smalto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e morbido, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza. Il finale è persistente con ricordi di mela cotogna, mandorla e uva passa. Tutti Santi è prodotto con uve da vendemmia tardiva, matura per 12 mesi in barrique a cui seguono 24 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne bianca arrosto, Formaggi, Pesce arrosto | |

|
|
Morellino di Scansano Riserva Bracaleta 2006 |
|
| Villa Acquaviva (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese (85%), Alicante, Malvasia Nera (15%) | |
| Prezzo: € 16,00 | Punteggio: |
| Morellino di Scansano Riserva Bracaleta si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, prugna e viola appassita a cui seguono aromi di lampone, mirtillo, rosa appassita, vaniglia, tabacco, cacao e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, lampone e prugna. Morellino di Scansano Riserva Bracaleta matura in botte. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi | |
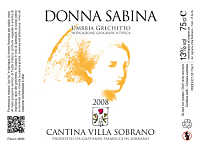
|
|
Donna Sabina 2008 |
|
| Villa Sobrano (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Grechetto | |
| Prezzo: € 12,50 | Punteggio: |
| Donna Sabina si presenta con un colore giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, susina e nocciola seguite da aromi di pera, pesca natura, nespola, ginestra, biancospino, miele e accenni di vaniglia. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di mela, susina e nocciola. Donna Sabina matura per 12 mesi in botte a cui seguono 12 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di pesce | |
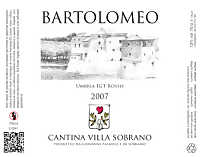
|
|
Bartolomeo 2007 |
|
| Villa Sobrano (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese (50%), Merlot (50%) | |
| Prezzo: € 13,50 | Punteggio: |
| Bartolomeo si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, vaniglia, tabacco, fagiolino, cioccolato, macis ed eucalipto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes. Bartolomeo matura in barrique per 14 mesi a cui seguono 24 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati | |
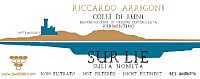
|
|
Colli di Luni Vermentino Sur Lie 2011 |
|
| Arrigoni (Liguria, Italia) | |
| Uvaggio: Vermentino | |
| Prezzo: € 16,00 | Punteggio: |
| Colli di Luni Vermentino Sur Lie si presenta con un colore giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, susina e miele seguite da aromi di biancospino, agrumi, ginestra, mandorla, pera e pesca matura. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco con un accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, lieve effervescenza. Il finale è persistente con ricordi di mela, susina e pera. Colli di Luni Vermentino Sur Lie matura in vasche di cemento. | |
| Abbinamento: Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Paste ripiene | |

|
|
Cinqueterre Tramonti 2011 |
|
| Arrigoni (Liguria, Italia) | |
| Uvaggio: Bosco (60%), Albarola, Vermentino (40%) | |
| Prezzo: € 16,00 | Punteggio: |
| Cinqueterre Tramonti si presenta con un colore giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di agrumi, ginestra, mandorla, pera, finocchio, minerale e un accenno di iodio. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di mela, susina e pera. Cinqueterre Tramonti fermenta e matura in barrique per 4 mesi. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Stufati di pesce | |
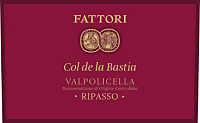
|
|
Valpolicella Ripasso Col de la Bastia 2010 |
|
| Fattori (Veneto, Italia) | |
| Uvaggio: Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%) | |
| Prezzo: € 28,00 | Punteggio: |
| Valpolicella Ripasso Col de la Bastia si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, vaniglia, tabacco, cioccolato, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, mora e prugna. Valpolicella Ripasso Col de la Bastia matura in botte. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia | |
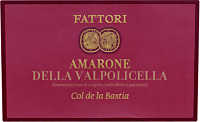
|
|
Amarone della Valpolicella Col de la Bastia 2010 |
|
| Fattori (Veneto, Italia) | |
| Uvaggio: Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%) | |
| Prezzo: € 35,00 | Punteggio: |
| Amarone della Valpolicella Col de la Bastia si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, vaniglia, tabacco, macis, cioccolato e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. Amarone della Valpolicella Col de la Bastia matura in botte per circa 24 mesi. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati | |
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
Albeisa Compie 40 Anni |
||||
Diventato un vero e proprio simbolo del territorio, con oltre 13 milioni di pezzi prodotti ogni anno, i produttori di Langa hanno deciso di festeggiarne il “compleanno” in modo originale. Il protagonista assoluto rimane lei: la bottiglia Albeisa. Grazie alla creatività di un giovane e stimato artista locale, Valerio Berruti, una serie limitata di sole 350 bottiglie Albeisa sarà valorizzata da un rilievo metallico rappresentante il profilo della bambina che rende inconfondibili le opere dell'artista. Proprio i più piccoli sono il leitmotiv del lavoro di Berruti, elemento che si ritrova in disegni, sculture, dipinti su grandi tele di iuta e bassorilievi in cemento armato. Sono, infatti, queste creature magiche, senza tempo, che trasmettono la serenità innocente e la saggia disponibilità di chi va imparando la fatica di stare al mondo l'ispirazione creativa di Valerio Berruti. Le bottiglie dell'anniversario saranno realizzate in due varianti: 270 saranno in acciaio inox (una per ogni socio Albeisa più alcuni esemplari istituzionali e da esposizione) e 80 esemplari in acciaio inox laccati oro. La versione “oro”, divisa in due gruppi, sarà omaggiata ai 40 locali italiani (ristoranti o enoteche) che più hanno sostenuto i produttori con bottiglia Albeisa e ulteriori 40 esemplari andranno ai locali internazionali che hanno nutrito la medesima passione. Saranno proprio i produttori-soci dell'associazione che indicheranno i loro più fidati clienti che comporranno la classifica dei migliori “ambasciatori Albeisa” nel Mondo. «Elevare la bottiglia stessa a oggetto d'arte, di valore, di eleganza, rende ancor più importante e prestigioso il ruolo che l'Albeisa ricopre per il nostro territorio - afferma Alberto Cordero di Montezemolo, presidente dell'associazione - Infatti essa rappresenta un'identità territoriale che poche zone possono vantare; e avere scelto un artista delle nostre colline, giovane, emergente e apprezzato dalle più autorevoli istituzioni artistiche del Mondo, non è stato casuale: la Langa ha forte tradizione su molti aspetti e da sempre ha dimostrato di avere l'azzardo di sperimentare, di esser creativa di imporre la propria piemontesità e filosofia produttiva e di vita. I giovani sono consci di questo, lo rispettano e puntano a valorizzarlo sempre più. Questa versione celebrativa avrà lo scopo di rafforzare lo spirito di appartenenza fra i soci, divenuti sempre più numerosi, ma anche di fare conoscere sempre più il nostro progetto nel mondo. Sarà consegnata ai migliori locali dei cinque continenti e questo permetterà, da New York a Tokyo, di portare un po' del nostro messaggio, della nostra storia, del nostro orgoglio agli occhi di tutti». |
||||
Conegliano-Valdobbiadene: Stop ai Prodotti Tossici |
| Prodotti di fascia rossa, ovvero a maggiore tossicità, quasi interamente
banditi passando da 19 ammessi a 4, eliminazione di quelli a base di Mancozeb
e sostituzione con prodotti di fascia verde, ovvero appartenenti alle categorie
non classificati (NC) o Xi. Sono alcune delle principali novità del Protocollo
Viticolo 2013, presentato dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco durante la conferenza stampa che si è tenuta il 16 aprile alla Camera
di Commercio di Treviso e che ha visto la partecipazione delle associazioni di
categoria Unindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Cia di Treviso ma anche del
responsabile locale di Legambiente, dei rappresentanti dei Comuni dell'area
DOCG e dell'Ulss 8. Presentato nel 2011 e adottato a partire dal 2012 su un
totale di 600 ettari di vigneto, il Protocollo Viticolo è un manuale di
autodisciplina voluto dai produttori dell'area del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore per rendere la viticoltura sempre più amica dell'ambiente.
E i risultati si vedono: le ricadute positive si sono registrate su una
superficie molto più estesa e l'obiettivo per il 2013 è quello di raddoppiare
la rappresentatività grazie a una serie di novità e al dialogo instaurato con
le ditte produttrici dei fitofarmaci e con i rivenditori, che hanno ricevuto in
via preliminare la bozza, in modo da poter costruire il proprio magazzino nel
rispetto del Protocollo. La rivoluzione bio avviata dal Consorzio con questo
documento abbatte sensibilmente il numero di prodotti ammessi a partire appunto
da quelli a base Mancozeb. Nel 2012 il loro impiego era previsto «in casi
specifici di gravità e rischio, previa consultazione dei bollettini
agrometeorologici» ora sono stati banditi 10 prodotti su 10. La linea
restrittiva è stata applicata anche su altri composti di fascia rossa, i più
tossici, autorizzati solo per pochi trattamenti a stagione. «I prodotti
antiperonosporici di fascia rossa passano da 19 a quatto», spiega Filippo
Taglietti, tecnico del Consorzio, «mentre gli antioidici della stessa categoria
da otto a uno». Sono invece ammessi molti composti di classe tossicologica Nc o
Xi, a basso impatto. Per tutti resta valido l'obbligo del patentino per
l'acquisto, ma il disciplinare di difesa si spinge oltre. Un'altra sostanziale novità è infatti l'indicazione dell'intervallo di sicurezza, ovvero dei giorni che secondo le indicazioni riportate in etichetta devono intercorrere fra l'ultimo intervento con il prodotto specifico e la raccolta delle uve; a questo si aggiunge il riferimento, qualora riportato, alla fascia di rispetto o “buffer zone” che consente all'utilizzatore di capire i confini e le pertinenze da osservare durante l'intervento fitosanitario per noi disperdere il prodotto nelle aree circostanti. Nella versione 2013 si integrano anche le informazioni utili per i viticoltori con l'inserimento del codice internazionale delle Modalità di Azione (MOA) delle sostanze attive presenti nelle formulazioni commerciali. L'obiettivo è quello di avviare una lotta ragionata contro tutte le avversità della vite, dalla peronospora all'oidio nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute di chi vi abita e lavora. Una finalità a cui si lavora a 360 gradi in tutte le fasi della filiera tanto che, sempre più spesso, le aziende imbottigliatrici del territorio richiedono ai propri conferitori come prerequisito il rispetto del Protocollo, pena il mancato acquisto delle uve. Per diffondere la conoscenza di questo strumento, il Consorzio di Tutela ha avviato un calendario di incontri in collaborazione con le associazioni di categoria, i Comuni e gli eventi sul territorio, con l'obiettivo di dare una corretta informazione, evitare gli allarmismi e rispondere alle domande degli abitanti. |
A Brisighella il Primo Concorso del Vitigno Albana |
| L'Albana, vitigno autoctono romagnolo, è sempre stato considerato dai
“vecchi” una vera eccellenza non riuscendo però a scatenare entusiasmi fuori
dei confini regionali e nei consessi di eno-appassionati. Il motivo? Forse
perché è un vino-vitigno bianco mascherato da rosso, per la sua componente
tannica, la sua acidità, la sua sensibilità all'ossidazione del colore e,
soprattutto, per la sua esuberanza alcolica. Se qualche anno addietro molti
produttori hanno cercato di “domarlo” e renderlo più fruibile, con risultati
spesso discutibili, oggi troviamo espressioni molto più personali e di
carattere che segnano la via per esprimere al meglio la potenzialità del
vitigno. Domenica 5 Maggio in Piazza Carducci a Brisighella si esaminerà lo stato dell'arte, con il 1° concorso dedicato all'Albana. Una commissione di degustatori professionisti, curatori delle principali guide eno-gastronomiche italiane selezionerà le migliori Albana nel corso di una degustazione “cieca”. Nel pomeriggio la degustazione dei migliori vini selezionati sarà aperta al pubblico che potrà votare quelli preferiti e partecipare così alla giuria popolare. Al termine della giornata saranno premiate le migliori Albana. Il concorso è rivolto alle sole Albana secche, suddivise in diverse categorie: DOCG, IGT, da tavola, tradizionali e con macerazione delle bucce. |
Lodi e l'Aceto Balsamico TradizionaleUna storia d'amore per l'aceto balsamico tradizionale, magnifico condimento nato in terra d'Emilia a Modena e adottato a Lodi |
|
Una delle discriminanti fra innamoramento e amore è il tempo. Dell'aceto balsamico tradizionale è facile innamorarsi, ma per amarlo ci vuole altro, esattamente come la decisione di immergersi in profondità dopo essere stati affascinati dallo spettacolo della bellezza del mare. Dopo avere incontrato l'aceto, magari casualmente, ci vuole cultura, curiosità e apertura mentale, attitudine ai tempi lunghi, pazienza di aspettare, voglia di fondere un pezzetto dei propri processi vitali a favore di questo prodotto, originato dalla natura ma che ha bisogno di attenzioni e cure (proprio come noi), per decidere di includerlo tra i nostri compagni di viaggio. Così succede che un giovane commercialista laureato alla Bocconi con interessi più che marginali nei confronti del vino e dei suoi derivati, incrocia l'aceto tradizionale di Modena. Da quell'incontro nasce un iniziale interesse discreto ma sufficiente a far scattare una crescente curiosità. Si svela quindi una storia che risale a circa il XV secolo, di un alimento che le spose delle casate più nobili di Modena e Reggio Emilia portavano in dote. Una storia fatta di tradizioni antiche che le famiglie patriarcali si trasmettevano di generazione in generazione, trasmettendo l'inestimabile valore della batteria di botti necessaria a produrre l'aceto, secondo la ricetta che ogni casato custodiva gelosamente come un sigillo distintivo. Un racconto talmente affascinante da indurre il nostro giovane commercialista a cercare di scrivere un capitolo squisitamente suo da aggiungere a una storia così importante: un tentativo di produzione personale (e con qualche probabilità di risultare velleitario) a Lodi, la sua città, della leggenda dell'aceto tradizionale di Modena. Si informa, si procura il vino e tre botticelle (numero minimo previsto dalla normativa) e inizia la sua avventura. La vita non sempre si cura della nostra volontà o delle nostre aspettative e spesso decide in modo diverso. Spetterà quindi al padre, insieme al suo tormento, di rendere vivi i sogni del figlio, fatti di disegni compiuti e di abbozzi, così da non destinarli nel buio di un esclusivo dolore. Sembra poco ma è l'unico modo che gli resta per continuare ad essere padre, ad occuparsi del figlio canalizzando l'energia vitale dei suoi progetti e, a mio parere, accarezzando l'inespressa speranza di trasmettere alle nipotine il gusto di coltivare antiche tradizioni. Non ha dubbi: allestisce un apposito locale sottotetto, rigorosamente senza riscaldamento, come da disciplinare e vi colloca, dopo averla completata, la batteria di sette botticelle di legni diversi e con volume decrescente. Nella botte grande il prodotto più giovane, nella botte più piccola quello maturo. Una batteria che è così composta: ciliegio (50 litri), frassino (40 litri), rovere (30 litri), acacia (25 litri), gelso (15 litri), ginepro (15 litri), rovere(10 litri) e destinata all'evoluzione e alla maturazione dell'aceto.
Contatta il titolare di un'acetaia di Modena per disporre del mosto cotto - ottenuto dal vitigno autoctono Trebbiano di Spagna - che andrà poi ad essere ospitato nella botte, definita correntemente a Modena come “Badessa”, capofila della batteria, deputata ad alimentare e supportare tutte le altre. Il metodo, infatti, prevede l'integrazione delle frazioni di liquido evaporato nel tempo o spillato per il consumo dal barile di “arrivo” (l'ultimo e il più piccolo), mediante “travasi” e “rincalzi” dalle botti precedenti, con uguale quantità di aceto. Il sistema è simile al metodo Soleras utilizzato per lo Sherry (Jerez) e il Marsala. Dopo aver ottenuto la supervisione sulle fasi evolutive, le tecniche di produzione e la verifica delle varie fasi di elaborazione, il racconto iniziato dal figlio può finalmente essere scritto, impaginandolo con scrupolo, attenzione quotidiana e cura minuziosa. Finalmente, l'aceto balsamico tradizionale, che nasce a Modena e adottato a Lodi, raggiunge nel 2009 il traguardo minimo di invecchiamento di 12 anni ed è pronto per essere degustato dalla botte di arrivo. Ecco le qualità organolettiche che ho annotato nel suo cartellino di identità, a seguito di una personalissima degustazione da sommelier e senza alcuna pretesa di ufficialità. In questo caso sarebbe infatti necessaria la qualifica di esperto degustatore di aceto balsamico tradizionale di Modena, qualifica che non possiedo. Il mio è un semplice confronto, fatto con l'umiltà di un devoto estimatore di Sua Maestà l'aceto tradizionale di Modena: Vista: colore bruno scuro lucente, limpido senza incertezze, buona densità sciropposa; Olfatto: profumo fine, gradevole, equilibrato e persistente supportato da una buona acidità ammansita subito dalla scia morbida; Gusto: dolce e agro armonico; l'acidità entra per prima e sembra volere prevalere, subito cede spazio alle note morbide procedendo in equilibrio per un tempo decisamente lungo nel quale prevalgono le impronte balsamiche e speziate in accordo con le sensazioni olfattive; Giudizio Complessivo: prodotto vivo con comportamenti ancora giovani che ampliano il tempo delle sensazioni passando dall'irruenza iniziale a un abbraccio morbido su un tappeto di acidità gradevole che si fa fatica a dimenticare. Il nostro aceto balsamico tradizionale cresciuto a Lodi, rispetto al suo nobile fratello di Modena ha qualcosa in più. Alle sensazioni gusto-olfattive aggiunge le suggestioni del cuore: l'incontro con qualcuno che sa essere compagno generoso e discreto, capace di viverti accanto e di fondere storie personali diverse e talvolta complicate, in un unico progetto vitale che evolve nel tempo, grazie a uno scambio reciproco di energia e di emozioni. Per questo motivo non può, e non vuole collocarsi, in alcuna prospettiva economico-commerciale ma si inserisce in un ambito di sentimenti personali e di rapporti disinteressati per dimostrare, ancora una volta, l'intreccio profondo tra cultura del vino e storia dell'uomo. Rino Lombardo
|
||||||||||||
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
| I punteggi delle acqueviti sono espressi secondo il metodo di valutazione di DiWineTaste. Fare riferimento alla legenda dei punteggi nella rubrica "I Vini del Mese" |

|
|
Acquavite di Morellino Essenza di Nero 2004 |
|
| Villa Acquaviva (Toscana, Italia) | |
| (Distillatore: Distilleria Nannoni) | |
| Materia prima: Vinaccia di Morellino di Scansano | |
| Prezzo: € 35,00 - 50cl | Punteggio: |
| Acquavite di Morellino Essenza di Nero si presenta in colore, limpida e cristallina. Al naso denota aromi intensi, puliti e gradevoli di amarena, violetta, nocciola, prugna e lampone, con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. In bocca ha sapori intensi con pungenza dell'alcol che tende a dissolversi rapidamente, buona corrispondenza con il naso, piacevole morbidezza, dolcezza equilibrata. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e nocciola. Acquavite di Morellino Essenza di Nero è prodotta con alambicco discontinuo a caldaiette di vapore. Alcol 42°. | |
Wine Parade |
|
|
| I 15 migliori vini secondo i lettori di DiWineTaste. Per esprimere le vostre preferenze comunicate i vostri tre migliori vini al nostro indirizzo di posta elettronica oppure compilare il modulo disponibile nel nostro sito. |
| Posizione | Vino, Produttore | |
|---|---|---|
| 1 |
| Avvoltore 2009, Moris Farms (Italia) |
| 2 |
| Trento Talento Brut Riserva 2007, Letrari (Italia) |
| 3 |
| San Leonardo 2006, Tenuta San Leonardo (Italia) |
| 4 |
| Franciacorta Pas Dosé Récemment Dégorgé 2006, Cavalleri (Italia) |
| 5 |
| Confini 2007, Lis Neris (Italia) |
| 6 |
| Sagrantino di Montefalco Collepiano 2007, Arnaldo Caprai (Italia) |
| 7 |
| Trento Brut Riserva Methius 2006, Dorigati (Italia) |
| 8 |
| Adarmando 2009, Tabarrini (Italia) |
| 9 |
| Camartina 2008, Querciabella (Italia) |
| 10 |
| Brunello di Montalcino 2007, Donatella Cinelli Colombini (Italia) |
| 11 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2010, Garofoli (Italia) |
| 12 |
| Batàr 2008, Querciabella (Italia) |
| 13 |
| Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi 2007, Tedeschi (Italia) |
| 14 |
| Offida Rosso Il Grifone 2006, Tenuta Cocci Grifoni (Italia) |
| 15 |
| Gran Masetto 2007, Endrizzi (Italia) |
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |