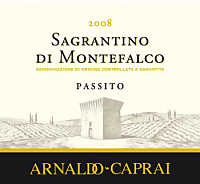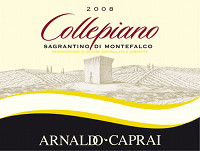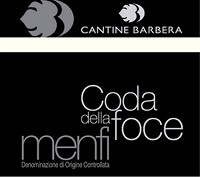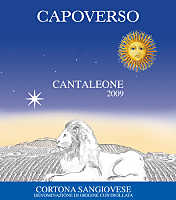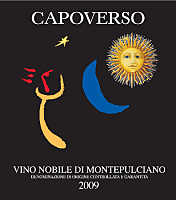|
Fra i vari componenti del vino, l'alcol è certamente quello più deplorato. Non
tanto per il fatto di essere alcol, piuttosto per i noti effetti che
questo può provocare nell'organismo. A tale proposito si deve ricordare che
nessuna cosa è buona o cattiva: è sempre l'uso, o l'abuso, che se ne fa a
renderla l'una o l'altra. In effetti, quello che pone l'alcol nel banco degli
imputati è proprio dovuto alle conseguenze derivanti dal suo abuso, non certo
dal suo consumo moderato e intelligente. Non è infatti una novità che l'uso
moderato e saggio di alcol può anche essere benefico per l'organismo, mentre
l'abuso - qui tutti sono d'accordo, nessuna eccezione - oltre ad essere un atto
idiota e dissennato, che non è giustificabile o condivisibile in nessun caso, è
sovente causa di danni all'organismo, anche cronici e irreversibili. Il piacere
è ben diverso dalla disgraziata condizione della dipendenza, soprattutto quando
porta a conseguenze deprecabili sia per sé stessi sia per gli altri.
Bello e buono, brutto o cattivo che sia, l'alcol è comunque un componente
fondamentale nel vino, probabilmente l'elemento che ne ha storicamente
determinato l'interesse da parte degli uomini e il suo cammino nella storia
dell'umanità. Poeti, letterati, storici e filosofi di ogni era, hanno sempre
decantato le virtù del vino e di quella sua caratteristica di donare gioia e
spensieratezza, allietare l'animo, corroborare lo spirito e il corpo. In quasi
tutte le culture e le società nelle quali il vino era presente, questo era
elevato ad autentica bevanda sacra, riservata ai riti più significativi,
probabilmente a causa dell'effetto inebriante dell'alcol, ma anche per
l'associazione - soprattutto per il vino rosso - che questo facilmente evocava
con il sacro liquido che manteneva in vita gli uomini, ovvero il sangue. A tale
proposito, basti ricordare l'uso eucaristico del vino nel rito religioso dei
cristiani e che proprio da questa analogia trae la sua origine.
Da qualche tempo, il mercato offre anche vini senza alcol, prodotti con un
processo industriale meglio noto come dealcolizzazione, tuttavia
l'importanza dell'alcol nella degustazione sensoriale e nell'equilibrio del vino
resta fondamentale. A tale proposito, è bene ricordare che il vino stesso è
prodotto dalla fermentazione alcolica del succo d'uva, un processo che,
inevitabilmente, porta alla produzione di alcol e, se non opportunamente
controllato, alla produzione di aceto. Il vino stesso esiste in quanto esiste
l'alcol e il complesso processo biochimico che lo produce per opera dei lieviti,
ma - va detto, ribadito e ricordato - che il vino non è solo alcol. Se si
considera il contenuto medio di alcol nel vino, questo rappresenta generalmente
il 13% della bevanda, pertanto non si tratta dell'elemento dominante. Il vino,
com'è noto, è bevanda complessa, non solo dal punto di vista sensoriale, ma
anche da quello chimico, dove l'alcol rappresenta uno delle centinaia di
elementi che lo compongono.
L'alcol, come già detto, è il risultato della fermentazione, un processo
biochimico svolto dai lieviti, organismi unicellulari che, in assenza di
ossigeno, convertono gli zuccheri in alcol etilico e anidride carbonica. La
fermentazione è, di fatto, il processo che assicura la sopravvivenza dei lieviti
in mancanza di ossigeno, grazie alla conversione degli zuccheri. All'inizio di
questo complesso processo, i lieviti posso sopravvivere in condizioni di
respirazione aerobica - cioè in presenza di ossigeno - durante il quale
gli zuccheri sono convertiti in acqua e anidride carbonica. Quando l'ossigeno è
stato consumato completamente, il processo prosegue in condizioni
anaerobiche - cioè in assenza di ossigeno - ed è proprio questa fase che
prende il nome di fermentazione, assicurandosi la sopravvivenza unicamente
dall'energia ottenuta dagli zuccheri. La fermentazione è comunque un processo
inevitabilmente letale per i lieviti, sia per il consumo dell'unica fonte di
energia, lo zucchero, sia perché l'alcol etilico, in alte concentrazioni,
risulta tossico per la loro sopravvivenza.
|
|  |
| Chiaro e limpido: l'alcol nella sua
forma pura si presenta come un liquido trasparente e cristallino |
|
La fermentazione si conclude quindi - in presenza di condizioni ambientali
favorevoli - sia per il totale consumo dello zucchero, sia per l'elevata
quantità di alcol che in certi casi è prodotta dai lieviti. Senza lo zucchero, i
lieviti si trovano senza possibilità di sopravvivenza e di nutrimento,
condizione che porta inevitabilmente al termine della loro attività biologica,
lasciando al liquido una certa quantità di alcol etilico. Per completezza, va
detto che il processo di fermentazione produce anche altre sostanze, seppure in
quantità decisamente inferiori all'alcol etilico, fra le tante, la “celebre” e
tanto discussa anidride solforosa. Al termine della fermentazione - tecnicamente
detta alcolica o primaria - i lieviti restituiranno il succo d'uva
nella forma di vino, bevanda complessa e caratterizzata da innumerevoli aromi e
sapori, nei quali l'alcol etilico svolge un ruolo fondamentale. Si deve inoltre
ricordare che anche i cosiddetti vini senza alcol nascono per effetto di
questo processo, al termine del quale l'alcol viene eliminato con specifici
metodi, fra questi, i più diffusi sono l'osmosi inversa e la
distillazione frazionata.
Sempre per completezza di informazione, va ricordato che talvolta il processo di
dealcolazione viene applicato anche ai vini da tavola con lo scopo di abbassare
il volume alcolico di qualche grado. Prove di degustazione condotte alla cieca
sui vini dealcolati, o parzialmente dealcolati, ha rilevato che il processo di
sottrazione dell'alcol elimina anche altre componenti del vino, in modo
particolare quelle aromatiche. L'alcol, infatti, svolge un ruolo attivo nella
percezione delle sostanze gustative e, particolarmente, quelle olfattive. Questo
si spiega, fra l'altro, grazie alla capacità dell'alcol di volatilizzare,
sollevando letteralmente le sostanze odorose dalla superficie del vino
favorendone quindi la percezione olfattiva, sia per intensità, sia per varietà e
qualità. Per questo motivo, spesso i sistemi di dealcolizzazione prevedono il
recupero e la successiva reintroduzione nel vino dealcolizzato della frazione
aromatica estratta durante l'eliminazione dell'alcol, reintroduzione che - in
ogni caso - non avrà la stessa intensità e qualità della forma originale.
Il volume alcolico attualmente presente nei vini da tavola è mediamente del
13,5%, tuttavia si registrano frequentemente valori che raggiungono il 14,5%,
talvolta anche superiore a questo valore. In tempi passati, comunque non molto
distanti, il volume alcolico era decisamente più contenuto, con valori medi del
12,5%, un valore che, non solo rappresentava la media, ma era anche considerato
medio-alto. Oggi si considera questo valore medio-basso ed è
anche piuttosto difficile trovare vini con un volume alcolico del 12,5%. Le
ragioni dell'innalzamento del volume alcolico sono molteplici. I cambiamenti
climatici degli ultimi anni, caratterizzati da stagioni estive piuttosto calde e
afose, incidono notevolmente sul ciclo della maturazione delle uve e, con
questo, sullo sviluppo degli zuccheri, aumentandone la quantità. I lieviti, come
già detto, utilizzano lo zucchero per condurre la fermentazione: con una
maggiore quantità disponibile, la fermentazione è più lunga e, nel contempo, si
produce anche una quantità superiore di alcol.
L'alcol è uno dei tanti elementi che contribuiscono all'equilibrio gustativo del
vino, specificamente, è uno di quei componenti che si definiscono
morbidi, cioè preposti all'equilibrio delle sostanze definite
dure. Com'è noto, una delle caratteristiche primarie che definiscono la
qualità nei vini è appunto l'equilibrio. Un vino troppo morbido - sensazione
alla quale contribuisce anche l'alcol - rende il profilo gustativo piatto e
stanco, quasi senza alcun accenno di vivacità. Un vino troppo alcolico,
non opportunamente equilibrato, tende infatti a produrre questa sensazione in
bocca, oltre a risultare troppo “caldo” per effetto del tipico effetto
caustico e irritante svolto sulle papille gustative. La tipica sensazione
tattile dell'alcol può essere infatti diminuita attraverso un opportuno
equilibrio, come per esempio, aumentando l'astringenza o l'acidità del vino.
È bene ricordare che l'equilibrio dell'alcol non diminuisce la sua quantità
presente nel vino, semplicemente ne diminuisce la percezione. Questo significa
che al gusto un vino può sembrare meno alcolico di quanto non sia
effettivamente, tuttavia la quantità di alcol non subisce alcuna variazione. Si
prenda, ad esempio, un vino prodotto con uva Nebbiolo. La fermentazione del
mosto di quest'uva tende a produrre quantità di alcol significative - talvolta
anche superiore al 14% - tuttavia la presenza di sostanze acide e
dell'astringenza, sia quella tipica dell'uva, sia quella introdotta dall'uso
della botte, rende il vino equilibrato e, con questo, anche la sensazione
alcolica che si percepisce in bocca sembrerà più mite. Si tratta quindi di una
percezione relativa e non quantitativa, concetto che è valido per qualunque
altro stimolo olfattivo o gustativo. Infine, la percezione di uno stimolo e la
sua intensità sono determinati anche dalla soglia di percezione di ogni
individuo.
Prima di trattare gli aspetti organolettici legati al gusto e al contributo
dell'alcol nel profilo gustativo di un vino, soffermiamoci sul ruolo di questo
elemento nella percezione degli aromi. L'alcol etilico è una sostanza volatile,
pertanto - come tale - tende a “sollevarsi” dalla superficie del vino e a
disperdersi nell'aria. Durante la sua volatilizzazione, l'alcol risulta
estremamente utile nella percezione delle sostanze aromatiche, poiché trasporta
letteralmente questi composti verso l'alto, facilitando la loro
percezione al naso. Come già detto in precedenza, un vino con un basso contenuto
alcolico - o totalmente privo di alcol - risulta essere meno aromatico e certe
componenti olfattive risultano decisamente attenuate e più difficili da
percepire al naso. A questo fanno eccezione i vini prodotti con uve cosiddette
“aromatiche”, come Moscato Bianco e Gewürztraminer, grazie all'abbondanza e
all'intensità dei loro componenti aromatici, risultano comunque ben percettibili
anche senza l'aiuto dell'alcol etilico. A titolo di esempio, si può considerare
il Moscato d'Asti: nonostante il suo volume alcolico sia in genere del 5%, la
sua esuberanza aromatica è sempre ben percettibile.
Dal punto di vista gustativo, l'alcol si presenta in bocca con molteplici
sensazioni organolettiche, sia gustative, sia tattili. La sensazione più
evidente e dominante dell'alcol è quella tattile. L'effetto tattile più evidente
prodotto dall'alcol è riconoscibile da una sensazione che ricorda il
calore, solitamente descritto come effetto pseudocalorico. Questo
effetto caustico è conseguenza della secchezza delle mucose della cavità orale
prodotto dall'alcol, un'irritazione che si può facilmente confondere con la
sensazione di “bruciore”. Tanto maggiore la quantità di alcol, per essere
esatti, tanto più lo squilibrio dell'alcol nel vino, maggiore la sensazione di
bruciore che questo provoca. Si pensi, ad esempio, all'effetto di un distillato,
nel quale la quantità dell'alcol è piuttosto elevata e, benché equilibrato da
altri componenti, la sensazione di bruciore è evidente e può durare molti
secondi.
Quando la sensazione tattile di bruciore si sarà placata, finalmente si potrà
percepire il sapore dell'alcol, tendenzialmente dolce. Non si tratta di una
dolcezza “evidente” come nel caso dello zucchero, tuttavia la sensazione di
dolcezza è ben percettibile nel sapore dell'alcol. Altra caratteristica
gustativa-tattile dell'alcol è la rotondità che produce in bocca: per
questo motivo, e per il suo sapore tendenzialmente dolce, l'alcol è classificato
fra le componenti “morbide” nella determinazione dell'equilibrio di un vino.
Il suo eccesso gustativo - dolcezza e morbidezza - deve essere quindi
equilibrato in giusta misura da sostanze “dure”, come l'astringenza, l'acidità
e la quantità di sostanze minerali. Per contro, la sua presenza sarà utile a
bilanciare gli eccessi di acidità e di astringenza presenti nel vino, utile
quindi sia nei vini bianchi, dove l'acidità è un elemento caratteristico, sia
nei vini rossi, nei quali troviamo sia l'acidità e sia - soprattutto -
l'astringenza prodotta dai tannini.
|