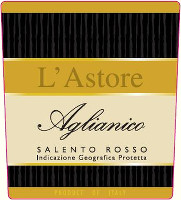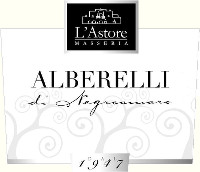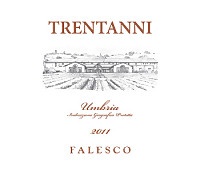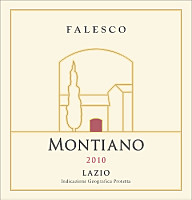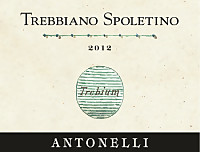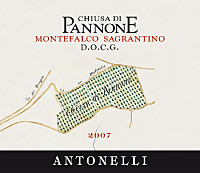|
Confrontare vini bianchi e rosati può sembrare un controsenso. Dal punto di
vista enologico, si tratta certamente di due stili di vino che, in termini
generali, non hanno molto in comune, a partire dalle uve. I vini bianchi,
infatti, si producono esclusivamente con uve a bacca bianca, mentre i rosati
con uve a bacca rossa. A tale proposito, è opportuno ricordare che, in accordo
alle leggi enologiche vigenti in quasi tutti i paesi vinicoli del mondo, la
produzione di vini rosati attraverso l'unione di vini bianchi e rossi è
vietata. L'unico stile di vino per il quale si prevede l'eccezione a questa
regola, è quello spumante, poiché, per quelli rosati è ammessa la produzione
del vino base mediante l'unione di bianchi e rossi. A titolo di completezza,
questo metodo non sempre è impiegato nella produzione di spumanti: molti di
questi sono infatti prodotti con vini veramente rosati e unicamente da uve a
bacca rossa.
Tipi di uve a parte, la produzione di vini bianchi e rosati hanno comunque
alcune caratteristiche enologiche in comune. Prima di discutere le analogie
sensoriali dei due stili, ricordiamo - brevemente - la loro produzione. I vini
bianchi si producono solitamente con uve bianche e subito dopo la pigiatura -
operazione che consente l'estrazione del succo dell'uva dagli acini - le bucce
sono separate dal mosto. Al termine delle eventuali operazioni di
stabilizzazione e “pulizia” del mosto, si avvia la fermentazione alcolica.
Questo metodo di produzione prende il nome di vinificazione in bianco ed
è usato anche nel caso dell'impiego di uve a bacca rossa per le quali il mosto
è immediatamente separato dalle bucce. In questo specifico caso, è bene
ricordare il vino che si ottiene in questo modo è sempre e comunque “bianco”
anche nel caso di uve a bacca rossa. Così nascono, per esempio, gli spumanti
metodo classico detti blanc de noirs, cioè bianchi da uve rosse.
La produzione dei vini bianchi non segue necessariamente e unicamente questo
modello enologico. La tecnica, infatti, può divenire più articolata e complessa
in certi casi, tuttavia - in termini generali - la loro produzione prevede
questa procedura. I vini rosati - come già detto - si producono con le uve
rosse e, dopo la pigiatura, le bucce dell'uva sono lasciate in macerazione con
il mosto così da estrarre colore. Si deve infatti ricordare che il colore dei
vini rosati, esattamente come nei rossi, deriva dalle sostanze coloranti che si
trovano nella buccia dell'uva. Il tempo di macerazione è uno dei fattori che
determina la quantità di colore che sarà estratto dalle bucce: con l'aumentare
del tempo il vino assume un colore che tende sempre più al rosso. Si deve
ricordare che il potere colorante delle uve è caratteristico a ogni singola
varietà, pertanto il contenuto di sostanze coloranti, unitamente al tempo,
determina l'intensità del colore rosato o rosso.
Nelle bucce dell'uva non c'è solamente colore. Questa infatti è anche la sede
delle sostanze aromatiche - variabili per natura e per intensità in accordo
alle singole varietà - una caratteristica valida, soprattutto, per le uve
bianche. La macerazione delle bucce nel mosto, oltre a estrarre colore e
sostanze polifenoliche, arricchisce il succo dell'uva di profumi e aromi. Se è
vero che nei vini rossi e rosati l'estrazione delle sostanze polifenoliche
dalle bucce potrebbe essere un fattore desiderato, in quelli bianchi è talvolta
inopportuno e indesiderato. L'estrazione di polifenoli è in genere evitata
nella produzione dei vini bianchi, tuttavia - va detto - spesso è impiegata
proprio per arricchire il mosto di sostanze polifenoliche e conferire un colore
più intenso. Durante la macerazione si avvia solitamente anche la fermentazione
alcolica, la quale - a causa dell'aumentare della temperatura e della
progressiva produzione di alcol - favorisce l'estrazione sia del colore sia
delle sostanze polifenoliche.
|
 | |
| Vini bianchi e rosati:
apparentemente diversi e con molte cose in comune | |
|
Per questo motivo - e in termini generali - il mosto dei vini bianchi lasciato
a contatto con le bucce e con lo scopo di estrarre sostanze aromatiche, è
mantenuto a una temperatura bassa così da evitare l'avvio della fermentazione.
La durata della macerazione delle bucce nel mosto è solitamente di poche ore e
difficilmente si protrae per oltre un giorno. Trascorso il tempo stabilito, sia
per i bianchi sia per i rosati, il mosto è separato dalle bucce e si procede in
ogni caso con la fermentazione, la quale potrebbe anche essere iniziata durante
la macerazione. Per certi vini bianchi e che prevedono questa tecnica
produttiva, la fermentazione si avvia già durante la macerazione con le bucce
e, in alcuni casi, la separazione avviene solamente al termine di questa fase.
Lo stesso non accade per i rosati, poiché la macerazione non supera
generalmente le ventiquattro ore e la fermentazione non è mai svolta
completamente in presenza delle bucce.
La produzione di vino bianco e rosato, considerata secondo queste tecniche,
presenta analogie piuttosto evidenti, poiché il ruolo delle bucce interviene in
entrambi i casi. Va detto che la produzione di vino che prevede l'impiego delle
bucce nel processo della fermentazione si definisce vinificazione in
rosso anche nel caso di vini bianchi. In questo caso specifico, il vino è
definito come bianco vinificato in rosso pur non assumendo questo
colore. Al termine della fermentazione, un vino bianco vinificato con le bucce,
avrà un colore decisamente più intenso e carico rispetto allo stesso vino
separato dalle bucce subito dopo la pigiatura. La lunga macerazione dei vini
bianchi con le bucce determina, in ogni caso e come vedremo più avanti,
sostanziali caratteristiche sensoriali, dall'aspetto al gusto. La stessa cosa
accade, ovviamente, anche nei vini rosati: la durata della macerazione con le
bucce influisce sulle sue qualità sensoriali.
Le analogie dell'aspetto dei vini bianchi e rosati sono ovviamente limitate:
colori diversi, gialli i primi gialli, rosa i secondi. L'unica vera analogia
della quale si può parlare è relativa alla trasparenza. In entrambi i casi si
può parlare di vini con una trasparenza moderata o elevata; trasparenze più
ridotte restano comunque caratteristiche di certi rossi. Nei vini rosati
lasciati macerare nelle bucce per un tempo brevissimo - in genere sei ore - il
colore può essere estremamente tenue, soprattutto in quelli prodotti con uve
rosse dal basso potere colorante. In questi casi, nell'osservazione della
sfumatura del colore - eseguita inclinando opportunamente il calice - si
possono talvolta notare delle tonalità che tendono al giallo oppure
all'arancio. In fin dei conti, un vino rosato è un mosto “bianco” variamente
colorato di rosa, in tonalità e intensità diverse. Nel caso di macerazioni
brevi, la natura “bianca” del mosto diviene evidente.
I profili aromatici dei due tipi di vino sono decisamente caratterizzati da un
numero maggiore di analogie, nonostante la sommaria valutazione dei loro
aromi evidenzi chiaramente delle differenze sostanziali. In termini generali,
nei vini bianchi si percepiscono prevalentemente aromi di fiori bianchi e
gialli così come frutti a polpa bianca e gialla. Nei vini rosati, le percezioni
prevalenti riguardano invece fiori rossi e rosa, oltre a frutti rossi, più
raramente, frutti neri. In termini generali, le tipiche qualità aromatiche dei
vini rosati non si percepiscono nei vini bianchi, salvo in rare eccezioni e in
vini prodotti con tecniche particolari. Il contrario, invece, può accadere e
anche spesso. Questo significa che nei vini rosati può essere normale
percepire, oltre ai caratteristici aromi di questo stile, molte delle
sensazioni olfattive tipiche dei bianchi.
Le analogie olfattive principali comuni a bianchi e rosati sono classificabili
nelle famiglie aromatiche di fiori e frutti. Fra i principali aromi tipici dei
vini bianchi e talvolta percettibili nei rosati si ricordano: biancospino,
gelsomino e lavanda. Le sensazioni riconducibili alla frutta sono decisamente
più ricche, trovando perfino analogie nella frutta esotica. Pesca, susina,
pera, mela, banana, kiwi, albicocca e nespola - solo a titolo di esempio - sono
infatti percettibili anche nei vini rosati. Si tratta, in ogni caso, di
sensazioni che sono generalmente “secondarie” per intensità rispetto agli
aromi tipici dei rosati, pur rilevando che - in certi casi - questi aromi sono
decisamente intensi. Un'altra analogia olfattiva che, talvolta, si può rilevare
sia nei vini rosati e, più frequentemente, in quelli bianchi, è l'aroma di
mandorla, in particolare in certi rosati prodotti nel meridione d'Italia.
Le analogie olfattive possono aumentare nel caso di vini fermentati o maturati
in botte. Questa pratica è solitamente poco utilizzata per i vini rosati,
poiché, nella maggioranza dei casi, si preferisce vinificarli in contenitori
inerti proprio per esaltare e conservare i caratteri di fiori e frutta.
Esistono tuttavia diverse eccezioni nelle quali i vini rosati sono fatti
maturare, o addirittura fermentare, in botte. Com'è prevedibile, sia nei
bianchi sia nei rosati, la percezione dei profumi conferiti dal legno al vino
diviene evidente e determinante in funzione della durata di permanenza
nella botte. In questo caso, non si può parlare esattamente di analogia fra i
due stili di vino: si tratta piuttosto di analogia produttiva e che può essere
ricondotta a qualunque stile, rossi compresi.
L'analogia fra vini bianchi e rosati si può rilevare anche al gusto. La
freschezza - concetto sensoriale associato all'acidità - è una caratteristica
tipica dei vini bianchi e molto comune anche nei rosati. L'intensità
dell'acidità nei vini rosati, a livello sensoriale può raggiungere quella dei
bianchi, una qualità fondamentale per il loro equilibrio. L'intensità della
freschezza è ovviamente in funzione della varietà di uva, tuttavia è da
rilevare che i vini rosati risultano più gradevoli quando sono prodotti con uve
caratterizzate da un significativo contenuto di sostanze acide. L'acidità nei
vini rosati risulta infatti utile ed essenziale per l'equilibrio dell'alcol e
dell'eventuale residuo zuccherino. Per questo motivo i rosati si servono
solitamente a una temperatura piuttosto fresca - intorno ai 12 °C - proprio per
valorizzare maggiormente il loro carattere fresco.
Anche la morbidezza è decisamente simile a quella dei vini bianchi, cioè è
piuttosto contenuta, almeno nei casi di produzione in contenitori inerti, come
le vasche in acciaio o cemento. La fermentazione o maturazione in legno
conferisce sia morbidezza sia una tenue astringenza, dovuta alla cessione di
tannini nel vino. L'astringenza è determinata anche dalla durata della
macerazione nelle bucce, caratteristica che è inoltre relativa alla varietà
specifica di uva. La fermentazione e la maturazione in legno conferisce una
lieve astringenza anche nei vini bianchi, esattamente come i rosati, può essere
ulteriormente accentuata dalla macerazione nelle bucce. La fermentazione e la
maturazione in botte, così come la macerazione nelle bucce, contribuiscono ad
aumentare inoltre la struttura di entrambi gli stili di vini, rendendoli, a
volte, perfino robusti.
|