
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 162, Maggio 2017 |
Sommario |
|
|
Diavoli di Legno |
|
Pensavo che certi argomenti fossero oramai consegnati all'oblio. Dopo feroci discussioni fra sostenitori e detrattori, vittime eccellenti di eccessi ideologici, immaginavo che - finalmente - si potesse parlare di altri aspetti del vino. Nel corso degli ultimi anni, il mondo del vino ha vissuto tendenze, mode e filosofie dal sapore di religione integralista, tutte legate a una sorta di guerra santa combattuta strenuamente in nome di una non meglio specificata purezza del vino. Uno scontro ideologico e tecnico combattuto su fronti diversi, che ha visto protagonisti - loro malgrado e inconsapevolmente - lieviti, anidride solforosa e quant'altro ritenuto colpevole di supposte sofisticazioni, anche lievi, in nome di una non sempre comprensibile purezza enologica. In tutti questi anni - caratterizzati da infinite chiacchiere, spesso inverosimili, infondate e futili, perfino sostenute da motivi senza alcun fondamento pratico, tecnico e scientifico - un “elemento”, in particolare, sembrava essere escluso da questi scontri. Il legno, o per meglio dire, la botte, nello specifico una botte particolare - la barrique - sembrava essere esclusa dalle nuove scuole di pensiero enologico, tutti concentrati altrove e puntando il dito contro la chimica. Che poi, piaccia o no, il vino non è altro che il risultato di processi chimici e biologici, usati e controllati dall'uomo con lo scopo di ottenere un vino capace di gratificare le nostre emozioni e il nostro piacere. Il legno, seppure protagonista in passato di feroci discussioni, non sembrava torturare più i pensieri dei puristi e appassionati, tanto da tenerlo più o meno escluso dalle mode degli anni recenti. Tutti a puntare il dito contro i lieviti selezionati, l'aggiunta di anidride solforosa e altri additivi, pratiche virtuose in vigna, rispetto per l'ambiente e viticoltura sostenibile. La barrique sembrava essere esclusa, forse oramai considerata uno strumento - uno dei tanti - ammissibile e accettabile nella produzione di vino, apparentemente assolta dal ruolo di demonio infernale. Invece no. Per molti, la celebre botte bordolese da 225 litri è ancora un simbolo di chissà quale orrenda pratica enologica, una sofisticazione invereconda che lede pesantemente l'espressione delle uve e dei territori. Mi chiedo se a Bordeaux pensano la stessa cosa. Chissà se pensano che la barrique - con la sua anima impura e satanica - sia capace di plagiare Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e le altre di quella terra, oltre ai tanti celebri cru di quel territorio. Non so dire se si tratti semplicemente dell'atteggiamento difensivo nel rifiutare qualunque cosa che non appartiene alla propria cultura o tradizione, oppure di autentica ignoranza. Quello che posso dire - così pensavo - è che la crociata contro la barrique, che tanto ha acceso gli animi di produttori e appassionati fino a una quindicina di anni fa circa, fosse oramai superata e conclusa. Mi capita molto spesso di incontrare produttori e di assaggiare i loro vini, ascoltare le loro storie e le visioni personali, viticolturali ed enologiche con le quali producono i loro vini. In particolare, mi appassiono spesso nell'ascoltare i produttori che non conosco, sia perché sono spinto da curiosità, sia per l'opportunità di conoscere qualcosa di nuovo e - magari - buono. Si discute, si scambiano opinioni che sono sempre utili al costruttivo confronto anche quando non si condividono le idee degli altri. In particolare, mi interessano le pratiche viticolturali ed enologiche che portano alla creazione dei loro vini, anche per meglio comprendere il risultato in funzione delle uve e delle tipicità del territorio. In altre parole, cosa fa il produttore per interpretare quello che coltiva in vigna. Mi interesso inoltre ai contenitori utilizzati per la fermentazione e maturazione dei vini, fra questi - ovviamente - le botti. Non tutti i produttori sono uguali e ognuno ha la sua visione su come deve essere il vino, in particolare il suo vino, ognuno forte di idee - fondate o meno - su cosa può o deve entrare nella sua vigna e cantina. Di recente, mi è capitato più di una volta di confrontarmi sul tema botti e barrique con alcuni produttori che non conoscevo, rilevando che per alcuni questo tema è piuttosto sgradevole e controverso. In particolare la barrique che è vista da molti come il male assoluto del vino, responsabile della peggiore mistificazione enologica e, secondo loro, quelli che la usano non sanno come si fa il vino. Il vero vino, ovviamente. Insomma, con alcuni è stato un po' come parlare del diavolo in chiesa. A loro dire la barrique distrugge la vera natura del vino, ne stravolge il gusto e i profumi, un oltraggio all'integrità di uve e territori. Personalmente, insisto nel dire che qualunque pratica svolta dall'uomo - qualunque e senza eccezione alcuna - produce l'effetto di alterare e “veicolare” il gusto e il carattere del vino. Lo fanno i lieviti selezionati, non da meno quelli indigeni, lo fa l'anidride solforosa, anche quella naturalmente prodotta dalla fermentazione indipendentemente dal tipo di lievito. Alterano il sapore del vino anche i travasi e il tempo, pure l'ossigeno, che semplicemente fa il proprio lavoro, nel bene e nel male. Io credo che, molto spesso, si tratta dell'incapacità di sapere usare certi strumenti o, forse, di non averne compreso il ruolo e l'effetto. Chiunque sa, infatti, che non si mette il vino in botte o in barrique per alterarne il gusto. Chi lo fa per ottenere questo risultato evidentemente è perché ha un pessimo vino che cerca di mascherare alla meno peggio. Ciò che rende buono o cattivo uno strumento o un oggetto è esclusivamente il tipo di uso che se ne fa. Una pistola non è né buona né cattiva: e l'uso che se ne fa a renderla l'una o l'altra. A tale proposito mi piace citare queste celebri parole: «il migliore vino passato in legno è quello dove il legno non si sente». Chi l'ha detto? Émile Peynaud, senza timore di smentita uno dei più grandi enologi dell'era moderna, per giunta francese e che di barrique e botti - evidentemente - ne capiva qualcosa. E non solo di quello. Antonello Biancalana
|
||||
Contrasti di Freisa e RabosoDue rosse di personalità - la prima tipica del Piemonte, la secoda del Veneto - si confrontano questo mese nei nostri calici |
|
Torniamo a parlare di vini rossi confrontando due varietà italiane, protagoniste di interessanti vini nei rispettivi territori. Le uve che confronteremo nei calici di questo mese sono la Freisa - celebre varietà rossa del Piemonte - e il Raboso, uva veneta particolarmente diffusa nell'area della denominazione Piave. I vini prodotti con queste varietà rosse risultano molto diversi fra loro, in particolare nei profumi e nel gusto. In comune - per così dire - condividono una storia recente che testimonia una riscoperta e un rinnovato interesse, dopo avere trascorso un lungo periodo di apparente disinteresse. Questo è particolarmente vero per il Raboso - uva difficile e scontrosa - che, a causa delle sue decise qualità organolettiche, ha subito gli effetti di mode moderne orientate verso altri vini. La Freisa, certamente fra le varietà più celebri del Piemonte, ha invece subito la notorietà e l'imponenza di altri vini della regione. La notorietà raggiunta negli anni recenti da Nebbiolo e Barbera, hanno determinato una significativa perdita di interesse nei confronti della Freisa - e di altre varietà piemontesi - mantenendo comunque la propria identità nelle aree di maggiore diffusione. Lo stesso destino, per così dire, ha limitato la diffusione del Raboso, poiché - negli ultimi venti anni - i vini rossi del Veneto sono stati principalmente identificati con la Valpolicella e quindi l'Amarone. La tenacità dei produttori nei rispettivi territori e regioni, ha comunque consentito a Freisa e Raboso di mantenere con orgoglio la propria dignità enologica. Questo è stato particolarmente vero per il Raboso che, dopo un lungo periodo di scarsa diffusione e notorietà fuori dal proprio territorio, sta diventando oggi una delle varietà a bacca rossa più riconoscibili del Veneto. Freisa e Raboso offrono ai sensi del degustatore vini dalla personalità spiccata e riconoscibile, in ogni caso molto diversi fra loro, perfetti per una degustazione per contrasto.
|
|
Originaria del Piemonte, la Freisa è un'importante varietà a bacca rossa prevalentemente diffusa nel Monferrato e nella provincia di Asti, oltre al territorio del Canavese e di Biella. Una significativa presenza della Freisa si registra inoltre nelle Langhe, dove subisce maggiormente la notorietà del Nebbiolo e delle altre uve di quell'area. In queste terre, la Freisa è tradizionalmente prodotta in due stili enologici: fermo e frizzante. La Freisa è riconosciuta in molti disciplinari di produzione del Piemonte a Denominazione di Origine Controllata e, fra queste, le più celebri sono certamente la Freisa d'Asti, Freisa del Monferrato, Langhe Freisa e Freisa di Chieri. Da notare tutte le denominazioni che includono la Freisa prevedono gli stili fermo e frizzante e, in alcuni di questi, possono concorrere anche altre uve ammesse nel territorio. Questo significa che non sempre si tratta di vini prodotti con Freisa in purezza. Non si hanno certezze sull'origine della Freisa, tuttavia sono in molti a concordare che questa varietà è presente in Piemonte da tempo immemore. In particolare, si ritiene che la Freisa sia originaria della zona che si trova fra Torino e Asti. Le prime citazioni risalgono al 1500 e, già a quei tempi, gli si riconosceva una discreta qualità enologica. Ricerche condotte sul DNA della Freisa, hanno rilevato una certa parentela con il Nebbiolo e oggi se ne distinguono due cloni principali: Freisa Piccola - maggiormente diffusa e significativa - e Freisa Grossa. I vini prodotti con Freisa si caratterizzano per la buona astringenza prodotta dai tannini e la piacevole freschezza, non eccessivamente ricchi nel colore e con evidenti sfumature violacee. Il buon contenuto di polifenoli si adatta, in alcuni casi, con la vinificazione in legno, tuttavia si deve notare che la Freisa è maggiormente vinificata in contenitori inerti, spesso nello stile frizzante e, talvolta, con un apprezzabile residuo zuccherino.
|
||||
|
Il Raboso - più correttamente definito come Raboso Piave - è principalmente coltivato in provincia di Padova, nello specifico nell'area che si sviluppa lungo il corso del fiume Piave. La varietà si deve distinguere dal Raboso Veronese - anch'esso presente in questo territorio - il quale non ha legame genetico con il Raboso Piave e si tratta, di fatto, di una varietà distinta, nonostante le evidenti similitudini. Le origini del Raboso sono ancora oggi incerte, compreso il suo nome. Per alcuni deriverebbe dal nome dell'omonimo torrente, un affluente del fiume Piave, per altri deriva dal termine dialettale rabioso (cioè “rabbioso”) a causa dell'evidente acidità e astringenza dei suoi vini. Le sue caratteristiche organolettiche hanno infatti influito enormemente sulla diffusione del Raboso, utilizzato molto spesso come uva da taglio e raramente per vini in purezza, ritenuti troppo rustici e irruenti. Il Raboso - noto anche come Friularo e Rabosa Friulara - sarebbe stato introdotto nel territorio del Piave nel 1300 e, nel 1600, la sua presenza si registrava fino al territorio dell'Istria. Si suppone infatti che il Raboso sia arrivato nel territorio del Piave passando per il Friuli - da cui il nome Friularo - tuttavia si ritiene che la vatietà sia originaria della Germania. Nella Renania, infatti, ancora oggi sono presenti varietà a bacca rossa che presentano significativi legami con il Raboso Piave. I vini prodotti con questa varietà offrono ai sensi del degustatore una spiccata acidità unita a notevole astringenza, condizioni che impongono l'adozione di opportune pratiche di vinificazione. Oggi, grazie a una migliore consapevolezza delle qualità del Raboso, unitamente all'adozione di specifiche pratiche di maturazione, i vini da quest'uva risultano decisamente più equilibrati e apprezzati. In particolare, l'uso del tempo e la maturazione in legno, conferiscono ai vini Raboso la morbidezza necessaria a mitigare le sue “asperità”.
|
Rispetto alle precedenti degustazioni per contrasto, questo mese metteremo a confronto due vini prodotti con tecniche enologiche diverse. La ragione è dovuta al fatto che il Raboso, a causa della sua irruente acidità e astringenza, è generalmente maturato in legno, procedura che altera alcune qualità organolettiche. A onore del vero, il Raboso è vinificato anche in contenitori inerti - solitamente in vasche d'acciaio - tecnica utilizzata quando il produttore decide di produrre lo stile frizzante. Anche la Freisa è sovente vinificata nello stile frizzante, in entrambi in casi non adatto per la nostra degustazione. Sceglieremo infatti una Freisa d'Asti vinificata in contenitori inerti e nello stile fermo, preferibilmente di due anni. Per il Raboso, la scelta sarà per una bottiglia della DOC Piave, maturato in botte, preferibilmente con due anni di maturazione. I vini sono versati nei rispettivi calici da degustazione e serviti alla temperatura di 18 °C. Versiamo nei calici la Freisa e il Raboso e iniziamo la nostra degustazione per contrasto. Il primo vino del quale valuteremo l'aspetto è la Freisa d'Asti. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca e osserviamo la base del calice: il colore della Freisa è rosso rubino brillante con una trasparenza moderata. Osserviamo ora l'estremità del vino verso l'apertura del calice così da valutare la sfumatura: si noterà - netta e intensa - una tonalità rosso rubino con un'evidente tendenza al porpora. Passiamo ora al calice del Piave Raboso, mantenendolo sempre inclinato sopra una superficie bianca. Alla base del calice si rileva un colore rosso rubino intenso, spesso cupo, con una trasparenza decisamente inferiore rispetto alla Freisa. La sfumatura del Raboso - osservata all'estremità della massa liquida, verso l'apertura del calice - conferma la tonalità rosso rubino. Si confrontino ora i due calici mettendoli uno a fianco dell'altro: le differenze nel colore, trasparenza e sfumatura sono evidenti. Freisa e Raboso sono caratterizzati da profili olfattivi che presentano sostanziali differenze. In entrambi i casi, le sensazioni principali richiamano frutti rossi e neri così come fiori. I profumi della Freisa sono più orientati verso i frutti rossi, in particolare la ciliegia - che spesso diviene amarena - lampone e fragola, ai quali si uniscono mirtillo, mora e prugna. Fra i profumi di fiori che si riconoscono nella Freisa troviamo la violetta, rosa e ciclamino. Il Raboso si orienta più verso i frutti a bacca nera, nello specifico amarena, prugna e mora, sovente accompagnati da mirtillo. I fiori che si possono riconoscere nel Raboso sono principalmente violetta e rosa. Sia la Freisa sia il Raboso possono essere vinificati in contenitori di legno - una pratica utilizzata più frequentemente con il Raboso - conferendo ai vini sensazioni complesse che a volte esaltano le qualità dei vini. Va detto che, quando i produttori utilizzano il legno con la Freisa, tendono a non eccedere con le qualità terziarie proprio per favorire la tipica espressione fresca di questa varietà. Procediamo con la valutazione del profilo olfattivo della Freisa d'Asti e del Piave Raboso, iniziando dal vino piemontese. Manteniamo il calice in posizione verticale e, senza rotearlo, procediamo con la prima olfazione che consente di valutare l'apertura olfattiva del vino. Dal calice emergono profumi netti, intensi e puliti di ciliegia, prugna e lampone, con un orientamento decisamente fresco. Roteiamo ora il calice così da favorire lo sviluppo dei profumi della Freisa e procediamo con la seconda olfazione. Dal calice si percepiscono profumi di fragola, violetta, ciclamino, mirtillo e - talvolta - la rosa. Passiamo ora al calice del Piave Raboso. L'apertura del vino veneto è caratterizzata da un profilo decisamente più “robusto” nel quale si riconoscono amarena, prugna e mirtillo. Dopo avere roteato il calice, procediamo alla seconda olfazione, facendo attenzione a discriminare i profumi terziari derivanti dalla maturazione in legno. Il profilo del Raboso si completa con mora e violetta, ai quali può seguire - in alcuni casi - il profumo della rosa. La fase gustativa delle nostra degustazione metterà maggiormente in evidenza le notevoli differenze fra Freisa e Raboso. Come nelle fasi precedenti, il primo vino che prenderemo in esame è la Freisa d'Asti. L'attacco di questo vino - cioè le sensazioni che si percepiscono in bocca al primo sorso - rivelano una moderata astringenza e una piacevole freschezza conferita dall'acidità. In bocca si percepiscono - netti - i sapori di ciliegia, lampone, prugna e fragola, oltre a una buona struttura. Procediamo con la valutazione dell'attacco del Piave Raboso e prendiamo un sorso di questo vino. Si percepiscono immediatamente le differenze con la Freisa: nel vino veneto la sensazione di astringenza e di acidità sono decisamente più intensi e dominanti. La morbidezza che si percepisce è, in buona misura, conferita dalla maturazione in legno, con una struttura maggiore rispetto alla Freisa. In bocca si percepiscono piacevoli sapori di amarena, prugna, mirtillo e mora, confermando la buona corrispondenza con il naso. L'ultima fase della nostra degustazione per contrasto si concentra sulle sensazioni finali lasciate in bocca dai due vini dopo la deglutizione. Il finale della Freisa d'Asti è di buona persistenza, lasciando in bocca piacevoli sapori di ciliegia, lampone, prugna e fragola, unitamente a una bella sensazione di freschezza. Il finale del Piave Raboso si fa notare per la buona persistenza, nella quale spiccano - in buona evidenza - l'astringenza e la freschezza conferita dall'acidità. In bocca si continuano a percepire piacevoli sapori di amarena, prugna, mirtillo e mora che si uniscono alla garbata morbidezza conferita dall'alcol e dalla maturazione in legno. Si confrontino ora le differenze del finale dei due vini: la struttura del Raboso è decisamente più robusta rispetto alla Freisa così come la sensazione di freschezza prodotta dall'acidità.
|
||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |
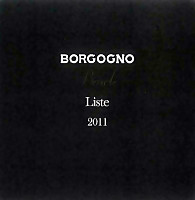
|
|
Barolo Liste 2011 |
|
| Borgogno (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo Nebbiolo | |
| Prezzo: € 40,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola,
melagrana, mirtillo, ciclamino, tabacco, vaniglia, carruba e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola,
melagrana, mirtillo, ciclamino, tabacco, vaniglia, carruba e mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Almeno 3 anni in botte. Almeno 3 anni in botte. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
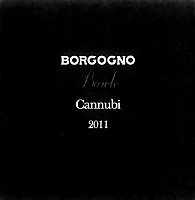
|
|
Barolo Cannubi 2011 |
|
| Borgogno (Piemonte, Italia) | |
 Nebbiolo Nebbiolo | |
| Prezzo: € 55,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola,
vaniglia, mirtillo, cioccolato, cuoio, liquirizia, macis, cannella e
mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola,
vaniglia, mirtillo, cioccolato, cuoio, liquirizia, macis, cannella e
mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole freschezza. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole freschezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e
lampone.
 4 anni in botte. 4 anni in botte. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati |
|
|
|
|
Il Padrone delle Vigne Bianco 2015 |
|
| Tabarrini (Umbria, Italia) | |
 Trebbiano Spoletino Trebbiano Spoletino | |
| Prezzo: € 10,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, melone e
susina seguite da aromi di biancospino, pesca, agrumi, pera e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, melone e
susina seguite da aromi di biancospino, pesca, agrumi, pera e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di melone, pesca e susina. Finale persistente con ricordi di melone, pesca e susina. Almeno 6 mesi in vasche d'acciaio. Almeno 6 mesi in vasche d'acciaio. |
|
 Pasta con pesce, Carne bianca stufata, Paste ripiene, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi Pasta con pesce, Carne bianca stufata, Paste ripiene, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi |
|
|
|
|
Il Padrone delle Vigne 2015 |
|
| Tabarrini (Umbria, Italia) | |
 Sangiovese (80%), Sagrantino (10%), Barbera (10%) Sangiovese (80%), Sagrantino (10%), Barbera (10%) | |
| Prezzo: € 12,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e mirtillo seguite da aromi di melagrana, violetta, geranio, carruba
e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e mirtillo seguite da aromi di melagrana, violetta, geranio, carruba
e vaniglia.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e melagrana. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e melagrana. 1 mese in botte, 3 mesi in vasche d'acciaio. 1 mese in botte, 3 mesi in vasche d'acciaio. |
|
 Pasta con carne, Carne saltata con funghi, Carne alla griglia Pasta con carne, Carne saltata con funghi, Carne alla griglia |
|
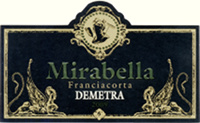
|
|
Franciacorta Extra Brut Demetra 2009 |
|
| Mirabella (Lombardia, Italia) | |
 Chardonnay (70%), Pinot Nero (20%), Pinot Bianco (10%) Chardonnay (70%), Pinot Nero (20%), Pinot Bianco (10%) | |
| Prezzo: € 24,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, perlage fine
e persistente, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, perlage fine
e persistente, molto trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, agrumi e crosta di pane seguite da aromi di mela, acacia, pralina,
burro, lievito, nocciola, pompelmo, kiwi, miele, susina e un accenno di
vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, agrumi e crosta di pane seguite da aromi di mela, acacia, pralina,
burro, lievito, nocciola, pompelmo, kiwi, miele, susina e un accenno di
vaniglia.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo. Una parte dello Chardonnay fermenta in barrique. Rifermentazione in
bottiglia sui propri lieviti per almeno 55 mesi. Una parte dello Chardonnay fermenta in barrique. Rifermentazione in
bottiglia sui propri lieviti per almeno 55 mesi.
|
|
 Pasta con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto Pasta con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto |
|
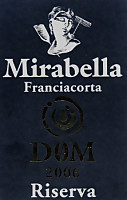
|
|
Franciacorta Dosaggio Zero Riserva D0M 2006 |
|
| Mirabella (Lombardia, Italia) | |
 Chardonnay (60%), Pinot Nero (25%), Pinot Bianco (15%) Chardonnay (60%), Pinot Nero (25%), Pinot Bianco (15%) | |
| Prezzo: € 39,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, perlage fine
e persistente, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, perlage fine
e persistente, molto trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, mela e pralina seguite da aromi di pera, crosta di pane, brioche,
burro, nocciola, pompelmo, biancospino, lievito, acacia, kiwi, miele e
vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, mela e pralina seguite da aromi di pera, crosta di pane, brioche,
burro, nocciola, pompelmo, biancospino, lievito, acacia, kiwi, miele e
vaniglia.
 Attacco fresco ed effervescente, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco ed effervescente, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pera. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pera. Una parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in
bottiglia sui propri lieviti per almeno 70 mesi. Una parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in
bottiglia sui propri lieviti per almeno 70 mesi.
|
|
 Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Pesce stufato con funghi Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Pesce stufato con funghi |
|
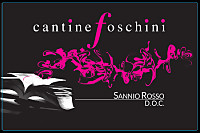
|
|
Sannio Rosso 2015 |
|
| Cantine Foschini (Campania, Italia) | |
 Piedirosso (80%), Sangiovese (20%) Piedirosso (80%), Sangiovese (20%) | |
| Prezzo: € 6,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza
trasparente.
 Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, prugna e lampone
seguite da aromi di violetta, mirtillo, ciclamino e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, prugna e lampone
seguite da aromi di violetta, mirtillo, ciclamino e un accenno di vaniglia.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale abbastanza persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Finale abbastanza persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Maturato in botte. Maturato in botte. |
|
 Pasta con carne, Carne saltata con funghi, Affettati Pasta con carne, Carne saltata con funghi, Affettati |
|
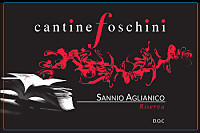
|
|
Sannio Aglianico Riserva 2013 |
|
| Cantine Foschini (Campania, Italia) | |
 Aglianico Aglianico | |
| Prezzo: € 7,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, vaniglia,
cioccolato e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena,
prugna e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, vaniglia,
cioccolato e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. 22 mesi in barrique, 12 mesi in vasche d'acciaio. 22 mesi in barrique, 12 mesi in vasche d'acciaio. |
|
 Paste ripiene con funghi, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi Paste ripiene con funghi, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi |
|

|
|
L'Autentica 2014 |
|
| Cantine del Notaio (Basilicata, Italia) | |
 Moscato Bianco (70%), Malvasia Bianca (30%) Moscato Bianco (70%), Malvasia Bianca (30%) | |
| Prezzo: € 29,00 - 50cl | Punteggio: |
 Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva
passa, albicocca secca e miele seguite da aromi di confettura di mele
cotogne, dattero, confettura di pesche, canditi, litchi, lavanda, scorza di
agrume, fico secco, vaniglia e smalto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva
passa, albicocca secca e miele seguite da aromi di confettura di mele
cotogne, dattero, confettura di pesche, canditi, litchi, lavanda, scorza di
agrume, fico secco, vaniglia e smalto.
 Attacco dolce e piacevolmente fresco, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce e piacevolmente fresco, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca
secca, litchi e dattero. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca
secca, litchi e dattero.
 12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. 12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. |
|
 Formaggi stagionati e piccanti, Crostate di frutta, Pasticceria secca Formaggi stagionati e piccanti, Crostate di frutta, Pasticceria secca |
|
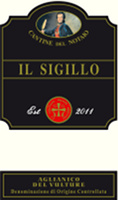
|
|
Aglianico del Vulture Il Sigillo 2011 |
|
| Cantine del Notaio (Basilicata, Italia) | |
 Aglianico Aglianico | |
| Prezzo: € 38,00 | Punteggio: |
 Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
vaniglia, pepe rosa, ribes, cacao, macis, cannella, cuoio, tabacco e
mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
amarena, prugna e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
vaniglia, pepe rosa, ribes, cacao, macis, cannella, cuoio, tabacco e
mentolo.
 Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mora. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mora. 24 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati |
|
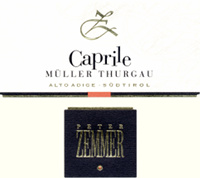
|
|
Alto Adige Müller Thurgau Caprile 2016 |
|
| Peter Zemmer (Alto Adige, Italia) | |
 Müller Thurgau Müller Thurgau | |
| Prezzo: € 10,40 | Punteggio: |
 Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina,
pesca e sambuco seguite da aromi di pera, banana, mela, ortica e ginestra. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina,
pesca e sambuco seguite da aromi di pera, banana, mela, ortica e ginestra.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e pera. Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e pera. Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Latticini Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Latticini |
|
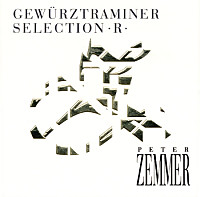
|
|
Alto Adige Gewürztraminer Selection R 2016 |
|
| Peter Zemmer (Alto Adige, Italia) | |
 Gewürztraminer Gewürztraminer | |
| Prezzo: € 18,10 | Punteggio: |
 Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
uva, pesca e litchi seguite da aromi di albicocca, mango, frutto della
passione, rosa bianca, luppolo, banana, pera, garofano, mela e ananas. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
uva, pesca e litchi seguite da aromi di albicocca, mango, frutto della
passione, rosa bianca, luppolo, banana, pera, garofano, mela e ananas.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di uva, litchi, mango e frutto della
passione. Finale persistente con ricordi di uva, litchi, mango e frutto della
passione.
 Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Pasta con crostacei e funghi, Crostacei e pesce alla griglia, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto Pasta con crostacei e funghi, Crostacei e pesce alla griglia, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto |
|
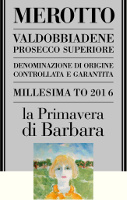
|
|
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry La Primavera di Barbara 2016 |
|
| Merotto (Veneto, Italia) | |
 Glera (90%), Perera (10%) Glera (90%), Perera (10%) | |
| Prezzo: € 14,00 | Punteggio: |
 Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
glicine seguite da aromi di pera, ananas, mandarino, biancospino, ginestra
e susina. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e
glicine seguite da aromi di pera, ananas, mandarino, biancospino, ginestra
e susina.
 Attacco effervescente e piacevolmente dolce, comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco effervescente e piacevolmente dolce, comunque equilibrato
dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca. Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca. Rifermentato in autoclave. Rifermentato in autoclave. |
|
 Risotto con crostacei, Crostacei saltati, Flan di verdure, Latticini Risotto con crostacei, Crostacei saltati, Flan di verdure, Latticini |
|

|
|
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2016 |
|
| Merotto (Veneto, Italia) | |
 Glera Glera | |
| Prezzo: € 18,00 | Punteggio: |
 Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, perlage fine e
persistente, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, perlage fine e
persistente, molto trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e
glicine seguite da aromi di mela, ananas, biancospino, mandarino,
gelsomino, ginestra e susina. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e
glicine seguite da aromi di mela, ananas, biancospino, mandarino,
gelsomino, ginestra e susina.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole dolcezza. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole dolcezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Fermentazione in autoclave per 50 giorni. Fermentazione in autoclave per 50 giorni. |
|
 Aperitivo, Antipasti di crostacei, Crostacei saltati, Risotto con verdure Aperitivo, Antipasti di crostacei, Crostacei saltati, Risotto con verdure |
|
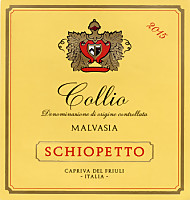
|
|
Collio Malvasia 2015 |
|
| Schiopetto (Friuli Venezia Giulia, Italia) | |
 Malvasia Istriana Malvasia Istriana | |
| Prezzo: € 11,00 | Punteggio: |
 Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e
pesca seguite da aromi di susina, ananas, biancospino, litchi, ginestra e
mandorla. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e
pesca seguite da aromi di susina, ananas, biancospino, litchi, ginestra e
mandorla.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di pesca, mela e mandorla. Finale persistente con ricordi di pesca, mela e mandorla. 8 mesi in vasche d'acciaio, 5 mesi in bottiglia. 8 mesi in vasche d'acciaio, 5 mesi in bottiglia. |
|
 Antipasti di pesce, Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato Antipasti di pesce, Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato |
|
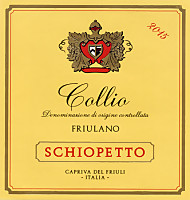
|
|
Collio Friulano 2015 |
|
| Schiopetto (Friuli Venezia Giulia, Italia) | |
 Friulano Friulano | |
| Prezzo: € 11,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e
biancospino seguite da aromi di pesca, mandorla, agrumi, susina, ginestra e
minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e
biancospino seguite da aromi di pesca, mandorla, agrumi, susina, ginestra e
minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina. Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina. 8 mesi in vasche d'acciaio. 8 mesi in vasche d'acciaio. |
|
 Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi |
|
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
Al Via la Campagna di Comunicazione Albeisa B.O.C.G. |
||||
Giocando sull'acronimo B.O.C.G. (Bottiglia di Origine Controllata e Garantita), gli assi portanti della campagna saranno appunto il rispetto del territorio, la qualità e la garanzia del prodotto. L'obiettivo è far sì che il consumatore associ sempre più automaticamente la bottiglia Albeisa al territorio delle Langhe, dando vita a un inscindibile trait d'union tra i vini e il luogo da cui prendono vita. Si svilupperà attraverso l'aspetto digital su sito e social network, oltre a una nuova campagna adv e di sensibilizzazione verso il consumatore in primis ma anche verso i giornalisti, gli operatori e gli opinion leader sia in Italia che all'estero. Si rivolgerà infatti a un pubblico sempre più attento e giovane. Come rilevato da uno studio condotto da Nomisma Wine Monitor e presentato a Bologna lo scorso venerdì, per i Millenials il packaging risulta essere oggi uno dei principali driver di scelta nell'acquisto e nel consumo del vino. I dati indicano infatti che il 70% dei Millennials italiani è attratto da bottiglie con design innovativo o particolare. La bottiglia Albeisa nasce sul finire del 1700 per volontà dei produttori dell'albese che desideravano avere una bottiglia unica per i propri vini. Nel 1973 la produzione della bottiglia viene regolamentata tramite un preciso Statuto messo in atto per disciplinare e controllare l'utilizzo del contenitore. Il suo utilizzo è tutelato dall'Associazione Produttori Vini Albesi che ne indica la possibilità di impiego e fornisce un dettaglio sulle varietà e le DOC/DOCG che essa può contenere. |
||||
Certificati Come Biologici Tutti i Vigneti di Proprietà delle Cantine Ferrari |
| Tutti i vigneti trentini di proprietà del Gruppo Lunelli e destinati alla
creazione di Ferrari Trentodoc hanno ottenuto la certificazione biologica: una
notizia attesa, che arriva il 20 marzo, a pochi giorni dal Vinitaly 2017 e
corona l'impegno della famiglia Lunelli nel riportare al centro dell'attività
agricola il concetto stesso di fertilità naturale del terreno, il rispetto
dell'ambiente e di chi vi lavora. Questo traguardo è il punto di arrivo di un percorso lungo e impegnativo, iniziato oltre venti anni fa. Numerosi studi e sperimentazioni in campagna condotti con il supporto della Fondazione Mach, hanno portato alla convinzione che, una volta ottenuto un adeguato equilibrio del vigneto, sia possibile fare viticoltura biologica anche in territori di montagna. Negli anni è stato introdotto il divieto totale di utilizzo di diserbanti e concimi chimici, a favore di pratiche tradizionali come il sovescio, di fertilizzanti naturali come il letame e dell'uso esclusivo di fitofarmaci ad alto grado di sicurezza, che prediligono l'impiego di prodotti naturali quali il rame e lo zolfo. In questo contesto, nel 2014 è iniziato il processo di conversione al biologico di tutti i vigneti di proprietà delle Cantine Ferrari, che è terminato con successo qualche giorno fa. Questa cultura della sostenibilità e del rispetto per il territorio negli anni è stata condivisa anche con le oltre 500 famiglie che conferiscono le proprie uve alle Cantine Ferrari, attraverso un lungo processo di formazione e di educazione da parte del team di agronomi di Casa Ferrari. A tutti i conferenti è stato chiesto di seguire un vero e proprio protocollo di viticoltura di montagna salubre e sostenibile denominato “Il Vigneto Ferrari”, elaborato sempre col sostegno scientifico della Fondazione Edmund Mach e certificato da CSQA. Oltre a garantire una migliore qualità della pianta e dell'uva prodotta, queste iniziative hanno avuto importanti ricadute su tutto il territorio circostante, che oggi beneficia di una più ricca biodiversità, confermata anche dalla certificazione “Biodiversity Friend' da parte della Worldwide Biodiversity Association. Un territorio, quello delle montagne del Trentino, che nei secoli il lavoro dell'uomo ha trasformato, rendendo più dolci i pendii con filari di viti coltivati e mantenuti come giardini. Oggi questi vigneti di montagna, gli unici ad assicurare l'eccellenza della base spumante Trentodoc, sono ancora più in sintonia con la natura, grazie all'importante traguardo raggiunto dalle Cantine Ferrari, che dimostrano di conservare lo spirito pioneristico del loro fondatore. Fu proprio Giulio Ferrari, infatti, oltre un secolo fa, a individuare le montagne trentine come terreno ideale per la produzione del migliore Chardonnay destinato alla produzione di Metodo Classico. «La certificazione biologica di tutti i vigneti trentini della nostra famiglia rappresenta un grande traguardo che ha ricadute positive su tutto il processo produttivo, e rafforza ulteriormente il nostro impegno in termini di responsabilità sociale verso i territori in cui operiamo» ha commentato Marcello Lunelli, vice presidente delle Cantine Ferrari. |
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
||||||||||||
Wine Guide ParadeFebbraio 2017
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |