
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 117, Aprile 2013 |
Sommario |
|
|
Quello Che Ho Imparato dal Vino |
|
Sono oramai oltre venti anni che mi occupo di vino. Tutto è iniziato come una passione amatoriale, forse alimentata dal fatto di essere cresciuto in una cultura che è fondata sul vino, come la gran parte delle persone che vivono in Italia o nei paesi dove storicamente si produce la bevanda di Bacco. Il mio primo contatto con il vino - del quale ho memoria - non è stato esattamente il vino, ma la magia del luogo dove questo nasce: la vigna. La prima “autorità” del vino che ho conosciuto è stato mio nonno, fra l'altro, abilissimo e apprezzatissimo innestatore di piante e alberi. Come accadeva in passato, qualcosa che rappresentava un fatto assolutamente normale e indispensabile per chiunque avesse della terra, mio nonno produceva vino. La sua era una produzione per puro consumo personale, come per la maggioranza di quelli che producevano vino. Mio nonno era molto orgoglioso del vino che produceva dalla sua vigna, così come era orgoglioso della sua vigna che curava pressoché quotidianamente. I primi ricordi che ho della vigna, della vigna di mio nonno, sono due momenti che ricordo ancora con vera emozione: la vendemmia e il giorno che mi portò con sé in vigna ad aiutarlo. La vendemmia era una vera festa, soprattutto per noi bambini - ed eravamo tanti - che vedevamo in quell'occasione un'opportunità di stare insieme, prima facendo finta di aiutare i grandi a vendemmiare l'uva, poi a ritrovarsi, dopo un'ora circa, tutti insieme a giocare e a combinare qualche marachella. Era una festa, una festa vera che iniziava la mattina presto e finiva la sera, tutti insieme a raccogliere uva e a fare il vino. Il tutto sotto la rigorosa supervisione di mio nonno che seguiva con scrupolo tutte le fasi della giornata, da come si raccoglieva l'uva a come veniva portata in cantina, fino al momento che il mosto veniva travasato nella botte. Era molto orgoglioso della sua vigna e del vino che sarebbe nato qualche mese dopo: nonostante producesse vino per il puro piacere di bere il proprio vino e di offrirlo agli amici e parenti, era comunque molto esigente in vigna e in cantina. Il secondo ricordo, quando mio nonno mi portò in vigna ad aiutarlo a sostituire una vecchia vite che era morta. Non ricordo esattamente quanti anni avessi, ma di certo non più di sette. Scavammo una fossa e interrammo un tralcio della vite accanto - usando la tecnica della margotta - e, con mio stupore, mi spiegò che in quel modo una vite poteva replicare sé stessa dando vita a una nuova pianta. Quel vigneto è passato poi a suo figlio - mio zio - e oggi, anche nel rispetto di due vite che si sono dedicate con passione a quella vigna, a quella terra, a quelle viti e al loro vino, continua la sua storia attraverso il lavoro dei miei cugini e mio. Cerchiamo, per quel che possiamo, di curare quella vigna e continuare a fare vino, sempre per uso assolutamente personale. Ritengo l'esperienza di camminare nella vigna che fu di nostro nonno e poi fare vino, sia per me, che scrivo di vino e li assaggio quotidianamente, un'opportunità immensa per comprendere meglio il nettare di Bacco. La vigna e la cantina sono una grande scuola di vita, entrambe ti educano all'ascolto e, più importante, al rispetto. Soprattutto capisci quanto sia faticoso, ma certamente nobile, allevare la vite e fare vino: una scommessa fatta di rischi, continue preoccupazioni nel guardare il cielo, la terra e la vite, gesti che si ripetono, sempre rinnovati e nuovi, ogni anno. E ogni anno è una magia e una meraviglia che si ripetono. Non è mia intenzione, ovviamente, celebrare il mio diletto per la vigna e la cantina - direi nostro, visto che il vino lo faccio insieme ai miei cugini - soprattutto per la consapevolezza di produrre vini di livello amatoriale e per uso strettamente personale e da condividere con gli amici. Ritengo tuttavia che comprendere come si fa il vino e cosa accade in vigna - anche in un contesto casalingo e amatoriale - rappresenti per me un'enorme opportunità per capire meglio il lavoro che faccio, quello che scrivo sul vino e sui vini. Poi l'ascolto. Ascoltare non solo le bottiglie - tutte - e quello che si versa nel calice, ma ascoltare anche chi ha prodotto il nettare che riempe di emozioni - belle e brutte - il calice. Ognuno è capace di raccontare storie affascinanti, nel bene e nel male, e quello che ho capito è che il vino riflette perfettamente la personalità di chi lo produce. Persone appassionate, producono vini di altrettanta passione; persone poco sincere e poco oneste, trasmettono ai loro vini le medesime qualità, rendendo i loro vini privi di anima, spogliati di qualunque personalità sincera. Non si tratta, evidentemente, di magnificare uno stile enologico rispetto ad altri: grazie al vino ho anche capito che le persone capaci di produrre vini di qualità e ricchi di emozioni, non hanno affatto bisogno di nascondere la propria mediocrità dietro un'etichetta, dietro vuote parole o religioni di comodo. Dal vino ho anche imparato che la tanto odiata tecnologia - ma che ha permesso a tutti di migliorare i propri vini, comprendendo meglio i processi enologici - non è affatto cattiva. Quello che è cattivo è l'uso, o l'abuso, che se ne fa, qualcosa che riguarda unicamente l'onestà e la moralità del produttore. Un produttore in malafede o disonesto, non fa nessuna differenza ai miei occhi: le etichette e le farse patetiche a supporto dei suoi vini non fanno altro che peggiorare la situazione, indipendentemente dal “credo” enologico al quale si affida. Dal vino ho capito che, esattamente come le persone, gli animali e le piante, ognuno di loro, ogni bottiglia, ogni calice, ha una storia irripetibile da raccontare e che merita sempre di essere ascoltata, anche quando non si riesce a comprenderla o a condividerla. Un atteggiamento che ho imparato, prima che dal vino, dal tè, straordinaria bevanda alla quale ho dedicato decenni della mia vita - passione ancora oggi immutata - sia come oggetto di studio, sia come Maestro di vita. Di certo anche il vino è mio Maestro di vita: da lui ho imparato quello che il tè non potrebbe mai insegnare, e di certo dal tè ho imparato quello che il vino non può insegnare. Dal vino ho anche imparato che ogni calice, ogni sorso, è capace di ricordarti, in un attimo, che il cammino della comprensione della bevanda di Bacco è pressoché infinito. Ogni sorso aggiunge sempre qualcosa di nuovo alla propria conoscenza, rendendo consapevoli - nel contempo - che anche alla propria ignoranza si aggiunge un nuovo e inquietante vuoto da colmare, che porterà ad altri infiniti e inevitabili vuoti da colmare. Oggi, benché abbia assaggiato la modesta quantità di circa 15.000 vini - oltre un quarto di questi sono parte della Guida dei Vini di DiWineTaste - ho la consapevolezza che c'è ancora molto da imparare, molto ancora da capire e vivere. Dal vino ho anche imparato che il rispetto viene prima di tutto. Rispetto per chi produce vino, con la propria fatica e la propria passione, rispetto che viene prima del loro vino, anche quando non lo si capisce. Questo va sempre ricordato quando se ne parla e quando si scrive di vino. In questo senso, ho anche capito che c'è gente che usa il vino per autocelebrarsi e per credersi sopra tutto e sopra tutti: il vino mi ha insegnato anche ad avere compassione della pochezza di questi vacui soggetti. Il vino mi ha anche insegnato che va condiviso, come alto e nobile atto, perché le belle storie, i momenti piacevoli, restano vuoti e inutili quando non sono condivise. Ho la fiducia e la consapevolezza che il vino mi insegnerà ancora molto. Antonello Biancalana
|
||||
Tecnica Enologica e DegustazioneLa tecnologia, applicazione di una tecnica e di un metodo, consente di ottenere vini di maggiore qualità enologica, influendo inevitabilmente anche sulle caratteristiche sensoriali |
|
La tecnica e la tecnologia in vigna e in cantina sono argomenti che da tempo - da alcune decine di anni, forse da sempre - accendono gli animi degli appassionati di vino e dei produttori. Per alcuni la tecnica e la tecnologia sono considerate come la negazione assoluta del vino e della sua capacità di espressione, spesso associata, con disprezzo, al concetto di sofisticazione e alla peggiore industrializzazione del vino. Altri invece considerano la tecnologia in modo più pragmatico, riconoscendo a questa il fondamento della conoscenza e del progresso enologico, una via scientifica e ragionata per migliorare la qualità di un vino limitando, o eliminando completamente, i rischi della formazione di difetti e fattori negativi. Qualunque metodo o principio applicato all'opera dell'uomo può definirsi tecnica, anche in quei contesti dove questo termine è ampiamente criticato. Dal punto di vista etimologico, la parola “tecnica” ha un'origine decisamente nobile. Deriva dal greco téchne con il significato di arte, inteso come capacità dell'uomo di sapere fare attraverso l'applicazione e l'uso consapevole di norme che consentono la realizzazione di un'attività, sia di tipo pratico e manuale, sia di tipo intellettuale. In altre parole, definisce la capacità e l'espressività del talento dell'uomo in tutti gli ambiti nei quali interagisce, natura compresa, vino compreso. Anche la parola tecnologia deriva dal greco e precisamente della parola téchne alla quale si aggiunge logos, che significa discorso, pertanto il suo significato compiuto è “esposizione tematica di un'arte”. La tecnologia, nel senso più ampio, è la definizione dell'insieme di regole e metodi che costituiscono scientificamente e artisticamente una materia, consentendone non solo la comprensione ma anche la consapevole attuazione e applicazione. Il 1900 è stato senza ombra di dubbio il secolo che ha maggiormente contribuito alla tecnologia enologica. Grazie infatti all'impiego di tecniche e conoscenze, che il progresso e la scienza rendevano disponibili anche in altri ambiti, si sono compresi in modo scientifico e metodico i fenomeni che consentono la produzione di vino e le loro interazioni. Questo straordinario cammino inizia poco dopo la metà del 1800, quando il grande scienziato francese Louis Pasteur - fra il 1861 e il 1862 - spiega per la prima volta e in modo scientifico, il processo della fermentazione alcolica identificando l'attività dei lieviti. I suoi fondamentali studi sulla microbiologia hanno anche consentito di comprendere le ragioni e i rimedi per molti dei difetti che si riscontravano nel vino. Per onore di completezza, va ricordato anche il grande contributo di Louis Pasteur nella produzione della birra, i quali studi e l'applicazione delle medesime scoperte, gli hanno consentito di spiegare i fenomeni chimici, fisici e biologici della produzione del vino. Prima delle scoperte di Louis Pasteur, la produzione di vino era prevalentemente fatta dell'applicazione di metodi empirici e tradizionalmente affidabili dal punto di vista enologico, frutto di esperienze e osservazioni del passato. Questi metodi erano infatti applicati in funzione della loro “storica” e comprovata efficacia, tuttavia non si conoscevano, o non erano completamente compresi, i principi che ne determinavano l'efficacia nel vino. Basti pensare, ad esempio, alla parola “fermentazione”, che deriva dal latino fervere, con il significato di “bollire”, pertanto, in tempi passati, la “fermentazione” era considerata una sorta di “ebollizione”. La ragione deriva dall'osservazione del mosto in fermentazione che ricorda il tumulto dell'acqua in ebollizione, ulteriormente rafforzato dal fatto che durante questo processo il mosto si scalda. Oggi sappiamo, anche grazie a Louis Pasteur, che il mosto non bolle affatto e che il tumulto non è altro che il risultato dell'attività biologica dei lieviti. Ancora oggi la fermentazione alcolica del mosto è talvolta indicata con il termine “ebollizione”, più precisamente, si dice che il “mosto bolle”.
Il vino è innegabilmente il prodotto della tecnica, espressione del talento e dell'arte dell'uomo con la fondamentale e insostituibile collaborazione della Natura e dell'ambiente. Senza la tecnica, senza la conoscenza dei metodi enologici e viticolturali, di qualunque natura e forma, non esisterebbe né il vino né qualunque altra espressione dell'ingegno dell'uomo. Anche i gesti romantici e tradizionali, che vogliono ricondursi a pratiche naturali, sono il frutto della tecnica e della sua applicazione. Ogni qualvolta l'uomo interagisce con i processi naturali, dalla vigna alla bottiglia, non fa altro che attuare un metodo e una tecnica, scientifica o empirica, non fa differenza. Il fattore discriminante, va da sé, è il modo con il quale si usa la tecnica, il confine fra il ragionevole e irrinunciabile uso oppure l'abuso. Un concetto che vale per ogni cosa senza eccezione: sono l'uso e l'abuso a rappresentare la bontà, l'onestà e la correttezza delle cose, dei pensieri, dei comportamenti. Ricordando, in ogni caso, che il vino non esiste in natura e che è il risultato del fondamentale intervento dell'uomo, interagendo con la Natura e il territorio, qualunque tecnica impiegata per la produzione del nettare di Bacco influisce nel profilo organolettico del vino. Dall'aspetto del vino fino alle sensazioni che si continuano a percepire in bocca dopo la deglutizione, la misura e la modalità di intervento tecnico da parte dell'uomo hanno la capacità di plasmare ogni singolo aspetto sensoriale del vino. Come si coltiva la vigna, come si pota la vite, gli interventi in vigna, come e quando si vendemmia dell'uva, come si pigia l'uva e si fermenta il mosto, come si travasa e si imbottiglia, come si serve il vino, sono tutti esempi dell'uso di tecniche che inevitabilmente influiscono sulle qualità organolettiche del vino e come queste sono percepite dagli organi di senso. Si potrebbe erroneamente credere che il vino è puramente tecnica e questo sarebbe del tutto errato. Il vino non è solo tecnica: è soprattutto il risultato della sensibilità, moralità, onestà, cultura e correttezza del produttore e di come e quanto usa ogni singola tecnica nel rispetto della Natura, la vigna e l'ambiente. La tecnica è lo strumento con il quale l'uomo interagisce con i processi di coltivazione della vite e della produzione del vino. La tecnica, infatti, fornisce gli strumenti essenziali che consentono di prevenire le malattie della vite e la formazione o la cura di difetti nel vino. La natura, certamente, svolge un ruolo insostituibile e irripetibile, ma è la tecnica che consente di rivelarla e di farla esprimere nel vino. Ogni tecnica, infatti, ha il potere di plasmare il vino verso un determinato stile di espressione e, nonostante molte di queste siano necessarie alla sua stabilizzazione, finiscono inevitabilmente a modificare il profilo organolettico. Definire il confine fra l'uso e l'abuso della tecnica e della tecnologia è estremamente difficile e inutile, poiché questo è strettamente legato alla filosofia e al credo dei produttori e dei consumatori. A titolo di esempio, l'uso dei cosiddetti lieviti selezionati è considerato da alcuni come pratica sana per il vino di qualità, per altri è visto, non solo come l'esatto contrario, ma anche come segno di sofisticazione e omologazione. I lieviti, non c'è dubbio, contribuiscono in modo sostanziale alle caratteristiche organolettiche del vino e, indipendentemente dal fatto che siano usati quelli selezionati o quelli presenti naturalmente nella buccia dell'uva, la loro attività è fortemente condizionata da fattori tecnici che si verificano in cantina. Com'è noto, il Saccharomyces Cerevisiae è la specie di lievito maggiormente responsabile della fermentazione alcolica del vino. Non è l'unica specie, ovviamente, ma è quella che si cerca di favorire durante la fermentazione alcolica. Il risultato della fermentazione è opera di diverse specie, soprattutto nel caso si decida di non usare i lieviti selezionati che sono costituiti esclusivamente dal Saccharomyces Cerevisiae. Questa specie di lievito è naturalmente presente nella buccia dell'uva, ma anche nell'aria, esattamente come qualunque altra specie di lievito. Uno dei fattori tecnici che determina l'attività dei lieviti, di qualunque specie, è la temperatura. Il controllo della temperatura, tecnica ampiamente impiegata in enologia, sia dai produttori naturali sia da quelli industriali, ha il potere di alterare fortemente l'attività dei lieviti, operando - di fatto - una selezione, indirizzando il profilo sensoriale verso uno specifico carattere. L'anidride solforosa, ampiamente utilizzata non solo in enologia ma anche nell'industria alimentare, è un altro degli elementi fortemente criticati nel mondo del vino. Premesso che questo elemento chimico è naturalmente prodotto durante la fermentazione alcolica - nella misura variabile da 6 a 40mg per litro, a seconda del tipo di lievito e delle condizioni enologiche - è bene ricordare che l'eccesso può provocare disturbi alla salute. L'anidride solforosa nel vino offre comunque degli innegabili vantaggi, anche dal punto di vista sensoriale. Va infatti ricordato che l'anidride solforosa, oltre a offrire una buona protezione al vino, rendendolo più stabile, nella giusta misura aiuta l'espressione dei profumi del vino. Come già detto, l'eccesso di anidride solforosa, oltre a provocare disturbi alla salute, soprattutto nei soggetti più sensibili, stravolge il vino con un evidente odore di zolfo, distruggendo completamente la qualità olfattiva e gustativa. Sempre ricordando che esiste una differenza innegabilmente sostanziale fra l'uso e l'abuso, fra onestà e disonestà, va ricordato che, a livello tecnico, il vino può essere corretto e, in un certo senso, plasmato a seconda dello stile che si intende ottenere. In cantina, il vino può essere corretto sotto ogni aspetto organolettico, dalla vista al gusto, non esiste aspetto enologico che non si possa correggere. Va detto, per chiarezza, che sebbene in cantina si possono spesso compiere miracoli, è innegabile che da uve di qualità è più semplice ottenere un grande vino: in questo caso l'intervento dell'uomo e della tecnologia può, eventualmente, distruggere e plagiare il grande patrimonio offerto da Madre Natura. Dove l'abuso della tecnologia può soccorrere abilmente, è nel caso di uve di mediocre o pessima qualità: nonostante non sia comunque possibile, in questo caso, ottenere un grande vino, di certo può essere notevolmente migliorato e reso migliore di quanto non potrebbe essere. Acidità e astringenza, per esempio, possono essere corretti in cantina sia nel caso di carenza sia per motivi di eccesso. Non solo, anche la carenza di zucchero nel mosto può essere corretto, sia aggiungendo del mosto concentrato (in certi paesi, ma non in Italia, è consentita anche l'aggiunta di zucchero) sia eliminando l'eccesso, che porterebbe a una produzione eccessiva di alcol. Per chiarezza, va detto che queste correzioni sono ammesse per legge, pertanto - almeno dal punto di vista legale - non si può parlare di sofisticazione, ma di pratiche enologiche correttive. In ogni caso, questo genere di interventi influiscono in modo sostanziale sulle qualità organolettiche del vino, sull'equilibrio e la percettibilità di ogni singolo stimolo. Operando questo tipo di correzioni, è possibile stravolgere completamente la natura e il carattere di un vino. Si potrebbe considerare come una sorta di “trucco” applicato con lo scopo di nascondere delle imperfezioni e delle carenze, spesso frutto di una viticoltura errata o poco rispettosa per la vigna e l'ambiente, o nel caso di annate particolarmente sfavorevoli. Lo stesso principio si applica all'uso della botte e dei contenitori di legno. Precisando che la botte è un prezioso strumento per la produzione di vino, il suo abuso, per meglio dire, il suo uso scorretto, ha la capacità di stravolgere le qualità organolettiche di un vino. Va detto che non tutte le uve, non tutti i territori, sono adatti all'uso della botte o di certi tipi di botte. Innanzitutto, il vino deve essere stato prodotto con lo scopo di sostenere la maturazione in botte, una scelta che è fortemente condizionata dalle pratiche viticolturali e dalle varietà di uva. Il filtraggio - operazione meccanica che consente l'eliminazione di sostanze solide, anche con lo scopo di evitare sedimenti in bottiglia, non sempre graditi dai consumatori - se è vero che restituisce un vino biologicamente più stabile e dall'aspetto impeccabile, può alterare le qualità organolettiche. Il filtraggio, a seconda del suo “rigore” spoglia, di fatto, il vino di sostanze che possono rappresentare un fattore caratterizzante, sia nei profumi, sia nel sapore.
|
||||||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |

|
|
Langhe Rosso 2009 |
|
| Mossio (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Barbera (40%), Nebbiolo (40%), Dolcetto (20%) | |
| Prezzo: € 15,50 | Punteggio: |
| Questo Langhe Rosso si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora, vaniglia, lampone, tabacco, cioccolato, rosa appassita, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Questo Langhe Rosso matura per 12 mesi in botte. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Dolcetto d'Alba Bricco Caramelli 2011 |
|
| Mossio (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Dolcetto | |
| Prezzo: € 11,50 | Punteggio: |
| Dolcetto d'Alba Bricco Caramelli si presenta con un colore rosso rubino cupo e sfumature rosso porpora, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di ciliegia, mora e prugna seguite da aromi di violetta, lampone, fragola, ciclamino, mirtillo, pesca, mandorla, geranio e anice. In bocca ha ottima corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di ciliegia, prugna e mora. Dolcetto d'Alba Bricco Caramelli matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Salumi, Pasta con carne e funghi, Carne bianca arrosto, Carne saltata | |

|
|
Arquata Rosso 2006 |
|
| Adanti (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Cabernet Sauvignon (40%), Merlot (40%), Barbera (20%) | |
| Prezzo: € 13,50 | Punteggio: |
| Arquata Rosso si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, ribes e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, prugna, vaniglia, tabacco, cioccolato, cannella, macis ed eucalipto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna. Arquata Rosso matura in botte e barrique per 24 mesi seguiti da 6 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Sagrantino di Montefalco Il Domenico 2006 |
|
| Adanti (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Sagrantino | |
| Prezzo: € 27,00 | Punteggio: |
| Sagrantino di Montefalco Il Domenico si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, mirtillo, vaniglia, tabacco, cioccolato, macis, cuoio, pepe rosa e mentolo. In bocca ha ottima corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. Sagrantino di Montefalco Il Domenico matura in botte per 30 mesi a cui seguono 24 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |
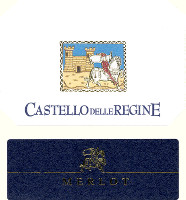
|
|
Merlot 2005 |
|
| Castello delle Regine (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Merlot | |
| Prezzo: € 33,00 | Punteggio: |
| Questo Merlot si presenta con un colore rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di mirtillo, violetta, vaniglia, cioccolato, caffè, tabacco, macis, pepe rosa ed eucalipto. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. Questo Merlot matura in barrique per 12 mesi a cui seguono 24 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati | |

|
|
Selezione del Fondatore 2004 |
|
| Castello delle Regine (Umbria, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese Grosso | |
| Prezzo: € 22,00 | Punteggio: |
| Selezione del Fondatore si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, vaniglia, tabacco, cioccolato, cannella, cuoio, liquirizia, macis e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Selezione del Fondatore matura per 18 mesi in barrique a cui seguono 36 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |
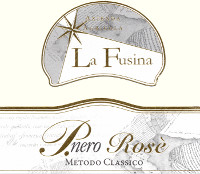
|
|
Metodo Classico P.Nero Rosé Extra Brut 2010 |
|
| La Fusina (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Pinot Nero | |
| Prezzo: € 18,00 | Punteggio: |
| Metodo Classico P.Nero Rosé Extra Brut si presenta con un colore rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage fine e persistente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di mela, lievito, mandarino e ciclamino. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco ed effervescente, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola. Metodo Classico P.Nero Rosé Extra Brut rifermenta in bottiglia sui propri lieviti per oltre 9 mesi. | |
| Abbinamento: Pasta e risotto con funghi e pesce, Carne bianca saltata, Latticini | |
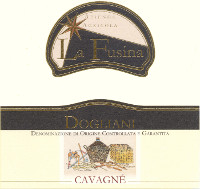
|
|
Dogliani Superiore Cavagné 2010 |
|
| La Fusina (Piemonte, Italia) | |
| Uvaggio: Dolcetto | |
| Prezzo: € 10,00 | Punteggio: |
| Dogliani Superiore Cavagné si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mirtillo, geranio e mora. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Dogliani Superiore Cavagné matura per 12 mesi in vasche d'acciaio a cui seguono 6 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne saltata con funghi, Carne alla griglia | |
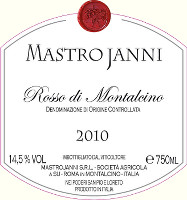
|
|
Rosso di Montalcino 2010 |
|
| Mastrojanni (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese | |
| Prezzo: € 15,00 | Punteggio: |
| Questo Rosso di Montalcino si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, lampone, vaniglia, geranio, carruba e ciclamino. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza e morbidezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Questo Rosso di Montalcino matura in botte per 7 mesi a cui seguono 3 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne alla griglia, Carne arrosto | |
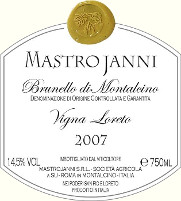
|
|
Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2007 |
|
| Mastrojanni (Toscana, Italia) | |
| Uvaggio: Sangiovese | |
| Prezzo: € 45,00 | Punteggio: |
| Brunello di Montalcino Vigna Loreto si presenta con un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso arancio, abbastanza trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, vaniglia, cacao, liquirizia, macis, cannella, tabacco e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. Brunello di Montalcino Vigna Loreto matura per 36 mesi in botte a cui seguono 8 mesi di affinamento in bottiglia. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati | |

|
|
Lambrusco Brut |
|
| Lusvardi (Emilia Romagna, Italia) | |
| Uvaggio: Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa | |
| Prezzo: € 8,00 | Punteggio: |
| Questo Lambrusco Brut si presenta con un colore un colore rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente, perlage fine e persistente. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di ciliegia, prugna e mirtillo seguite da aromi di lampone, fragola, mora e violetta. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco effervescente e giustamente tannico, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, prugna e mirtillo. Lambrusco Brut fermenta in autoclave. | |
| Abbinamento: Affettati, Pasta e risotto con carne, Carne bianca saltata, Latticini | |

|
|
Lambrusco Grato |
|
| Lusvardi (Emilia Romagna, Italia) | |
| Uvaggio: Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa | |
| Prezzo: € 9,00 | Punteggio: |
| Lambrusco Grato si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente, perlage fine e persistente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di ciliegia, mora e prugna seguite da aromi di lampone, lievito, violetta, rosa e fragola. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico ed effervescente, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, mora e prugna. Lambrusco Grato rifermenta in bottiglia sui propri lieviti e non subisce sboccatura. | |
| Abbinamento: Paste ripiene, Carne saltata, Formaggi | |
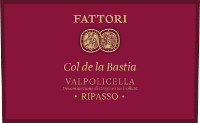
|
|
Valpolicella Ripasso Col de la Bastia 2009 |
|
| Fattori (Veneto, Italia) | |
| Uvaggio: Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%) | |
| Prezzo: € 28,00 | Punteggio: |
| Valpolicella Ripasso Col de la Bastia si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli e raffinati che si aprono con note di amarena, mora e violetta seguite da aromi di mirtillo, prugna, vaniglia, tabacco, cioccolato, macis, cannella e mentolo. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di amarena, mora e prugna. Valpolicella Ripasso Col de la Bastia matura in botte. | |
| Abbinamento: Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Carne alla griglia | |
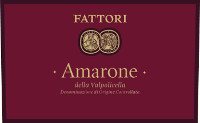
|
|
Amarone della Valpolicella 2007 |
|
| Fattori (Veneto, Italia) | |
| Uvaggio: Corvina (65%), Corvinone (15%), Rondinella (10%), Altre Uve (10%) | |
| Prezzo: € 50,00 | Punteggio: |
| Questo Amarone della Valpolicella si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di mora, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, tabacco, vaniglia, cioccolato, cannella, macis, cuoio e mentolo. In bocca ha ottima corrispondenza con il naso, un attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Il finale è molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena. Questo Amarone della Valpolicella matura per 36 mesi in botte. | |
| Abbinamento: Selvaggina, Brasati e stufati di carne, Carne arrosto, formaggi stagionati | |

|
|
Inzolia 2012 |
|
| Cantine Barbera (Sicilia, Italia) | |
| Uvaggio: Inzolia | |
| Prezzo: € 7,00 | Punteggio: |
| Questa Inzolia si presenta con un colore giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di pera, pesca e ananas seguite da aromi di mela, ginestra e susina. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di mela, pera e pesca. Questa Inzolia matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Pesce fritto, Risotto con pesce, Pesce saltato | |

|
|
La Bambina 2012 |
|
| Cantine Barbera (Sicilia, Italia) | |
| Uvaggio: Nero d'Avola | |
| Prezzo: € 7,00 | Punteggio: |
| La Bambina si presenta con un colore rosa buccia di cipolla brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente. Al naso denota aromi intensi, puliti e gradevoli che si aprono con note di ciliegia, lampone e mora seguite da aromi di fragola, ciclamino e susina. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mora. La Bambina matura in vasche d'acciaio. | |
| Abbinamento: Antipasti di carne e pesce, Pasta con pesce, Carne saltata, Pesce stufato | |
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
#Caprai4love: Montefalco nel Cuore |
||||
Su iniziativa promossa dall'Accademia di Montefalco per la storia, l'arte e la cultura locale, CrucianiC, in collaborazione con il Comune di Montefalco, Consorzio Tutela Vini di Montefalco, la Strada del Sagrantino e il Museo di San Francesco di Montefalco, hanno messo a disposizione le loro risorse, la loro creatività e l'amore per la loro terra per recuperare la pergamena ora in mano a una casa d'aste, restituirla alla città da cui è partita più di cinque secoli fa e ricostruire così un capitolo di storia fatto di arte, di lealtà e di amore. Per raggiungere questo obiettivo di “cuore” Luca Caprai, alla guida di CrucianiC, con la sua linea di braccialetti, ormai al polso delle maggiori star del mondo, nonché protagonisti dell'ultima mattonella d'autore per il Brunello di Montalcino 2012, ha creato un braccialetto in macramè special edition dove grappoli d'uva Sagrantino si sposano ad un cuore rosso Sagrantino che sarà in vendita a partire dal 27 Marzo sia sul sito di CrucianiC http://www.braccialetticruciani.it, sia sul territorio di Montefalco presso tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa. Il ricavato della vendita andrà all'Accademia della Cultura di Montefalco che acquisterà la lettera di Benozzo Gozzoli, restituendo così alla città di Montefalco un vero “pezzo” di cultura. Marco Caprai ama definire questo progetto un vero e proprio progetto SOCIAL+E, social perché i social network sono i suoi canali di diffusione, sociale perché il suo obiettivo è quello di restituire al territorio un importante pezzo della sua memoria storica. Inoltre dichiara: «Non possiamo “solo prendere” dal territorio, ma anche re distribuire all'interno di esso, iniziando così a comprende l'importanza che esso ricopre per ognuno di noi, del resto un famoso aforisma recita: Non ereditiamo il mondo dai nostri padri ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli» Con #caprai4love, il nostro intento è quello di far conoscere a un vasto pubblico questa iniziativa di recupero attraverso il coinvolgimento di bloggers, fotografi e “instagramers” ovvero la community di riferimento mondiale della “fotografia digitale”, creando un vero e proprio contest all'interno della community italiana. I risultati sui social network sono davvero sorprendenti: in meno di 48 ore su Twitter più 100 “influencer” della rete stanno già parlando di #caprai4love ottenendo così più di 350 mila impressions. Mentre il video teaser dell'iniziativa fa registrare già 1300 visualizzazioni e altissimi tassi di condivisione. Lo stesso sindaco di Montefalco, Donatella Tesei, ha dichiarato: «Il progetto “Montefalco nel Cuore” è un progetto di territorio, per il territorio. Con l'idea che il territorio torni finalmente protagonista ho deciso di coinvolgere le sue energie migliori in un momento in cui gli eventi straordinari a cui siamo di fronte non ci permettono di contribuire economicamente al recupero di questo pezzo importante della nostra storia con i soli mezzi pubblici» Aiutaci a donare un sogno a Montefalco comunicando l'iniziativa del braccialetto con il cuore. Segui su Twitter #caprai4love e guarda il video teaser dell'evento su YouTube. |
||||
FIVI pone la questione “Vendemmia Verde” |
| Nei lavori in corso al MIPAAF per giungere ai decreti di programmazione dei
finanziamenti legati all'OCM vino per il periodo 2014-2018, si discute anche di
finanziamenti alla Vendemmia Verde per le prossime campagne. FIVI ha contestato
la proposta avanzata da alcune Regioni di procedere a finanziare la Vendemmia
Verde e soprattutto di potersi avvalere di sostanze chimiche da spruzzare in
vigneto per far avvizzire i grappoli direttamente sulle viti. Né l'Europa, né
il Ministero avevano proposto tale modalità in applicazione della misura nº 102
del Regolamento Comunitario 1234/2007 a sostegno del settore vitivinicolo. Per “Vendemmia Verde” si intende la distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa del vigneto. L'obiettivo di tale misura (inserita nel PNS-vino previsto dalla OCM 2013-18) è quello di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, diminuendo la produzione vitivinicola e privilegiando le produzioni di vini di qualità che hanno maggiore capacità di penetrazione nei mercati e maggiore ritorno economico. FIVI ritiene che, alla luce del grande calo di produzione registrato nella vendemmia 2012 (il più significativo da alcune decine d'anni), si ponga la questione dell'utilità di una simile misura (che ovviamente sottrae risorse altrimenti destinabili ad altri capitoli, come la ristrutturazione vigneti o gli investimenti produttivi e commerciali). Ma se la misura può essere di sostegno, in determinate aree e determinati contesti, è giusto venga attuata tramite pratiche manuali o meccaniche, e assolutamente non si debba procedere per via chimica. Il risultato certo di una simile pratica, infatti, sarebbe un ulteriore inquinamento dei suoli e delle piante stesse. Risulterebbe peraltro paradossale diffondere nell'ambiente molecole atte a distruggere ciò che molto probabilmente si è fatto crescere in precedenza con l'uso di altri agenti chimici. FIVI evidenzia che queste richieste di “Vendemmia Verde chimica” indicano una programmazione regionale delle aree vitate non ottimale e il rischio di possibili danni ambientali. I Vignaioli FIVI, che mantengono rapporti con le autorità territoriali, sono impegnati in ogni contesto in cui operano a chiedere con fermezza che si desista da scelte incomprensibili, lesive della reputazione dell'agricoltura e della viticoltura e meno che mai lungimiranti. |
Più di 6 Tonnellate di Tappi in Sughero Riciclati |
| Chiuso con successo il primo anno di collaborazione della onlus trevigiana
Oltre il Labirinto con il progetto “Etico” di raccolta e riciclo dei tappi in
sughero usati promosso dall'azienda coneglianese Amorim Cork Italia, sede
italiana del colosso portoghese Amorim, leader mondiale del mercato del
sughero. Grazie alla presenza capillare sul territorio di numerosi punti di
raccolta, la onlus Oltre il Labirinto che è impegnata nel sostegno dei malati
di autismo e delle loro famiglie, è riuscita a raccogliere nel 2012 ben 6.041
kg di tappi. A consegnare alla onlus l'assegno di 6.041 euro è lo stesso Carlos Santos, AD Amorim Cork Italia, che mantiene l'impegno di responsabilità sociale dell'azienda, che vuole essere vicina, soprattutto nella difficile contingenza economica che attraversa l'Italia, a chi si occupa degli “ultimi”. «Sei tonnellate sono una cifra importante - afferma - se pensiamo che è riferita al primo anno di avvio dell'iniziativa e che riguarda un territorio relativamente ristretto. Questo significa che l'associazione si è spesa tantissimo per sensibilizzare la cittadinanza nella raccolta e questo è per noi un grandissimo risultato che va premiato». Il progetto “Etico” ha infatti come scopo, oltre alla raccolta e riciclo dei tappi, anche la sensibilizzazione della popolazione rispetto alla tutela ambientale e la salvaguardia delle foreste da sughero, strategiche nella lotta alla desertificazione e per il loro contributo all'abbattimento della produzione di Co2 globale. Pienamente raggiunti quindi gli obiettivi prefissati in questa prima fase di avvio del progetto Etico nel territorio trevigiano. Le sei tonnellate raccolte da Oltre il Labirinto onlus vanno a sommarsi agli altri quantitativi già raccolti sul territorio lombardo e che superano in tutto le venti tonnellate di tappi in sughero. «Come da accordi - spiega Santos - i tappi raccolti, opportunamente selezionati, sono stati venduti all'azienda trevigiana Eco Profili, specializzata in bioedilizia, al prezzo di 600 euro al kg. Per ogni kg 400 euro sono stati donati da Amorim alla onlus e quindi ecco raggiunta la cifra di 6.041 euro ricavati sia dalla vendita che e dal contributo di Amorim. È questo il motivo per cui abbiamo chiamato “Etico” questo progetto: perché per ogni tonnellata di tappi riciclata 1.000 euro sono donati alla società civile». Più che soddisfatta anche la Fondazione Oltre il Labirinto: «È stato un primo anno ricco di soddisfazione - afferma il presidente Alberto Cais - per la duplice finalità del progetto etica e ambientale, un'iniziativa unica nel suo genere, ma anche per l'incredibile partecipazione da parte di una rete di associazioni e persone fantastiche. Grazie di cuore ad Amorim, con l'augurio di poter continuare la collaborazione anche in futuro». «I soldi raccolti - dichiara il direttore Mario Paganessi - verranno impiegati per acquistare il laboratorio educativo e occupazionale nel villaggio di Godega dove abbiamo avviato da alcuni mesi percorsi a favore di bambini e adulti autistici legati al mondo agricolo e artigianale». |
Nuovo Programma per una Viticoltura Più Verde |
| Proseguono a pieno ritmo i lavori di preparazione del nuovo Protocollo
Viticolo, manuale di autodisciplina voluto dai produttori dell'area del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per rendere la viticoltura sempre
più amica dell'ambiente. Il passo più recente è stato compiuto durante la
riunione tra i vertici del Consorzio di Tutela, ideatore dell'iniziativa, la
Provincia di Treviso, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente Alberto
Villanova, le associazioni di categoria, alcuni comuni della DOCG, le Ulss7 e 8
e Legambiente. In occasione dell'incontro il Consorzio ha spiegato lo stato di
avanzamento del nuovo documento, che introdurrà importanti novità. Presentato
nel 2011 e adottato a partire dal 2012 su un totale di 600 ettari di vigneto,
il Protocollo ha avuto ricadute positive su una superficie molto più estesa
promuovendo una sempre maggiore sensibilità per la tematica ambientale da parte
dei viticoltori. «Il Protocollo Viticolo ha il ruolo di promuovere la
consapevolezza da parte dei produttori della necessità di rendere la
viticoltura sempre più in armonia con l'ambiente e la cittadinanza - afferma
il presidente del Consorzio Innocente Nardi - l'ambizione è farlo adottare in
modo capillare da tutti i viticoltori della zona e per ottenere questo
risultato è necessario che tutti vi credano e che vi sia una corretta
conoscenza del progetto.» L'obiettivo per il 2013 sarà raddoppiare la rappresentatività ed eliminare molti altri prodotti tossici. Durante la riunione tutti i presenti hanno condiviso i risultati e riconosciuto lo sforzo compiuto finora dal Consorzio. La Provincia di Treviso, in particolare, ha evidenziato l'importanza di questo percorso. «La Provincia di Treviso ha deciso fin dall'inizio di essere partner attiva di questa iniziativa di grande importanza per la tutela della salute delle persone e del nostro territorio - ha dichiarato l'assessore provinciale all'Ambiente, Alberto Villanova - La Provincia ha aderito con convinzione e fermezza al percorso intrapreso dal consorzio, dalle amministrazioni comunali, dall'ulss e dalle associazioni ambientaliste perché è convinta che il Prosecco DOCG debba essere il biglietto da visita di un territorio sano e d'eccellenza». Il nuovo Protocollo Viticolo verrà presentato ai media alla vigilia della partenza della nuova stagione produttiva, il 16 aprile, durante la conferenza stampa che si terrà alle 11:30 presso la sede della Camera di Commercio di Treviso. In attesa del lancio ufficiale, il documento è stato già discusso con le ditte farmaceutiche e inviato ai rivenditori di fitofarmaci, che potranno così impostare il nuovo magazzino nel rispetto delle indicazioni, ovvero scegliendo prodotti a basso impatto, consigliati dal Consorzio. A questo seguiranno ora le presentazioni ai viticoltori, curate dall'ufficio tecnico del Consorzio. Il ruolo dei produttori, infatti, è fondamentale e questi hanno già dimostrato la volontà di rispettare sempre più l'ambiente anche attraverso l'adozione di questo strumento. Il protocollo viticolo è studiato per offrire loro una vera e propria guida alla scelta e all'uso dei prodotti, con l'obiettivo di usare quelli a minore tossicità e ridurne il più possibile l'impiego. La risposta è già molto buona ma gli incontri saranno fondamentali per sviluppare una sensibilità ancora maggiore. |
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
| I punteggi delle acqueviti sono espressi secondo il metodo di valutazione di DiWineTaste. Fare riferimento alla legenda dei punteggi nella rubrica "I Vini del Mese" |

|
|
Grappa di Poggio ai Chiari |
|
| Colle Santa Mustiola (Toscana, Italia) | |
| (Distillatore: Distillerie Peroni Maddalena) | |
| Materia prima: Vinaccia di Sangiovese e Colorino | |
| Prezzo: € 26,00 - 50cl | Punteggio: |
| Grappa di Poggio ai Chiari si presenta incolore, limpida e cristallina. Al naso esprime aromi intensi, puliti e gradevoli di prugna, nocciola, amarena e violetta con pungenza dell'alcol percettibile. In bocca ha sapori intensi con pungenza dell'alcol che tende a dissolversi rapidamente, buona corrispondenza con il naso, piacevole morbidezza, dolcezza equilibrata. Il finale è persistente con ricordi di prugna, amarena e nocciola. Questa grappa è prodotta con alambicco discontinuo a caldaiette di vapore. Alcol 42°. | |
Wine Parade |
|
|
| I 15 migliori vini secondo i lettori di DiWineTaste. Per esprimere le vostre preferenze comunicate i vostri tre migliori vini al nostro indirizzo di posta elettronica oppure compilare il modulo disponibile nel nostro sito. |
| Posizione | Vino, Produttore | |
|---|---|---|
| 1 |
| Avvoltore 2009, Moris Farms (Italia) |
| 2 |
| Trento Talento Brut Riserva 2007, Letrari (Italia) |
| 3 |
| Franciacorta Pas Dosé Récemment Dégorgé 2006, Cavalleri (Italia) |
| 4 |
| San Leonardo 2006, Tenuta San Leonardo (Italia) |
| 5 |
| Sagrantino di Montefalco Collepiano 2007, Arnaldo Caprai (Italia) |
| 6 |
| Confini 2007, Lis Neris (Italia) |
| 7 |
| Adarmando 2009, Tabarrini (Italia) |
| 8 |
| Trento Brut Riserva Methius 2006, Dorigati (Italia) |
| 9 |
| Batàr 2008, Querciabella (Italia) |
| 10 |
| Camartina 2008, Querciabella (Italia) |
| 11 |
| Brunello di Montalcino 2007, Donatella Cinelli Colombini (Italia) |
| 12 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2010, Garofoli (Italia) |
| 13 |
| Gran Masetto 2007, Endrizzi (Italia) |
| 14 |
| Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi 2007, Tedeschi (Italia) |
| 15 |
| Offida Rosso Il Grifone 2006, Tenuta Cocci Grifoni (Italia) |
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |