
Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
 Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Numero 221, Ottobre 2022 |
Sommario |
|
|
Siamo Tutti Sommelier |
|
C'era un tempo nel quale trovare qualcuno con la qualifica da sommelier era piuttosto raro. Oggi, al contrario, trovare qualcuno che non sia sommelier è impresa difficilissima. A vario titolo, a chiunque si chieda, ovunque si vada o indipendentemente da chi si frequenta, è molto probabile trovare almeno una persona che possiede un titolo da sommelier. Del resto, oggi ci sono diverse decine di associazioni, scuole e corsi capaci di rilasciare, a vario titolo e modo, la prestigiosa qualifica di sommelier. Ce n'è per tutti i gusti, possibilità e ambizioni, si diventa sommelier anche nel giro di pochissimo tempo conseguendo – addirittura – qualifiche di livelli crescenti tali da promettere la conoscenza dei segreti più reconditi sul vino e non solo. Non è difficile, infatti, durante una conversazione sul vino, nel momento topico della discussione, sentirsi dire che il proprio interlocutore è sommelier di primo, secondo, terzo, quarto o supremo livello assoluto con tanto di cintura nera enoica. Una precisazione che, nelle intenzioni dell'interlocutore, dovrebbe mettere a tacere qualunque controversia per il fatto che lui – o lei – sa perché è sommelier con tanto di attestato, pertanto conoscente supremo e illuminato di qualsivoglia tema legato al vino. Non solo: anche i conoscenti di sommelier o presunti tali si fregiano del privilegio di cotante influenti relazioni, convinti di possedere – per chissà quale proprietà transitiva – l'onniscienza enologica. Nel bel mezzo di una discussione, troncano e chiosano con “ho un amico sommelier”, pronunciato con aria ed enfasi tronfia, confidando di soffocare qualunque ed eventuale replica, come per dire “lei non sa chi sono io”. I sommelier sono dappertutto e tutti siamo sommelier in qualche modo. Se non altro, per il comune vezzo del ridicolo che molti praticano, convinti che, non appena giungono alla conoscenza del fatto che “uno più uno è uguale due”, si credono geni della matematica. La cosa triste e desolante è che, spesso, anzi, spessissimo, questi diplomati a vario titolo, detentori di attestati vari, a malapena sanno cos'è un sommelier, quali sono le sue competenze e le conoscenze che dovrebbe, almeno per un minimo, possedere. Si atteggiano a esperti della sommellerie – senza nemmeno sapere, appunto, cosa sia – quando poi sono addirittura incapaci di aprire correttamente una bottiglia di spumante, spesso anche di vino da tavola, competenza della degustazione sensoriale desolante, al limite, nozionistica perché qualcuno ha detto loro che “è così”. Se poi si chiede loro i motivi per i quali, per esempio, certi vini si servono in un certo modo, a una determinata temperatura, non hanno la minima idea dei motivi, né tecnici né pratici. A malapena hanno degustato qualche decina di vini, ma per loro, evidentemente, rappresentano tutti i vini del mondo, una summa della conoscenza enoica passata, presente e futura. Del resto, sono sommelier, visto che qualcuno gliel'ha fatto credere in qualche modo. Faccio una doverosa precisazione: in ogni paese del mondo dove esiste una tradizione culturale enologica – e in particolare in Francia e in Italia, dove la sommellerie ha innegabilmente una storia solida e significativa – operano associazioni competenti e serie capaci di formare effettivamente un sommelier. Ma è anche vero che poi esistono una lunga serie di scuole, corsi e associazioni che usano il termine sommelier con imbarazzante disinvoltura. Si fregiano perfino di essere “ambasciatori del vino”, quando poi di vino sanno palesemente ben poco. Questo è innegabilmente il risultato dei nostri tempi, nei quali si deve dare l'illusione a chiunque che per conseguire un risultato – qualunque esso sia – basti poco, quel poco che deve essere alla portata di tutti. Tutto deve essere facile e spensierato, tutto politicamente corretto, tutti devono potere arrogare il diritto di essere esperti per il semplice fatto di esistere o di avere la facoltà di esprimere il proprio pensiero. Questo rispecchia, purtroppo, quello che accade nella nostra società in generale: tutto deve essere facile, tutto si deve ottenere senza il minimo sforzo, merito o impegno. Innegabile, è anche il risultato della crescente cultura del “furbo” e della superficialità che prevalgono sull'onestà e il reale merito. Sommelier è una parola francese di inequivocabile origine latina. L'autorevole Académie Française definisce sommelier come «colui che in una comunità, in una casa, si occupa della biancheria, dei piatti, del pane, del vino e dei liquori», aggiungendo poi, in un'accezione moderna, che «sommelier si dice soprattutto di colui che, in un ristorante, si occupa della cantina». Il significato moderno del termine sommelier, in effetti, è molto lontano dal suo originale significato. In accordo al dizionario Larousse «nel medioevo [il sommelier era] l'ufficiale addetto al trasporto, su bestie o cavalli da soma, dei bagagli di un principe o di un signore» e «ufficiale incaricato di apparecchiare la tavola e preparare i vini». Il dizionario Le Robert, per quanto riguarda l'origine del termine, riporta che sommelier «deriva da summularius, a sua volta derivato da summula diminutivo di summa». Sommelier deriva quindi dal francese antico e, più precisamente, dal provenzale saumalier, cioè “conduttore della soma”, a sua volta derivato da “sauma”. Il termine è di derivazione latina, precisamente sagma, cioè “soma”. In origine, quindi, il sommelier era il “conducente delle bestie da soma”. Il sommelier acquisisce il significato moderno – cioè di addetto alla cantina e dei vini – all'inizio del 1800, tuttavia è bene osservare che una figura simile era già ben definita, soprattutto in Italia, con il termine coppiere, una figura già nota in tempi remoti e che aveva il compito di versare il vino nelle coppe dei ricchi banchettanti. Al coppiere si aggiunge poi il bottigliere, che aveva anche il compito di gestire la cantina e il suo approvvigionamento, a servizio di ricchi nobili. Sarà comunque il termine sommelier ad avere il sopravvento, e oggi è così che si definisce la figura professionale che si occupa del servizio del vino e dei distillati, oltre alla gestione della cantina e delle bottiglie conservate al suo interno. Insomma, il sommelier è anche un gestore e amministratore della cantina, soprattutto in un ristorante. Ha inoltre competenze sulla degustazione sensoriale del vino, il suo servizio e abbinamento con il cibo, oltre ad avere solide conoscenze di ampelografia ed enografia. Per chiarire ulteriormente, un degustatore di vino, con reali o presunte competenze in questa non banale disciplina, non è un sommelier. Mi capita molto spesso di leggere di corsi, associazioni e scuole per sommelier, quando poi – a ben vedere i loro programmi didattici – a malapena si occupano di fornire i rudimenti basilari della degustazione sensoriale. Riferimenti al servizio del vino e alla gestione della cantina, totalmente assenti. Spesso si tratta di “corsi” di poche lezioni, ognuna dedicata a uno specifico stile di vino e alla sua “degustazione”, al termine delle quali i partecipanti si possono definire trionfalmente a chiunque come sommelier. Questo farebbe pensare, non da meno, che il vero sommelier è solamente colui, o colei, che opera in un ristorante con questa qualifica. La mia personale esperienza, purtroppo, mi fa pensare che non sempre è così. Riconosco ci sono ristoranti – pochi, in verità – nei quali lavorano sommelier preparati, competenti e capaci, tuttavia nella maggioranza dei casi, è deprimente constatare come la loro preparazione sia imbarazzante, a partire dal servizio del vino. Se si guardano, poi, le carte dei vini di molti ristoranti – la cui composizione e compilazione spetta al sommelier – è desolante constatarne l'incompletezza e l'inesattezza. Eppure, mettono in bella mostra le loro insegne di appartenenza alla sommellerie appuntate sulla giacca, non da meno, la presenza del sommelier è addirittura annunciata all'ingresso del ristorante. Come per tutte le cose, il fatto di avere conseguito un diploma o un attestato non rappresenta l'effettiva capacità o competenza in una determinata disciplina o materia. Entrambe le cose si conseguono molto più avanti – per scelta, determinazione e volontà – attraverso lo studio, la pratica, la perseveranza, il talento, l'attitudine, la tenacia e l'avere usato proficuamente il tempo e le proprie risorse. Avere degustato qualche calice di vino nella confusione dei tavoli di un corso o scuola, avere maldestramente stappato – nella stessa occasione – qualche bottiglia di vino, possedere nozioni basilari sulle materie necessarie per la conoscenza del vino e dei distillati, non bastano a fare un sommelier. Figuriamoci poi i “sommelier” che conseguono un attestato al termine di un corso di poche lezioni, tutto incentrato sulla sommaria introduzione alla degustazione sensoriale. Perché va detto che oggi, molto spesso, per sommelier si intende qualcuno che, dopo avere messo il naso in un calice di vino, racconta, più o meno, qualcosa che possa fare effetto sull'ignoranza di chi ascolta. Il sommelier, tuttavia, è ben altro. E, per favore, imparate ad aprire le bottiglie e a servire vino correttamente. In caso contrario, presentatevi come “appassionati di vino che forse sanno qualcosa della degustazione sensoriale”. Essere sommelier e la sommellerie sono ben altro. Antonello Biancalana
|
||||
Contrasti di Lago di Caldaro Classico Superiore e Campidano di Terralba |
|
Bovale SuperioreDue vini interessanti, rappresentanti significativi delle loro terre, prodotti con uve altrettanto rappresentative di Trentino-Alto Adige e Sardegna, ricche di personalità e carattere. La degustazione per contrasto di questo mese mette a confronto due uve e due vini decisamente diversi e distanti. Non solo dal punto di vista geografico – i due vini sono prodotti in Trentino-Alto Adige e Sardegna – ma anche da quello ampelografico e sensoriale. Entrambe le regioni offrono un ampio panorama di uve e vini, spesso prodotti con varietà autoctone, tutti caratterizzati da spiccata personalità e riconoscibilità. Il patrimonio ampelografico di queste due regioni è ricco sia di varietà a bacca bianca sia rossa e, nonostante si faccia anche uso delle cosiddette uve internazionali, in particolare in Trentino-Alto Adige, l'identità delle varietà autoctone dei due territori è ampiamente rappresentata nei loro vini. Nella degustazione per contrasto di questo mese prendiamo in esame varietà rosse autoctone del Trentino-Alto Adige e della Sardegna. Nei nostri calici verseremo infatti vini prodotti in queste regioni appartenenti a territori a Denominazione d'Origine Controllata, nello specifico, Lago di Caldaro Classico Superiore per il Trentino-Alto Adige, Campidano di Terralba Bovale Superiore per la Sardegna. I vini della denominazione Lago di Caldaro sono prodotti, in accordo al suo disciplinare di produzione, con la varietà Schiava, anche se, in questo caso, è opportuno dire con le uve Schiava. Si deve infatti osservare che con questo termine si definisco ben tre varietà distinte e tutte ammesse alla produzione del vino Lago di Caldaro. Il Campidano di Terralba Bovale Superiore ha invece come protagonista una delle uve più interessanti di Sardegna – il Bovale – capace di creare vini di notevole pregio e personalità. Le uve Schiava e il Bovale sono varietà decisamente diverse e i loro vini altrettanto diversi da ogni punto di vista, sia enologico sia sensoriale. Da un lato, la finezza e l'eleganza dei vini del Lago di Caldaro e delle uve Schiava, dall'altro la potenza e il carattere del Bovale espresso nei vini di quella che è l'area più significativa di Sardegna per i vini prodotti con quest'uva: il Campidano di Terralba nelle provincie di Oristano e Sud Sardegna. Sarà quindi una degustazione per contrasto molto interessante, nella quale avremo l'opportunità di confrontare due stili decisamente diversi e distanti.
|
|
Il territorio vitivinicolo del Lago di Caldaro è fra i principali rappresentanti della produzione enologica del Trentino-Alto Adige. Questa importante area a Denominazione d'Origine Controllata (DOC) si sviluppa intorno all'omonimo lago e si estende nei territori delle provincie di Bolzano e Trento, vanta una lunga storia e qui si producevano vini già nel 500 a.C. In questa denominazione l'uva regina è la Schiava, tuttavia – in questo caso – è opportuno parlare della famiglia delle uve Schiava poiché comprende tre membri distinti: Schiava Grossa, Schiava Gentile e Schiava Grigia. A causa del bilinguismo in vigore in Alto Adige, questa denominazione è conosciuta anche con il nome tedesco di Kalterersee, mentre – per la stessa ragione – le uve Schiava sono anche conosciute come Vernatsch, più specificamente e rispettivamente Großvernatsch, Kleinvernatsch e Grauvernatsch. Per completezza, va detto che la Schiava Gentile è anche detta Schiava Piccola (Kleinvernatsch) o Schiava Media (Mittlerer Vernatsch). Per quanto riguarda la Schiava Grigia, si tende a considerarla come una varietà distinta, nonostante le sue somiglianze enologiche e organolettiche con gli altri membri della famiglia “Schiava”. Sull'origine del nome, ancora oggi non si hanno certezze, poiché per alcuni deriverebbe dal modo con il quale in passato si coltivava questa vite, cioè legata a tutori e supporti (quindi, per così dire “schiavizzata”), ma anche per le drastiche potature effettuate con lo scopo di ottenere maggiore vigoria e quindi migliore qualità delle uve. Inoltre, per altri deriverebbe dalla caratteristica coltivazione a ceppo basso e “schiavizzate” in filari. Altra ipotesi, sarebbe l'origine slava, introdotta in queste terre durante le invasioni longobarde, quindi italianizzato in “schiava”. In accordo al suo disciplinare di produzione, questo vino è prodotto per un minimo dell'85% di uve Schiava Grossa, Schiava Gentile e Schiava Grigia, da sole o congiuntamente. La restante quota del 15% può essere eventualmente rappresentata da varietà ammesse alla coltivazione nel Trentino-Alto Adige. Il disciplinare del Lago di Caldaro, inoltre, prevede gli stili riserva, scelto, classico, classico riserva, classico superiore, classico superiore riserva, scelto classico, scelto classico riserva, scelto classico superiore e scelto classico superiore riserva. Gli stili “riserva” devono maturare per un periodo minimo di due anni, operazione spesso condotta in contenitori di legno.
|
||||
|
La Sardegna è fra le regioni d'Italia a vantare il maggiore patrimonio di varietà autoctone e, fra queste, una posizione di assoluto rilievo spetta certamente all'uva Bovale. Un tempo utilizzata come uva da taglio per conferire maggiore struttura ai vini dell'isola, in modo particolare, a quelli prodotti con Cannonau e Monica, oggi è ampiamente riconosciuto come uva di assoluto rilievo nel ricco panorama viticolturale della Sardegna. Il Bovale trova la sua espressione più significativa nella Denominazione d'Origine Controllata di Campidano di Terralba – o semplicemente, Terralba – il quale territorio di estende fra le provincie di Oristano e Sud Sardegna. Va infatti detto che, nonostante il Bovale sia diffuso in tutta la regione, quella di Campidano di Terralba è l'unica denominazione della Sardegna e prevedere l'impiego del Bovale come varietà prevalente. In accordo al suo disciplinare di produzione, infatti, il Campidano di Terralba si produce con Bovale Sardo e/o Bovale Grande per almeno l'85%, mentre l'eventuale parte rimanente può essere costituita da uve a bacca rossa ammesse alla coltivazione in Sardegna. A tale proposito, va detto che i produttori tendono a produrre i vini di questo territorio con Bovale in purezza, soprattutto per esaltare le interessanti qualità che quest'uva esprime in queste terre. Per quanto concerne la sua storia, l'origine del Bovale è ancora oggi poco chiara e incerta. Si suppone che si tratti di varietà introdotte dalla Spagna durante il dominio aragonese, distinguendosi in due varietà specifiche: Bovale Sardo – o semplicemente, Bovale – e Bovale Grande. Indagini genetiche su queste due varietà – nonostante il loro nome – hanno evidenziato che non esiste alcuna relazione fra le due uve e pertanto si tratta di varietà distinte. Si è potuto altresì evidenziare una certa similitudine del Bovale Sardo con le varietà Cagnulari e Graciano, mentre il Bovale Grande sembrerebbe condividere caratteristiche del Carignano, Cariñena e Mazuela, a testimonianza delle loro presunte origini spagnole. In accordo al disciplinare di produzione, il Campidano di Terralba prevede gli stili Superiore e Riserva, quest'ultima obbligatoriamente maturata per almeno due anni, pratica che sovente è condotta in contenitori di legno.
|
Prima di iniziare la degustazione per contrasto di questo mese, provvediamo a reperire le due bottiglie che verseremo nei calici. A tale proposito va detto che la ricerca del Lago di Caldaro Classico Superiore è relativamente semplice poiché si tratta di un vino che gode di buona produzione e distribuzione. Sicuramente più difficile è l'acquisto del Campidano di Terralba Bovale Superiore, il quale – nonostante il suo prestigio enologico nel panorama viticolturale della Sardegna – non è molto presente negli scaffali della grande distribuzione, tuttavia una buona enoteca saprà certamente reperire questo interessante vino sardo. In entrambi i casi dovremo fare attenzione alla composizione, poiché i rispettivi disciplinari prevedono l'impiego delle uve primarie per un minimo dell'85%. Faremo quindi attenzione che il Lago di Caldaro Classico Superiore sia prodotto esclusivamente con le varietà Schiava, mentre il Campidano di Terralba Bovale Superiore con l'omonima varietà in purezza. Le due bottiglie appartengono alla vendemmia più recente e i vini sono versati in calici da degustazione alla temperatura di 18 °C. Versiamo il Lago di Caldaro Classico Superiore e il Campidano di Terralba Bovale Superiore nei nostri calici e diamo inizio alla degustazione per contrasto di questo mese. Il primo vino che prendiamo in esame è quello del Trentino-Alto Adige, quindi, inclinando il calice sopra una superficie bianca – è sufficiente un foglio di carta – osserviamo la base così da valutare il suo colore. Si osserva un deciso rosso brillante e intenso, inoltre – mettendo un oggetto a contrasto fra il calice e la superficie bianca – notiamo una trasparenza moderata tale da consentire la visione dell'oggetto. Concentriamo ora il nostro sguardo verso l'apertura del calice, dove lo spessore del vino si fa sottile, e valutiamo la sfumatura: il Lago di Caldaro Classico Superiore conferma il rosso rubino. Passiamo ora alla valutazione dell'aspetto del Campidano di Terralba Bovale Superiore e, come per il vino precedente, incliniamo il calice sopra la superficie bianca. Il colore del vino sardo è rosso rubino, decisamente intenso e più scuro rispetto al vino del Trentino-Alto Adige. La trasparenza del Bovale, rispetto al vino precedente, è decisamente inferiore e l'oggetto posto a contrasto è difficilmente visibile. La sfumatura del Campidano di Terralba Bovale Superiore conferma il colore rosso rubino. I profumi espressi dai vini prodotti con le uve Schiava e Bovale si differenziano sostanzialmente in diversi aspetti. I vini prodotti con le uve Schiava – come il Lago di Caldaro – si caratterizzano prevalentemente per la finezza e l'eleganza dei loro profumi, in particolare per le sensazioni di frutti a polpa rossa e fiori. Fra i riconoscimenti principali dei vini prodotti con le uve Schiava troviamo, per quanto riguarda le sensazioni riconducibili alla frutta, i profumi di ciliegia, lampone, prugna, fragola e mirtillo. Inoltre, i vini prodotti con le uve Schiava, e quindi anche il Lago di Caldaro, si caratterizzano sovente per un piacevole profumo di mandorla. Il mondo dei fiori che troviamo in questi vini è principalmente rappresentato da ciclamino e violetta. Ben diverso e decisamente più potente il profilo olfattivo dei vini prodotti con il Bovale. Il carattere, rispetto a quello espresso dalla Schiava, è decisamente più pieno e potente, nel quale si riconoscono, per quanto riguarda le sensazioni riconducibili a frutta, profumi di amarena, prugna, mora e mirtillo. Il principale riconoscimento floreale dei vini prodotti con Bovale è la violetta. Riprendiamo la nostra degustazione per contrasto e procediamo con l'analisi dei profili olfattivi del Lago di Caldaro Classico Superiore e Campidano di Terralba Bovale Superiore. Il primo vino che prendiamo in esame, come nella fase precedente, è quello prodotto in Trentino-Alto Adige. Mantenendo il calice in posizione verticale e senza rotearlo, effettuiamo la prima olfazione così da valutare l'apertura, cioè i profumi identificativi e primari. Il Lago di Caldaro Classico Superiore si fa riconoscere immediatamente per i suoi profumi di ciliegia, lampone e prugna, immediatamente seguiti dal profumo di ciclamino e violetta. Dopo avere roteato il calice, il vino del Trentino-Alto Adige continua a regalare profumi che ricordano la frutta e, in particolare, fragola e mirtillo. Inoltre, si percepisce netto e intenso il piacevole profumo della mandorla. Passiamo ora alla valutazione dell'apertura del Campidano di Terralba Bovale Superiore, procedendo con la prima olfazione e mantenendo il calice in posizione verticale, senza rotearlo. Al naso si percepiscono aromi intensi di amarena, mirtillo e mora, seguiti dal piacevole profumo della violetta. Dopo avere roteato il calice, il profilo del vino sardo si completa con prugna, talvolta accompagnata da lampone e ribes. La valutazione dei profili gustativi è certamente la fase che evidenzia le maggiori differenze fra Lago di Caldaro Classico Superiore e Campidano di Terralba Bovale Superiore. Iniziamo dalla valutazione dell'attacco, cioè le sensazioni gustative iniziali che percepiamo nel vino dopo il primo sorso. Come per le fasi precedenti, procediamo con la valutazione del Lago di Caldaro Classico Superiore e pertanto prendiamo un sorso di questo vino. In bocca si percepisce subito una piacevole e moderata astringenza, seguita dall'altrettanto piacevole freschezza conferita dall'acidità. Il vino è comunque ben equilibrato grazie all'effetto dell'alcol. In bocca percepiamo buona finezza ed eleganza, unitamente a sapori di ciliegia, lampone e prugna. Passiamo ora alla valutazione dell'attacco del Campidano di Terralba Bovale Superiore, prendendo quindi un sorso di questo vino dal calice. La differenza gustativa con il vino del Trentino-Alto Adige è evidente: l'attacco del vino sardo è decisamente di maggiore struttura e anche l'astringenza è più intensa. Inoltre, la percezione della morbidezza e dell'effetto dell'alcol sono maggiori, mentre la freschezza è decisamente inferiore. Si percepiscono infine i sapori di amarena, mirtillo e mora. Siamo giunti alla fase conclusiva della nostra degustazione per contrasto, consistente nella valutazione delle sensazioni finali che i vini lasciano in bocca dopo la deglutizione, in modo particolare la persistenza gusto-olfattiva. Il finale del Lago di Caldaro Classico Superiore è intenso e in bocca si continuano a percepire le piacevoli sensazioni di freschezza e la moderata astringenza, ben sostenute da buona eleganza e finezza. Si continuano inoltre a percepire i sapori di ciliegia, lampone, prugna e fragola, a volte anche la mandorla. Le differenze sensoriali dei due vini continuano anche nella fase finale della degustazione. Il Campidano di Terralba Bovale Superiore – anch'esso caratterizzato da buona persistenza – lascia infatti in bocca una sensazione di maggiore struttura e astringenza, con morbidezza più accentuata e freschezza di minore intensità rispetto al vino precedente. In bocca, infine, il vino sardo lascia ricordi netti e puliti di amarena, mora e prugna, spesso uniti a mirtillo.
|
||||||||
I Vini del Mese |
|
|
|
Legenda dei punteggi I prezzi sono da considerarsi indicativi in quanto possono subire variazioni a seconda del paese e del luogo in cui vengono acquistati i vini |

|
|
Demetra Pinot Bianco Brut Nature |
|
| Mirabella (Lombardia, Italia) | |
 Pinot Bianco Pinot Bianco | |
| Prezzo: € 26,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, camomilla,
ginestra, ananas, pera, canditi, cedro, miele, pralina, tiglio e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, camomilla,
ginestra, ananas, pera, canditi, cedro, miele, pralina, tiglio e minerale.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e pralina. Finale persistente con ricordi di mela, susina e pralina. Una piccola parte del vino base fermentata in barrique. Rifermentazione
in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi. Una piccola parte del vino base fermentata in barrique. Rifermentazione
in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi.
|
|
 Pasta con pesce, Stufati di carne bianca, Pesce arrosto, Zuppe di pesce Pasta con pesce, Stufati di carne bianca, Pesce arrosto, Zuppe di pesce |
|

|
|
Franciacorta Brut Nature Demetra 2016 |
|
| Mirabella (Lombardia, Italia) | |
 Chardonnay (70%), Pinot Nero (20%), Pinot Bianco (10%) Chardonnay (70%), Pinot Nero (20%), Pinot Bianco (10%) | |
| Prezzo: € 27,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, susina e crosta di pane seguite da aromi di acacia, biancospino,
cedro, mela, pera, pompelmo, nocciola, brioche, burro, pralina e miele. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, susina e crosta di pane seguite da aromi di acacia, biancospino,
cedro, mela, pera, pompelmo, nocciola, brioche, burro, pralina e miele.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di banana, susina e cedro. Finale persistente con ricordi di banana, susina e cedro. Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione
in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 60 mesi. Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione
in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 60 mesi.
|
|
 Pasta con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di pesce, Zuppe di funghi Pasta con pesce, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di pesce, Zuppe di funghi |
|
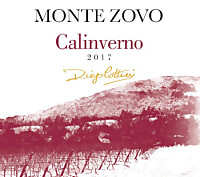
|
|
Calinverno 2017 |
|
| Monte Zovo (Veneto, Italia) | |
 Corvina, Corvinone (70%), Rondinella (20%), Cabernet Sauvignon (5%), Croatina (5%) Corvina, Corvinone (70%), Rondinella (20%), Cabernet Sauvignon (5%), Croatina (5%) | |
| Prezzo: € 23,90 | Punteggio: |
 Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo,
cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo
pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora. 24 mesi in barrique e botte, 12 mesi in bottiglia. 24 mesi in barrique e botte, 12 mesi in bottiglia. |
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati |
|
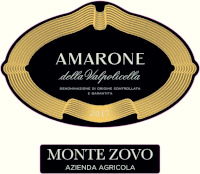
|
|
Amarone della Valpolicella 2017 |
|
| Monte Zovo (Veneto, Italia) | |
 Corvina (60%), Corvinone (30%), Rondinella (10%) Corvina (60%), Corvinone (30%), Rondinella (10%) | |
| Prezzo: € 38,60 | Punteggio: |
 Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena sotto spirito,
mirtillo, cioccolato, tamarindo, tabacco, cannella, liquirizia, cuoio,
macis, caramello, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mora, prugna e viola appassita seguite da aromi di amarena sotto spirito,
mirtillo, cioccolato, tamarindo, tabacco, cannella, liquirizia, cuoio,
macis, caramello, vaniglia e mentolo.
 Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, corpo pieno, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena
sotto spirito. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mora, prugna e amarena
sotto spirito.
 24 mesi in botte e barrique, 6 mesi in acciaio, almeno 12 mesi in
bottiglia. 24 mesi in botte e barrique, 6 mesi in acciaio, almeno 12 mesi in
bottiglia.
|
|
 Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati |
|
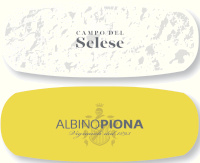
|
|
Bianco di Custoza Superiore Campo del Selese 2020 |
|
| Albino Piona (Veneto, Italia) | |
 Garganega (40%), Trebbiano di Soave (30%), Trebbianello di Soave (15%), Pinot Bianco, Incrocio Manzoni 6.0.13 (15%) Garganega (40%), Trebbiano di Soave (30%), Trebbianello di Soave (15%), Pinot Bianco, Incrocio Manzoni 6.0.13 (15%) | |
| Prezzo: € 20,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas,
pera, nespola, banana, miele, mandorla, vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas,
pera, nespola, banana, miele, mandorla, vaniglia e minerale.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas. Parte della Garganega fermenta in barrique. 12 mesi in vasche
d'acciaio. Parte della Garganega fermenta in barrique. 12 mesi in vasche
d'acciaio.
|
|
 Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di legumi Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di legumi |
|
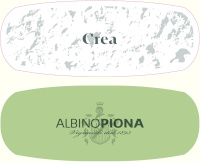
|
|
Bianco di Custoza Crea 2019 |
|
| Albino Piona (Veneto, Italia) | |
 Garganega (40%), Trebbiano di Soave (30%), Trebbianello di Soave (15%), Incrocio Manzoni 6.0.13 (15%) Garganega (40%), Trebbiano di Soave (30%), Trebbianello di Soave (15%), Incrocio Manzoni 6.0.13 (15%) | |
| Prezzo: € 22,00 | Punteggio: |
 Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas,
pera, nespola, pompelmo, scorza di agrume, miele, mandorla e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas,
pera, nespola, pompelmo, scorza di agrume, miele, mandorla e vaniglia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole morbidezza.
 Finale persistente con ricordi di susina, mela e pesca. Finale persistente con ricordi di susina, mela e pesca. 16 mesi in barrique. 16 mesi in barrique. |
|
 Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Stufati di carne bianca, Formaggi Paste ripiene con funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Stufati di carne bianca, Formaggi |
|

|
|
Valdobbiadene Extra Dry Rive di Soligo Mas de Fer 2021 |
|
| Andreola (Veneto, Italia) | |
 Glera Glera | |
| Prezzo: € 11,80 | Punteggio: |
 Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pera, albicocca e glicine seguite da aromi di acacia, biancospino,
ginestra, mandarino, mela, ananas, mango, melone, felce e mandorla. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pera, albicocca e glicine seguite da aromi di acacia, biancospino,
ginestra, mandarino, mela, ananas, mango, melone, felce e mandorla.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
debole, sapori intensi, piacevole dolcezza. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
debole, sapori intensi, piacevole dolcezza.
 Finale persistente con ricordi di pera, albicocca e mandarino. Finale persistente con ricordi di pera, albicocca e mandarino. Prodotto con il metodo Charmat. Prodotto con il metodo Charmat. |
|
 Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato Aperitivi, Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato |
|

|
|
Valdobbiadene Brut Rive del Refrontolo Col del Forno 2021 |
|
| Andreola (Veneto, Italia) | |
 Glera Glera | |
| Prezzo: € 11,80 | Punteggio: |
 Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pera, pesca e glicine seguite da aromi di acacia, ginestra, mela verde,
mandarino, kiwi, banana, ananas, mango, nespola e aneto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
pera, pesca e glicine seguite da aromi di acacia, ginestra, mela verde,
mandarino, kiwi, banana, ananas, mango, nespola e aneto.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
leggero, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo
leggero, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di pera, pesca e mela
verde. Finale molto persistente con lunghi ricordi di pera, pesca e mela
verde.
 Prodotto con il metodo Charmat. Prodotto con il metodo Charmat. |
|
 Aperitivi, Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Latticini, Uova Aperitivi, Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Latticini, Uova |
|
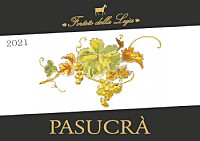
|
|
Piemonte Moscato Secco Pasucrà 2021 |
|
| Forteto della Luja (Piemonte, Italia) | |
 Moscato Bianco Moscato Bianco | |
| Prezzo: € 9,80 | Punteggio: |
 Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pesca e
rosa bianca seguite da aromi di ginestra, lavanda, litchi, pera, mela,
agrumi, banana e salvia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pesca e
rosa bianca seguite da aromi di ginestra, lavanda, litchi, pera, mela,
agrumi, banana e salvia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di uva, pesca e litchi. Finale persistente con ricordi di uva, pesca e litchi. Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Pasta e risotto con crostacei e funghi, Crostacei alla griglia, Carne bianca saltata con funghi Pasta e risotto con crostacei e funghi, Crostacei alla griglia, Carne bianca saltata con funghi |
|
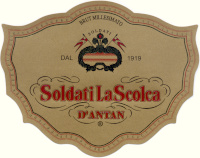
|
|
Soldati La Scolca Brut Millesimato Riserva d'Antan 2010 |
|
| La Scolca (Piemonte, Italia) | |
 Cortese Cortese | |
| Prezzo: € 70,00 | Punteggio: |
 Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente,
perlage fine e persistente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente,
perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegant, apre con note di
mela, arancia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, ginestra,
pera, pesca, susina, nocciola, mango, ananas, mandorla, miele, brioche e
burro. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegant, apre con note di
mela, arancia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, ginestra,
pera, pesca, susina, nocciola, mango, ananas, mandorla, miele, brioche e
burro.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, arancia e
mandorla. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, arancia e
mandorla.
 Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per circa
10 anni. Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per circa
10 anni.
|
|
 Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Carne bianca stufata Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Carne bianca stufata |
|
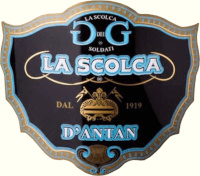
|
|
La Scolca d'Antan 2008 |
|
| La Scolca (Piemonte, Italia) | |
 Cortese Cortese | |
| Prezzo: € 69,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela cotogna, susina e mandorla seguite da aromi di biancospino, crosta di
pane, pompelmo, bergamotto, confettura di pere, tiglio, mallo di noce,
miele, brioche, rosmarino, burro e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela cotogna, susina e mandorla seguite da aromi di biancospino, crosta di
pane, pompelmo, bergamotto, confettura di pere, tiglio, mallo di noce,
miele, brioche, rosmarino, burro e pietra focaia.
 Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori
intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di susina, mela cotogna e
mandorla. Finale molto persistente con lunghi ricordi di susina, mela cotogna e
mandorla.
 Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio. |
|
 Paste ripiene con pesce, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di funghi, Formaggi Paste ripiene con pesce, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Zuppe di funghi, Formaggi |
|

|
|
Franciacorta Satèn Brut 2018 |
|
| Ricci Curbastro (Lombardia, Italia) | |
 Chardonnay Chardonnay | |
| Prezzo: € 30,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, mela,
pompelmo, pera, cedro, ananas, burro, miele, brioche e pralina. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, mela,
pompelmo, pera, cedro, ananas, burro, miele, brioche e pralina.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo. Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per
almeno 40 mesi. Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per
almeno 40 mesi.
|
|
 Pasta e risotto con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Crostacei saltati, Pesce arrosto Pasta e risotto con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Crostacei saltati, Pesce arrosto |
|
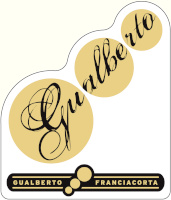
|
|
Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2012 |
|
| Ricci Curbastro (Lombardia, Italia) | |
 Pinot Nero (65%), Chardonnay (35%) Pinot Nero (65%), Chardonnay (35%) | |
| Prezzo: € 41,00 | Punteggio: |
 Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto
trasparente, perlage fine e persistente.
 Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo,
melone, ananas, pesca, mandarino, miele, brioche, pralina, burro, vaniglia
e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di
mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo,
melone, ananas, pesca, mandarino, miele, brioche, pralina, burro, vaniglia
e minerale.
 Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon
corpo, sapori intensi, piacevole.
 Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pompelmo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pompelmo. Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione
in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 80 mesi. Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione
in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 80 mesi.
|
|
 Pasta con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato con funghi Pasta con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato con funghi |
|
Notiziario |
|
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.
|
Pinot Grigio delle Venezie tra Previsioni di Sistema e Gestione del Consorzio di Tutela |
||||
Un'annata, la 2022, che come avvenuto per le ultime cinque stagioni sarà amministrata attraverso misure di gestione dell'offerta in un quadro di riconfermata e sempre più ampia sinergia con le altre Denominazioni del Sistema Pinot Grigio del Nordest. Deliberata la misura precauzionale relativa alla diminuzione di resa e di uno stoccaggio amministrativo che, per la prossima stagione produttiva, viene tuttavia portata a 160 q/ha con 30 q/ha stoccati (si ricorda che lo scorso anno si raggiungevano 150 q/ha con 20 q/ha messi a stoccaggio). Dalla misura viene escluso il prodotto Biologico e viene altresì confermata la tracciatura delle produzioni sostenibili SQNPI per un'eventuale gestione diversificata, cercando di fare fronte a una lieve diminuzione dell'imbottigliato e in attesa di trovare soluzioni idonee alle problematiche che sono causa di questo rallentamento, legate in parte alla carenza di materie prime come il vetro bianco. In virtù dell'andamento di mercato, infatti, a marzo 2022 il Cda del Consorzio DOC delle Venezie aveva fatto richiesta di svincolo del prodotto stoccato atto a DOC delle Venezie proveniente dalla vendemmia 2021. Per analizzare alcuni numeri, al 1° settembre 2022 la Denominazione ha quasi toccato 1,1 milioni di hl imbottigliati con una flessione del 16% sul 2021. In termini temporali, si tratta di un rallentamento di circa 40 giorni su un anno che, tuttavia ricordiamo, registrava risultati straordinari grazie ad un giugno da fuori quota, di fatto migliorando sensibilmente la diminuzione della disponibilità in giacenza. Queste analisi sono tanto più significative poiché, da un confronto dei dati del Sistema Pinot Grigio, si evidenzia un rallentamento delle riclassificazioni a “delle Venezie” in favore di un trend positivo sugli imbottigliamenti delle altre principali Denominazioni, per le quali in molti casi si prospetta a fine anno un ampio risultato positivo sul precedente 2021. Rispetto alle giacenze, peraltro, il trend attuale potrebbe portare all'utilizzo di tutto il patrimonio oggi in disponibilità in tempi non troppo lunghi, favorendo un maggior valore al prodotto fresco in arrivo nei prossimi mesi. Non ultimo, già dal 2020 le principali DO del territorio – Garda, Grave, Friuli, Valdadige, Trentino, Vicenza, Venezia e Arcole – avevano iniziato un programma di condivisione della misura precedentemente messa in atto dal Consorzio delle Venezie per una gestione coordinata delle disponibilità attraverso quello che viene chiamato “blocco degli impianti” (di fatto viene sospesa l'idoneità a rivendicare le uve), portando alla comune richiesta di rinnovo per il prossimo triennio della sospensione alla rivendica di tutto il Pinot Grigio delle principali DO del Triveneto legate alla varietà (ovvero quelle sopraccitate) dei vigneti messi a dimora dopo il 31 luglio 2021. Con i suoi oltre 27mila ha di vigneto di cui 14 mila direttamente rivendicati, «la DOC delle Venezie, la più estesa a livello nazionale, rappresenta oggi una garanzia di stabilità per il sistema produttivo delle tre regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, è chiamata a gestire oltre al proprio potenziale anche i quantitativi riclassificati da parte delle altre DO territoriali, garantendo sia un importante equilibrio di Sistema delle DO del Triveneto a produzione di Pinot Grigio sia valore e accreditamento per la varietà prodotta nel nostro areale, non solo a DOC delle Venezie. Sarà fondamentale quindi continuare a lavorare congiuntamente per una politica ampia di programmazione della produzione con le denominazioni del Nordest e ad attivare misure straordinarie di gestione dell'offerta da immettere sul mercato, quali mitigazione delle rese, blocco degli impianti e stoccaggio amministrativo, che ci hanno permesso di raggiungere oggi importanti risultati» dichiara il Presidente del Consorzio di Tutela DOC delle Venezie Albino Armani. Un progetto importante, quello del coordinamento tra Denominazioni, che unitamente al lavoro di controllo costante delle informazioni relative a riclassificazioni, giacenze ed imbottigliamenti chiama il Consorzio delle Venezie ad essere il punto di equilibrio non solo del Pinot grigio ma anche di tante altre varietà del Nordest che compongono il “Bianco DOC delle Venezie”, importante punto di ricaduta per la pratica del taglio e non solo, ulteriore opportunità di valore per il Triveneto vitivinicolo. |
||||
Alessandro Nicodemi è il Nuovo Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo |
| Alessandro Nicodemi è il nuovo presidente eletto dal nuovo CDA del Consorzio
Tutela Vini d'Abruzzo. «Il mio primo ringraziamento è rivolto a tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami nel rivestire
questo importantissimo ruolo, specie in un momento storico molto delicato per
la nostra viticoltura regionale» afferma il presidente esponendosi anche su chi
lo ha preceduto «nel contempo e non come gesto dovuto, ma veramente sentito, il
mio ringraziamento è rivolto anche al presidente uscente Valentino Di Campli
che mi ha sostenuto nell'affrontare questo passo epocale ovvero il passaggio
della prima presidenza del consorzio dalla cooperazione ad un produttore di
un'azienda familiare. Questo nuovo incarico mi inorgoglisce, mi gratifica del
lavoro fatto in tutti questi anni, ma allo stesso tempo mi carica di una enorme
responsabilità, e spero di non deludere nessuno. Ci aspettano sfide importanti
che affronteremo con un percorso in cui il confronto, il dialogo e la
condivisione saranno valori imprescindibili atti a rendere il Consorzio ancora
più efficiente ed autorevole. Il mio impegno e quello di tutti i consiglieri
sarà totale ed indirizzato al raggiungimento di traguardi ambiziosi ma
realizzabili, volti a garantire alle nostre aziende la più ampia capacità
competitiva, un'adeguata redditività e la massima valorizzazione dei nostri
prodotti enologici» conclude Nicodemi. Classe 1972, una laurea in Economia e Commercio, un trascorso da Ufficiale di Complemento nella Guardia di Finanza, nel 1997, a seguito della prematura scomparsa del papà, Alessandro, coadiuvato dalla sorella Elena, entra a pieno titolo nella Fattoria Bruno Nicodemi, azienda di famiglia e fra le più storiche del panorama enologico abruzzese, presente con il proprio marchio sin dal 1977, anni pioneristici per il vino regionale in bottiglia. Già presidente per 15 anni del Consorzio Tutela vini Colline Teramane, Nicodemi ha ricoperto negli ultimi 6 anni il ruolo di vicepresidente del Consorzio Vini d'Abruzzo e nel 2011 insignito “Benemerito della vitivinicoltura italiana”, per aver arrecato un determinante contributo allo sviluppo della viticoltura e alla valorizzazione della enologia italiana, ricevendo la prestigiosa Medaglia del Cangrande. Oggi ricopre anche l'incarico di rappresentante regionale in seno alla Federazione Nazionale Prodotto Vitivinicoltura di Confagricoltura. Per la prima volta sarà dunque un produttore privato e non un esponente della cooperazione regionale a guidare il Consorzio, un cambio epocale che ha l'obiettivo di portare avanti i tanti progetti iniziati negli ultimi anni che sono riusciti ad accendere i riflettori sulla viticoltura abruzzese e ad affermare l'intero territorio come protagonista della viticoltura nazionale oltre che come tassello imprescindibile dell'economia agroalimentare abruzzese. Si procederà in ogni caso nel solco della continuità continuando a cogliere tutte le opportunità offerte dai bandi europei e dal Pnrr, portando a compimento il Modello Abruzzo con la riorganizzazione dei disciplinari di produzione e l'introduzione delle misure proposte per la regolamentazione del mercato; tutte azioni, insomma, finalizzate a tutelare e dare sempre più valore alle nostre denominazioni. Affiancheranno il presidente Nicodemi, con la carica di vicepresidente, Pino Candeloro (Sincarpa) e Franco D'Eusanio (Chiusa Grande) e gli altri membri del CDA che sono Giulia Cataldi Madonna (Cataldi Madonna), Rocco Cipollone (Masciarelli), Franco D'Eusanio (Chiusa Grande), Dino D'Ercole (San Nicola), Carlo Di Campli Finore (Vin.co), Nicola Dragani (Madonna dei Miracoli) Paolo Ulpiani (Zaccagnini), Luciano Di Labio (Villamagna), Pino Canderolo (Sincarpa), Chiara Ciavolich (Chiara Ciavolich), Fausto Cimini (Paglieta), Vincenzo Bucci (Olearia Vinicola Villese), Miki Antonucci (Progresso Agricolo) e Gennaro Matarazzo (Roxan). Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo è stato istituito nel 2002 con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) per svolgere funzioni di tutela, valorizzazione delle denominazioni delle DOC Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Abruzzo e Villamagna e delle IGT Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, raccoglie attualmente oltre 210 cantine socie. |
Magia ed Eleganza del Pinot Nero: l'Oltrepò Pavese si Svela |
| Il 13 ottobre alle ore 18:30, l'Istituto dei Ciechi di Milano accoglierà una
degustazione guidata organizzata dalla delegazione Lombardia dell'Associazione
Nazionale Le Donne del Vino, in collaborazione con ONAV Nazionale. Elemento centrale della serata sarà la degustazione di sei diverse espressioni di Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese. Il momento dell'assaggio sarà guidato da due produttrici socie che a questo vino hanno dedicato la propria vita e che, con grazia, accompagneranno i presenti in un viaggio polisensoriale che coinvolgerà anche l'udito. Ad accompagnare il momento della degustazione ci saranno le note dell'antico organo Balbiani Vegezzi-Bossi, suonate dal Maestro Compositore Francesco Ferrario. Importante novità dell'edizione di quest'anno sarà la presenza di un momento di confronto tra i partecipanti, durante il quale porre domande sull'esperienza appena vissuta, esprimere sensazioni, suggestioni e, perché no, anche emozioni in totale libertà. A conclusione della degustazione ci sarà un rinfresco pensato da Le Donne del Vino. L'edizione corrente, proprio come quella dello scorso anno, è fortemente voluta da Pia Donata Berlucchi, vicepresidentessa dell'ONAV e Donna del Vino, che con impegno e dedizione da sempre si spende in cause sociali come quella portata avanti dall'Istituto dei Ciechi di Milano. La serata ha infatti una finalità benefica, con il ricavato interamente devoluto alla mostra Dialogo nel Buio. Per informazioni e prenotazioni: info@ledonnedelvino.com, Tel. 02 867577 / 331 9104048 |
Piemonte Grappa: alla Corte dell'Alambicco |
| “Piemonte Grappa, alla Corte dell'Alambicco” è l'evento di punta del
Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, quello più
rappresentativo perché propone un incontro ravvicinato con il mondo degli
alambicchi che distillano la nostra grappa, all'interno delle dodici aziende
che quest'anno hanno aderito alla annuale manifestazione. La distilleria Beccaris a Boglietto di Costigliole d'Asti; le distillerie Berta a Mombaruzzo; la distilleria Dellavalle a Vigliano d'Asti; la distilleria Francoli a Ghemme; la distilleria Gualco a Silvano d'Orba; la distilleria Levi a Neive; la distilleria Magnoberta a Casale Monferrato, la distilleria Marolo ad Alba, la distilleria Mazzetti d'Altavilla ad Altavilla Monferrato, la distilleria Montanaro a Gallo d'Alba; la distilleria Revel-Chion a Chiaverano e la distilleria Sibona a Piobesi d'Alba. Ecco le distillerie piemontesi che domenica 2 ottobre apriranno le porte ai visitatori, proponendo i loro programmi per la giornata visibili sul sito www.consorziograppapiemontebarolo.it; ogni azienda rivolgerà agli ospiti il racconto della propria storia e delle proprie tradizioni attraverso visite guidate agli impianti di distillazione, che proprio in questo periodo sono in piena attività, oltre a offrire degustazioni dei tanti prodotti che caratterizzano il loro lavoro. Un appuntamento da non perdere, in un momento dell'anno significativo, cogliendo la disponibilità dei mastri distillatori e dei tanti collaboratori a occuparsi in modo speciale degli ospiti che vorranno entrare nell'affascinante mondo del “lambiccare” e della grappa, il distillato italiano di bandiera. Sul sito web sopra indicato si trovano gli orari di visita e tutte le informazioni necessarie; con le misure restrittive anti Covid ormai allentate la giornata sarà certamente più godibile, ponendo però attenzione anche alle prenotazioni, che in molti casi vengono richieste. |
AquavitaeRassegna di Grappe, Distillati e Acqueviti |
|
|
||||||||||||
Wine Guide ParadeGiugno 2022
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza | |||||||


| Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
| Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |